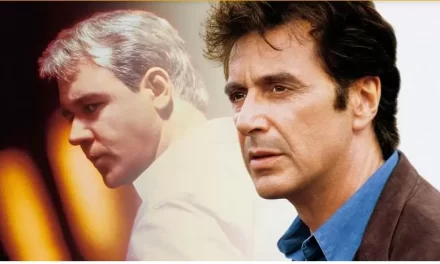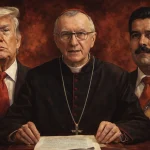L’idea che gli Stati Uniti d’America siano “una nazione unica” nel consesso delle nazioni non è nuova. È il cuore del cosiddetto eccezionalismo americano, un concetto ibrido a metà strada tra religione civile e mito politico, che ha attraversato secoli di storia statunitense sotto diverse forme: dal “Manifest Destiny” ottocentesco fino ai discorsi sul “leader del mondo libero” durante la Guerra Fredda, e oltre.
Ma che significato ha oggi questa pretesa di eccezionalità? E come si colloca, dal punto di vista evangelico e secondo la dottrina sociale della Chiesa, un’idea che troppo spesso ha giustificato interventi armati, dominio economico, disuguaglianze globali e indifferenza verso i poveri?
Una “città sulla collina”… per chi?
Il celebre sermone del puritano John Winthrop nel 1630 – “We shall be as a city upon a hill” – è stato più volte ripreso dai presidenti americani per evocare una vocazione quasi messianica degli USA nel mondo. Da Ronald Reagan fino a Barack Obama, e persino Donald Trump, questo linguaggio è stato usato per trasmettere l’idea che l’America fosse guida morale e faro di civiltà.
Eppure, la “città sulla collina” ha spesso proiettato ombre sui popoli posti ai suoi piedi: nativi americani spogliati delle loro terre, africani deportati e ridotti in schiavitù, interi Paesi invasi o destabilizzati in nome della libertà, dalla Palestina all’Iraq, dal Cile all’Afghanistan.
Come scrive Papa Francesco in Fratelli Tutti, «una nazione è grande quando difende la dignità dei più deboli e promuove l’inclusione dei dimenticati» (n. 190). L’eccezionalismo, quando si fa autogiustificazione imperiale, rischia di trasformarsi in un idolo nazionalista, che contraddice il Vangelo della fraternità universale.
Religione civile o vangelo universale?
Il sociologo Robert Bellah parlava di religione civile americana per indicare quell’insieme di simboli, miti e valori condivisi che attribuiscono al popolo americano un ruolo provvidenziale nella storia. Un fenomeno affascinante, ma anche ambivalente, perché sovrappone il piano teologico a quello geopolitico.
La dottrina sociale della Chiesa, invece, parte da un altro presupposto: la pari dignità di tutti i popoli, l’universalità dei diritti umani, il dovere della solidarietà internazionale. Come scriveva Giovanni Paolo II in Sollicitudo Rei Socialis, «la vera pace nasce dal riconoscimento dell’altro come fratello, non come satellite o pedina» (n. 39).
Questo vale ancora di più oggi, in un mondo interconnesso, dove la povertà strutturale, il colonialismo economico e i cambiamenti climatici colpiscono in modo diseguale. L’eccezionalismo, se non ripensato, rischia di diventare una teologia della disuguaglianza.
Una vocazione al servizio, non al dominio
Eppure, una via è possibile. Come mostrano esperienze come il Peace Corps, l’Alliance for Progress, la ricostruzione post-bellica europea, ci sono stati momenti in cui gli Stati Uniti hanno incarnato una forma di eccezionalismo costruttivo, fondato sul servizio, la cooperazione, la promozione della dignità umana. Il problema non è ritenere che una nazione abbia una missione; il problema è quando quella missione viene usata per dominare anziché servire.
Il teologo protestante Reinhold Niebuhr – spesso citato per la sua “teologia realista” – ricordava che ogni nazione tende ad assolvere sé stessa. «La moralità collettiva – scriveva – è più difficile di quella individuale, perché le nazioni si illudono di agire per il bene anche quando perseguitano i più deboli» (The Irony of American History, 1952).
Per una critica cristiana dell’imperialismo morale
Il Vangelo ci insegna che la grandezza si misura nel servizio: “Chi vuole essere il primo, si faccia servo di tutti” (Mc 10,44). Anche una potenza globale come gli Stati Uniti può incarnare questa logica, ma solo se abbandona la retorica dell’eccezione per abbracciare quella della responsabilità solidale.
La Chiesa, dal canto suo, deve avere il coraggio di dire parole chiare: non basta benedire le bandiere. Occorre denunciare ogni forma di ideologia che sacralizza il potere e riduce Dio a sponsor dell’Occidente. Come ha scritto Papa Francesco: «Non possiamo pretendere di appartenere alla Chiesa se eleviamo barriere tra popoli e coltiviamo disprezzo verso le nazioni più deboli» (Fratelli Tutti, n. 97).
Anche Benedetto XVI, nella sua enciclica Caritas in veritate, ammoniva: «Nel mondo globalizzato, il bene comune e la giustizia non possono più essere pensati nei termini del solo Stato-nazione» (n. 42). E Giovanni XXIII già nel 1963 affermava con forza in Pacem in Terris che «ogni essere umano ha il diritto alla vita, all’integrità fisica, ai mezzi necessari per un degno tenore di vita», indipendentemente dalla cittadinanza.
Leone XIV e il sogno di Martí
In questo quadro, l’elezione di Leone XIV, primo papa statunitense, assume un valore fortemente simbolico e, per certi versi, provocatorio. In un tempo di decadenza imperiale e nuove spinte autocratiche, un Papa che viene dal cuore dell’Impero ha scelto il nome della pace e della giustizia sociale, evocando Leone XIII – padre della dottrina sociale della Chiesa – e rilanciando un’idea non imperiale ma servizievole dell’identità americana.
Leone XIV, con il suo magistero aperto ai Sud del mondo, sembra voler rivitalizzare il sogno di José Martí: la visione di una Nuestra América indipendente, plurale, solidale, non più serva del Nord coloniale ma liberata da ogni eccezionalismo narcisista.
Martí scriveva nel 1891: «Nuestra América ha da mostrarse tal quale è, e portare in fronte non un pensiero preso in prestito, ma il proprio pensiero» (Nuestra América). Questa sfida è oggi più attuale che mai, anche per l’America del Nord. Il primo papa americano può aiutare a riscoprire un’America capace di mettersi al servizio di un mondo multipolare, riconciliato, fraterno.
Essere luce, non faro
Un’America che vuole davvero essere una “luce per le nazioni” deve imparare a non abbagliare. Il mondo non ha bisogno di egemonie morali, ma di alleanze solidali. Non di un nuovo impero, ma di compagni di strada capaci di portare il peso della storia comune.
La grandezza degli Stati Uniti non sarà misurata da quanto controllo esercitano sul mondo, ma da quanto bene sapranno fare senza aspettarsi nulla in cambio. In questo, forse, potranno riscoprire la parte più autentica della loro vocazione.