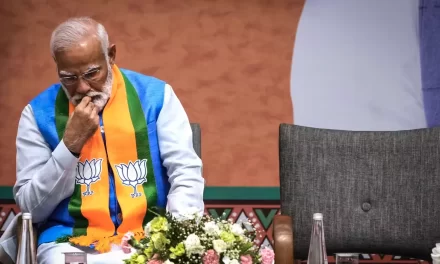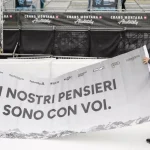Nel Donbass la guerra non ha più linee ma pulsazioni: droni che ronzano a bassa quota, fanterie che si muovono nella notte, città ridotte a snodi di fango e rottami. Lyman, Pokrovsk, Kupyansk: nomi che cambiano colore ogni settimana su mappe ormai senza confini. È il fronte dei cento metri, dove Mosca avanza metro dopo metro e Kiev resiste con la forza dei sensori e della fame. Ma dietro le immagini dei quadricotteri esplosivi c’è un’altra battaglia, invisibile e disumana: quella che addestra i bambini dei territori occupati a diventare soldati, trasformando il futuro stesso in carne da guerra.
Il Donbass non è più una linea del fronte: è una zona grigia sconfinata dove il controllo è un concetto provvisorio, variabile come il meteo e la batteria di un quadricottero. In questi giorni le avanguardie russe sono ricomparse ai margini di Lyman, decine di chilometri dietro la fascia di contatto, sfruttando il grande parco naturale a nord: tra alberi fitti e ombre lunghe i droni vedono peggio, e la fanteria si muove di notte, leggera, con solo armi e caricatori; acqua e cibo arrivano dall’alto, appesi ai rotori. È la logistica “a bassa quota” di una guerra che si vince (o si perde) tra i 100 e i 300 metri dal suolo, dove sciami di elicotterini e aeromodelli telecomandati sostituiscono l’aviazione tradizionale e ribaltano tattiche e geografia.
Da mesi Pokrovsk è il nome che torna come un ritornello amaro: città-cerniera, nodo di strade e rifornimenti, assaltata a ondate. Incursori e gruppi corazzati sbucano all’improvviso, spesso schermati da carapaci anti-drone – gabbie, lamiere, aste d’acciaio che trasformano i tank in testuggini e costringono gli ucraini a consumare dieci, dodici FPV per fermarne uno. A tratti gli incursori riescono a infiltrarsi dentro l’area urbana: Kiev ne respinge una parte, ma la pressione resta altissima e il quadro operativo oscilla di settimana in settimana. In superficie le due propagande sovraccaricano il segnale; sul terreno restano macerie e batterie scariche.
Tutto ruota ai droni, ma non solo: quando arriva la pioggia – e lunedì è attesa – i rotori si bagnano, le termiche ingannano, i collegamenti si interrompono. È il momento che Mosca prova a sfruttare per spingere avanti riserve corazzate e cingolati porta-fanti, esibendo bandiere su porzioni di terreno il più vaste possibile prima che torni il cielo secco e la rete ucraina riprenda quota. Gli analisti militari da mesi descrivono questo pendolo: EW e antidrone cinetici non bastano, l’industria russa ha migliorato autonomia, resistenza al jamming e addestramento degli operatori; il risultato è un campo di battaglia interamente “sensorizzato”, dove l’effetto sorpresa dura minuti e l’inerzia logistica decide più del genio tattico.
Intanto il cielo alto continua a colpire il retrofronte civile. Nella notte su Kyiv missili e droni hanno ucciso e ferito civili, incendiando case, un asilo, infrastrutture energetiche: il governo denuncia l’ennesimo passo verso una catastrofe umanitaria invernale. È la strategia della pressione lunga: sfiancare reti elettriche, riscaldamento, trasporti, finché la resilienza domestica incrina quella militare. La risposta ucraina chiede più difese aeree a lungo raggio – Patriot, soprattutto – perché ogni batteria salva vite e, con esse, la capacità di stare al fronte.
Nel mezzo, un paradosso morale che pesa come piombo: la militarizzazione forzata dell’infanzia nei territori occupati. Un’inchiesta del Kyiv Independent documenta programmi statali russi che addestrano minorenni di Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk e Donetsk all’uso delle armi, dei droni, persino allo sminamento; campi chiamati “Tempo degli Eroi”, ufficiali di guerra come istruttori, un budget dedicato e la retorica patriottica a fare da cornice. È la guerra che si autoalimenta, preparando la prossima generazione alla normalità del fucile. In un conflitto dove già si combatte con adolescenti nei team FPV, è un segnale che dovrebbe scuotere più di un’aula diplomatica.
Eppure, tra i titoli del giorno, si intravede anche il tentativo di risalire: l’intesa annunciata da Zelensky sui Gripen svedesi – “fino a 150”, prime consegne l’anno prossimo – è ambiziosa e da verificare nella sua effettiva scalabilità industriale, ma dice una cosa chiara: senza un salto di qualità nell’aria (e nella contro-UAV), il Donbass resterà il laboratorio del secolo, dove chi domina i sensori a bassa quota detta i tempi della terra.
Cosa resta, allora, in questa lotta senza confini? Tre verità scomode. La prima: non c’è “sfondamento” risolutivo all’orizzonte, ma un’usura spietata in cui contano produzione, manutenzione, addestramento e meteo – più che le mappe colorate. La seconda: la distinzione tra fronte e retrofronte si assottiglia fino a sparire, e ogni kilowattora vale quanto un plotone. La terza: una democrazia si difende anche evitando che l’inverno diventi un’arma di massa.
Se vogliamo che l’Europa resti uno spazio politico e non una periferia di guerra, bisogna avere il coraggio di dirlo: questa partita si gioca a tre livelli – aria bassa, cielo alto, civili – e si vince solo se si reggono tutti e tre. Droni e jammer, sì; Patriot e generatori, sì; ma anche corridoi umanitari d’inverno, scuole che riaprono, bambini che restano bambini. Altrimenti il Donbass sarà davvero la nostra nuova normalità: una foresta dove si sopravvive di notte e, di giorno, si impara a non credere più a nessuno.