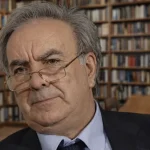Nell’opera Nous di Luciano Vasapollo, scritta con Rita Martufi e Mirella Madafferi, emerge una riflessione radicale e necessaria sul ruolo della scienza, del sapere e della prassi nella trasformazione della società. Vasapollo propone un metodo di pensiero critico che si colloca all’incrocio tra filosofia della liberazione, critica all’economia dominante e lotta per l’autodeterminazione dei popoli. Eppure, per quanto radicata in una matrice marxista, questa visione offre molteplici punti di convergenza con la Dottrina Sociale della Chiesa, soprattutto in ciò che riguarda il rispetto per la dignità della persona, la giustizia economica e la custodia del creato.
L’opera Dialettica della Natura, alla quale Vasapollo frequentemente fa riferimento, attribuisce alla realtà una logica dinamica e interconnessa. Tutto è in relazione, tutto è in trasformazione. Le tre leggi fondamentali della dialettica (trasformazione della quantità in qualità, compenetrazione degli opposti, e negazione della negazione) rivelano che il mondo, la natura e la società non sono realtà fisse, ma processi in divenire. Anche la Dottrina Sociale cattolica afferma che l’uomo è chiamato a essere co-creatore, in un mondo che Dio ha affidato alla sua responsabilità. Come ha ricordato Papa Francesco nella Laudato si’, “tutto è connesso”: la cura per l’ambiente, la giustizia verso i poveri e la riforma dei modelli economici non sono sfere separate, ma un’unica questione morale.
Nel testo si osserva come l’essere umano, attraverso il pensiero, sia in grado di intervenire e modificare la realtà naturale. Ma questa potenza intellettuale può degenerare in dominio, se priva di orientamento etico. Il capitalismo, denuncia Vasapollo, si è evoluto in un “Profit-State”, uno Stato-impresa dove la logica del mercato ha colonizzato la politica, la cultura e perfino la natura. La globalizzazione finanziaria ha creato nuove forme di sfruttamento che la Chiesa definisce con precisione “nuove schiavitù”. L’essere umano viene ridotto a fattore produttivo, il lavoratore è sorvegliato e schedato, e l’intelligenza artificiale è spesso utilizzata per rafforzare il controllo e l’ineguaglianza. Anche il Magistero cattolico mette in guardia da queste derive: in Caritas in veritate, Benedetto XVI parlava di un’economia disumana quando viene disconosciuto il primato dell’uomo sul capitale.
Un altro nodo centrale dell’analisi di Nous è la contraddizione tra capitale e natura. Vasapollo denuncia con forza come il modello produttivo dominante sacrifichi il pianeta alla logica del profitto, mercificando le risorse naturali come l’acqua, le foreste e persino l’aria. È la stessa diagnosi offerta da Papa Francesco: “La crisi ecologica è un sintomo della crisi etica, culturale e spirituale della modernità”. Ecco allora che l’ambientalismo sociale, come lo definisce Vasapollo, non è un tema tecnico, ma profondamente umano e spirituale: custodire la terra significa custodire la vita, e il bene comune.
Il testo propone un’alternativa: un modello multicentrico, decoloniale, eco-sociale, ispirato all’esperienza di Cuba e alla filosofia del “Vivir Bien” andino. Un modello che ricorda in modo sorprendente il principio cattolico della destinazione universale dei beni, secondo cui ogni proprietà privata deve avere una funzione sociale e orientarsi al bene comune. È questa la vera rivoluzione auspicata da Nous: una trasformazione integrale che coinvolga coscienze, culture, istituzioni e popoli.
La “dialettica della natura” – letta con attenzione cristiana – può aiutarci a comprendere che la scienza, la tecnica e l’economia non sono neutre: dipendono dal fine a cui sono orientate. Non è la conoscenza in sé a essere salvifica, ma l’uso che se ne fa per servire la giustizia, la pace e la dignità di ogni persona. Quando il sapere diventa merce e la cultura viene asservita al profitto, ci allontaniamo dalla vocazione più alta dell’umanità: amare, costruire, liberare.
La Dottrina Sociale della Chiesa ci invita allora a non cedere alla falsa neutralità dell’economia e della tecnologia. Ci chiede di smascherare il “feticismo” del mercato, come lo chiamava Marx e come la Chiesa preferisce chiamare “idolatria del denaro”, e di riscoprire una gerarchia di valori fondata sulla solidarietà, sulla partecipazione, sulla responsabilità verso i più deboli.
Nel solco tracciato da Nous, anche un economista cristiano può trovare spunti profondi per elaborare una visione alternativa al sistema neoliberista dominante. Una visione che non rinneghi la razionalità scientifica, ma che la incardini in una razionalità più grande: quella dell’amore sociale e della giustizia. Perché, come ricorda Papa Francesco in Fratelli tutti, «il mercato da solo non risolve tutto, benché a volte vogliano farci credere questo dogma della fede neoliberale».
È tempo di ricostruire una cultura economica nuova, ancorata alla realtà e orientata al bene. Ed è tempo che i cristiani, anche attraverso la lettura critica di opere come Nous, partecipino a questa rigenerazione, sapendo che “un’altra economia è possibile” solo se è al servizio dell’uomo e del creato.