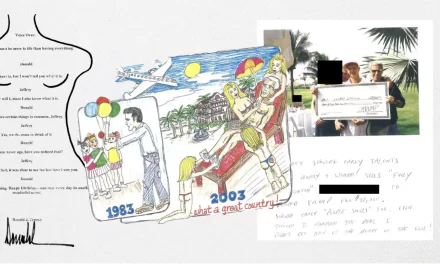Il Governo italiano accoglie con realismo l’intesa transatlantica, ma dietro il compromesso si celano svantaggi per l’industria, l’energia e la sovranità economica nazionale
L’accordo raggiunto tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi è stato presentato come un successo diplomatico che ha evitato lo scenario di una guerra commerciale tra partner storici. Tuttavia, per l’Italia — tra i Paesi europei più esposti — l’intesa rischia di avere costi rilevanti, sia sul piano industriale che su quello energetico e strategico.
Un dazio del 15% che pesa sull’export italiano
Il dazio negoziato al 15% sui prodotti coinvolti è, come ha riconosciuto lo stesso Governo, “sostenibile” solo se non si aggiunge ai dazi preesistenti. Ma anche nella migliore delle ipotesi, questa soglia rappresenta un aggravio per molte imprese italiane, in particolare nei settori manifatturieri a medio valore aggiunto — come meccanica, agroalimentare, arredamento e moda — che dipendono fortemente dall’export e che già scontano i costi energetici più alti d’Europa.
Per l’Italia, terzo esportatore europeo verso gli Stati Uniti, le nuove tariffe possono significare un rallentamento competitivo in settori trainanti del “Made in Italy”. La piccola e media impresa, cuore produttivo del Paese, sarà tra le prime a sentire gli effetti di una politica commerciale sbilanciata che, pur scongiurando lo scontro, impone condizioni asimmetriche.
Energia più cara e dipendenza strategica
Uno degli aspetti più critici dell’accordo è il rafforzamento della dipendenza energetica dell’Europa — e quindi dell’Italia — dagli Stati Uniti. Dopo il blocco delle forniture russe, Roma è stata costretta a riconvertire le proprie fonti di approvvigionamento verso il gas naturale liquefatto (LNG) americano, più costoso e vincolato da contratti a lungo termine.
Il mix energetico nazionale, già sotto pressione, subisce così un ulteriore appesantimento, con conseguenze su bollette, costi industriali e competitività. A ciò si aggiunge l’incremento degli acquisti di armamenti statunitensi, resi di fatto obbligati in un contesto geopolitico sempre più condizionato dalla guerra in Ucraina e dalle spinte al riarmo.
L’Italia, dunque, si trova a dover pagare di più sia per l’energia che per la difesa, in cambio di un “equilibrio” che sembra favorire soprattutto Washington.
Sovranità commerciale limitata
Il Governo italiano — con Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini in una nota congiunta — ha espresso apprezzamento per l’intesa, pur sottolineando l’importanza di «rafforzare il Mercato Unico», «diversificare le relazioni commerciali» e «ridurre le dipendenze». È una posizione pragmatica, che mostra la consapevolezza dei limiti dell’accordo.
Ma al tempo stesso, rivela come l’Italia sia costretta a muoversi in un quadro europeo che non ha saputo difendere in modo incisivo gli interessi industriali del Sud Europa, sacrificati in nome della coesione atlantica. Il peso contrattuale di Parigi e Berlino, i cui settori strategici sono stati in parte tutelati, ha lasciato scoperti molti comparti italiani.
Aiuti europei insufficienti, misure nazionali da attivare
Il Governo ha chiesto che l’UE predisponga misure di sostegno per i settori colpiti dalle tariffe, ma resta incerto l’ammontare e la rapidità di questi interventi. Intanto, Roma si dichiara pronta ad agire sul piano nazionale, ma con spazi fiscali limitati e una manovra di bilancio alle porte, l’efficacia di tali aiuti è tutta da verificare.
L’accordo UE-USA, pur evitando un conflitto commerciale diretto, mette l’Italia davanti a una nuova stagione di vulnerabilità. L’interesse strategico nazionale richiederebbe ora una doppia azione: difendere i settori esposti agli effetti dell’intesa, e rilanciare in Europa una voce autorevole per una politica commerciale meno subalterna.
Più che un trionfo, l’intesa sui dazi si presenta per l’Italia come un compromesso fragile, che rinvia i problemi senza risolverli. L’unità dell’Occidente, più volte invocata, si consolida solo se equilibrata. In caso contrario, rischia di tradursi in una subordinazione che il sistema produttivo italiano — già messo alla prova da pandemia, inflazione e guerra — non può più permettersi.