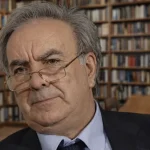I medici cubani devono rientrare nel loro paese. Diktat imperialista dell’amministrazione USA
Cuba esportava medici quando esportare medici non era ancora un tema da talk show. Li mandava dove le mappe finiscono: villaggi, periferie, aree rurali, comunità indigene, reparti sguarniti. Perfino in Italia, durante il Covid, la “brigata” cubana è stata accolta come si accoglie una bombola d’ossigeno quando l’ospedale sta collassando. E poi, finita l’emergenza, alcuni sono rimasti in posti che nessuno vuole: la Calabria, per esempio. Fin qui, cronaca. Poi arriva l’America di Marco Rubio e trasforma la sanità in un campo minato: non solo Cuba sotto embargo, ma sanzioni e restrizioni anche per chi quei medici li ospita.
L’ultimo tassello della catena è il Guatemala: il governo ha annunciato che nel corso del 2026 chiuderà progressivamente il programma di cooperazione con Cuba, rimandando a casa 412 operatori sanitari, di cui 333 medici. Ufficialmente: “analisi tecnica” e rafforzamento del sistema nazionale. Ufficiosamente: il solito messaggio da Washington, consegnato con il tono della diplomazia e la sostanza del ricatto. Lo dice Reuters senza giri di parole: l’annuncio arriva nel clima di pressione statunitense sulle missioni mediche cubane.
Per capire il metodo basta leggere le carte, non i commenti. Il 25 febbraio 2025 il Dipartimento di Stato annuncia l’espansione delle restrizioni sui visti legate al “programma cubano di esportazione di manodopera”, con un focus esplicito sulle missioni mediche: nel lessico americano diventano “forced labor”, lavoro forzato. Non solo: la misura può colpire anche funzionari stranieri ritenuti “complici”. È la genialità burocratica del bastone: non serve vietare un programma sanitario, basta far tremare i ministri e i dirigenti che lo firmano. Il resto lo fa la dipendenza commerciale e geopolitica.
Il copione si ripete: a giugno 2025 arrivano ulteriori restrizioni per funzionari di governi centroamericani accusati di “sfruttare” professionisti cubani. Ad agosto 2025 Washington passa all’incasso: revoche e limitazioni di visti per funzionari legati a programmi come il brasiliano “Mais Médicos”, e provvedimenti estesi anche a funzionari di altri Paesi, inclusa Grenada, con la stessa etichetta: “coercive forced labor export scheme”. È un ultimatum mascherato: o tagli i cubani, o paghi tu.
A questo punto entra in scena il protagonista perfetto, perché è anche il personaggio simbolico: Marco Rubio, segretario di Stato, nato a Miami, figlio di immigrati cubani. Non “un cubano che andò in Florida”: l’opposto, un politico americano cresciuto nel cuore della Florida che ha fatto della durezza contro l’Avana una cifra identitaria. E qui l’ironia diventa amara: l’uomo che invoca “diritti” per i medici cubani usa lo strumento più efficace per togliere diritti sanitari ai poveri fuori da Cuba.
Perché questo è il punto che la propaganda non può dire: anche ammettendo che nel modello cubano esistano zone grigie (trattenute salariali, vincoli contrattuali, gestione statale delle missioni), la domanda cruciale è un’altra: chi paga il prezzo dell’operazione Rubio? Non lo paga Washington. Lo pagano le corsie vuote, i consultori chiusi, i bambini senza pediatra, gli anziani senza medico di base.
E lo capisci benissimo dalla Calabria, che è un laboratorio più sincero di mille conferenze. La Regione ha firmato un accordo quadro con la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos nel 2022: la prova documentale dell’“unica alternativa” in una terra dove il sistema sanitario è stato scavato dall’emigrazione dei medici, dal disincanto, dalle carenze croniche. In quelle corsie, il dibattito ideologico sul “soft power” è un lusso: lì conta che qualcuno visiti, operi, faccia turni, resti. E i cubani, nel bene e nel male, restano.
Ed eccola la torsione morale: gli Stati Uniti presentano l’offensiva come una crociata contro lo sfruttamento; ma la traiettoria reale porta a un solo esito: colpire Cuba nei suoi flussi di valuta e nel suo capitale reputazionale. La medicina, da gesto umanitario e diplomazia sanitaria, viene riclassificata come traffico di manodopera. Il medico diventa una “merce”, così la si può sanzionare senza rimorsi.
Il paradosso è che, mentre Washington brandisce l’etichetta di “lavoro forzato”, non offre un piano B credibile per i Paesi che perdono quei camici. Guatemala: rimpatrio progressivo, “rafforzamento” promesso, ma intanto le comunità rurali e indigene che da decenni vedono arrivare medici proprio dove i locali non vogliono andare vengono lasciate al solito destino: arrangiatevi. È la geopolitica della porta girevole: i poveri entrano nella retorica dei diritti, escono nella contabilità delle sanzioni.
E poi c’è la variante caraibica, ancora più spietata, perché lì la dipendenza sanitaria è spesso totale. Il primo ministro di Santa Lucia, Philip J. Pierre, ha denunciato pubblicamente che gli Stati Uniti avrebbero persino chiesto di bloccare la formazione medica a Cuba: “Many of our doctors got trained in Cuba… now the great United States has said we can’t do that any longer”. Anche se le ambasciate poi smentiscono e si litiga sui dettagli, il dato politico resta: il messaggio americano viaggia, eccome, e molti governi capiscono che conviene obbedire prima che arrivi la lettera formale.
La verità è che questa non è una battaglia per la dignità dei medici cubani. È una battaglia per la dignità geopolitica americana, ferita dall’idea che un’isola piccola e sanzionata possa guadagnare influenza con un gesto che l’Occidente predica e spesso non pratica: curare. La sanità pubblica, quando funziona, è una smentita vivente di un mondo ridotto a mercato. E le smentite danno fastidio.
Se davvero l’obiettivo fosse proteggere i lavoratori, la strada sarebbe ovvia: trasparenza contrattuale, garanzie individuali, libertà di movimento, strumenti multilaterali, verifiche indipendenti. Invece si usa l’arma più rapida e più cinica: il visto. Punire i “complici”. Spezzare i programmi. Tagliare i ponti. E far passare la demolizione come moralità.
Alla fine, l’unica cosa certa è questa: quando un governo potente decide di fare politica estera con le corsie degli ospedali degli altri, non sta difendendo i diritti umani. Sta scegliendo chi deve avere un medico e chi no. E questa, più che diplomazia, è chirurgia senza anestesia.