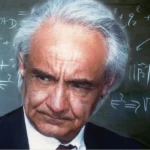Intervista del nostro direttore Alfonso Bruno al prof. Luciano Vasapollo, professore di economia a Roma e in alcune Università dell’America del Sud.
Roma, pioggia fitta. I sanpietrini davanti alla redazione di Mediafighter riflettono le luci come una pellicola consumata. Il professore arriva con passo svelto, l’impermeabile segnato da gocce minute, lo sguardo già altrove: in quei luoghi dove la geopolitica non è un gioco di mappe, ma il respiro o l’affanno di un popolo. Ci sediamo. Il registratore si accende. Fuori, la città rumoreggia piano; dentro, le parole cercano una forma che non sia propaganda né lamento, ma giudizio a un mese dal rapimento manu militari di Maduro in Venezuela.
Professore, partiamo da un mese che non somiglia agli altri: gennaio 2026. L’operazione che ha violato la sovranità venezuelana, la deportazione del presidente Maduro e della consorte, più di cento vittime. Lei che nome darebbe a quel mese?
Lo chiamerei un mese-soglia. Ci sono mesi che passano e mesi che restano come cicatrice nella storia. Gennaio 2026 è una cicatrice perché segna l’idea — terribile nella sua semplicità — che un capo di Stato possa essere “prelevato” come un pacco. Non è soltanto un fatto politico: è una pedagogia del dominio. Dice al mondo: la forza vale più del diritto. E quando la forza diventa grammatica, il resto è subordinato: i corpi, le istituzioni, perfino la verità.
Molti, qui da noi, hanno ascoltato le parole-chiave: “antidroga”, “criminalità”, “cartello”. È la cornice che giustifica?
È la cornice che rende digeribile l’indigeribile. Si prende un Paese e lo si riduce a un’etichetta. È un meccanismo antico: prima si costruisce il mostro, poi si invoca la necessità. La cosa più inquietante è che queste narrazioni cambiano con facilità, come accadde per le “armi di distruzione di massa” in Iraq: prima assolute, poi evaporate. E intanto resta il danno, restano i morti, resta la destabilizzazione. La storia, quando non è studiata, torna sempre come inganno.
Il suo sguardo torna sempre alla parola sovranità. Perché, oggi, è così scomoda?
Perché la sovranità è la parola che impedisce l’arbitrio. È un limite. E l’epoca che stiamo vivendo è un’epoca che detesta i limiti. Si può discutere di Maduro, del socialismo, della rivoluzione bolivariana: questo fa parte del pluralismo. Ma se si accetta che l’autodeterminazione di un popolo sia revocabile dall’esterno, allora nessuno è al sicuro. Oggi tocca al Venezuela, domani a chiunque osi essere “diverso” dai canoni del profitto e delle alleanze.
Lei dice: “si può essere d’accordo o no”, ma “va rispettato il popolo”. In concreto: qual è la priorità?
La priorità è semplice, anche se sembra scandalosa: lasciare il Venezuela in pace. Significa cessare la guerra economica, finanziaria, commerciale; smettere di trasformare un’intera popolazione in ostaggio di sanzioni e ricatti. E significa riportare la politica a ciò che deve essere: confronto interno, decisione nazionale, diritto internazionale. Chi ama la democrazia dovrebbe partire da qui: dalla regola che vale per tutti.
Lei ha insistito sul tema della “menzogna” che domina il mondo. Non è una parola troppo forte?
È una parola necessaria. Perché viviamo in un mondo dove la verità è spesso un dispositivo: si accende, si spegne, si modella. Sul Venezuela è accaduto per anni: si ripete “non si vota”, “non ci sono elezioni libere”, “è una dittatura”, come se fosse un ritornello inevitabile. Poi, quando arrivano osservatori o si verificano passaggi istituzionali, la complessità sparisce. Resta l’etichetta. La menzogna, oggi, è utile al profitto: mantiene lo scontro Nord-Sud e giustifica nuove forme di strozzinaggio.
E infatti lei chiama in causa Fondo Monetario, Banca Mondiale, grandi organismi. È ancora un tema attuale?
È il tema. Il capitalismo contemporaneo non si regge solo sulle fabbriche: si regge su debito, condizionalità, privatizzazioni imposte, discipline di bilancio che diventano disciplina sociale. Lo strozzinaggio non è un insulto, è una descrizione. E quando un Paese prova a sottrarsi — redistribuendo ricchezza, investendo nel sociale, costruendo un’alternativa — viene punito: isolamento, sanzioni, delegittimazione. È un manuale, non un incidente.
Lei cita spesso i risultati sociali: case popolari, occupazione, redistribuzione. Alcuni dicono: propaganda.
La propaganda la fa chi cancella i dati e la realtà concreta. Io ho visto — e non da turista — quartieri popolari costruiti, servizi attivati, politiche sociali che hanno dato dignità a chi era escluso. Non parlo di paradiso: il paradiso in terra non esiste. Ma parlo di un criterio: misurare l’economia dal basso, da ciò che cambia nella vita delle persone. Se un modello redistributivo ha difetti, lo si corregge; non lo si bombarda, non lo si strangola.
Eppure resta il nodo strutturale: dipendenza dal petrolio. Come se ne esce?
Con la diversificazione produttiva: industria, agricoltura, cooperazione, imprese pubbliche e private, ricerca, infrastrutture. Ridurre l’importazione e rafforzare lo “scheletro” produttivo. Ma è una scommessa dura, soprattutto se dall’esterno ti impediscono di respirare. È come chiedere a un atleta di correre con un peso al collo e poi dire che è incapace. Prima si rimuove il peso: sanzioni e sabotaggio.
Nel suo discorso torna spesso una geografia più ampia: Brasile, India, Sudafrica, Turchia, Vietnam… Che cosa cambia?
Cambia che il mondo non è più un monologo. C’è un multipolarismo in costruzione: potenze regionali, Paesi che vogliono dire la loro, soprattutto nel Sud globale e in Africa. Questo non è automaticamente “buono”, ma apre spazi: cooperazione, alternative, nuove rotte. Il problema è che le potenze dominanti reagiscono spesso con l’istinto del controllo. E quando non controllano, puniscono.
Lei ha pronunciato parole forti: “mi accusano di essere fiancheggiatore del terrorismo perché sono amico di Maduro”. Come vive questa criminalizzazione?
La vivo come un segno dei tempi. Quando mancano argomenti, si passa alle etichette: estremista, fiancheggiatore, terrorista. Ma io rivendico una cosa: la coerenza. Stare dalla parte dei popoli che rivendicano autodeterminazione non è estremismo; è una scelta politica e umana. Estremismo è normalizzare la guerra economica quotidiana, la militarizzazione, il sangue come strumento di governo.
Che cosa direbbe a un lettore che non ha simpatia per Maduro e che però è turbato da ciò che è accaduto?
Gli direi: non ti chiedo simpatia, ti chiedo principio. Se accetti che una potenza possa violare uno Stato e deportare un presidente, allora stai accettando che il diritto sia una decorazione. O quel principio vale sempre, oppure non vale mai. La democrazia, se è vera, comincia quando difendi anche il diritto di chi non ti piace.
Ultima domanda. In questa pioggia romana che sembra lavare e non pulire, che parola resta dopo gennaio 2026?
Resta una parola semplice e difficile: pace. Non come poesia, ma come pratica politica. Pace significa giustizia sociale, rispetto dei popoli, fine dello strozzinaggio, cooperazione. Pace significa interrompere l’idea che la violenza sia una scorciatoia legittima. Se vogliamo un futuro più equilibrato, più giusto, di uomini liberi, dobbiamo scegliere: o il mondo governato dalla paura e dal profitto, o il mondo costruito sulla dignità. Io non ho dubbi da che parte stare.