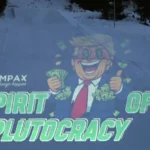C’è un dettaglio, nei disordini di Torino, che non riguarda né la politica né la polizia, ma il tempo. Il tempo di un’inquadratura. Il tempo di un video. Il tempo di un titolo. È in quel tempo minimo che una manifestazione cambia natura: da corteo a sommossa, da piazza a prova generale d’emergenza. E nel nostro presente – dove la realtà viene consumata in sequenze da trenta secondi – quel cambio di natura è quasi istantaneo.
Li vedono arrivare: vestiti di nero, a volto coperto, entrano nel corteo e vanno davanti. Non serve un’epica clandestina: basta la logica del corteo stesso. Chi sta davanti “fa” la scena. Chi sta davanti detta l’immagine. E l’immagine, oggi, non è un riflesso: è un’arma. L’incappucciato lo sa e lo sfrutta; la politica lo sa e lo sfrutta. In mezzo rimangono gli altri: i manifestanti che non sono lì per lo scontro, i cittadini che guardano, gli agenti che reggono l’urto, e un’intera città che si ritrova raccontata come campo di battaglia.
Il punto più scivoloso è sempre lo stesso: chi erano? “Black bloc”, si dice. “Infiltrati”, si suggerisce. “Violenti tra pacifici”, si ripete. Ma queste formule spesso servono più a placare l’ansia che a capire. È vero: in alcuni casi, nella storia delle piazze europee, la provocazione c’è stata, e perfino la presenza di agenti sotto copertura non è una fantasia. Però l’idea di un grande piano organizzato — la regia unica, la centrale internazionale, la strategia scientifica per “indirizzare” ogni protesta — quasi sempre è un racconto troppo ordinato per essere vero. La realtà di solito è più rozza: piccoli gruppi che praticano lo scontro come stile, che cercano il caos come linguaggio, e che contano su una cosa elementare e potente: la facilità con cui, attorno a loro, si agglutinano gli “utili idioti”.
“Utili idioti” non è un insulto morale: è una categoria sociale. Sono quelli che si fanno trascinare, che scambiano l’adrenalina per coraggio, che credono di “fare la storia” spaccando un vetro o rispondendo alla carica con il gesto che farà il giro dei social. E sono decisivi, perché un gruppo di facinorosi, da solo, produce rumore; con una corona di imitatori produce massa critica. In quel punto la manifestazione perde il controllo di sé. E quando una piazza perde il controllo, la piazza smette di essere politica e diventa materiale amministrativo: ordine pubblico, referti, numeri, dossier.
Askatasuna, a Torino, è un simbolo che polarizza da anni: per alcuni è un pezzo di città che ha dato spazi e servizi dove non c’erano; per altri è un nodo di illegalità e antagonismo permanente. Su questo conflitto – reale, lungo, intricato – si innestano i minuti del caos. Ed è qui che il disordine diventa “utile”: non nel senso di una cabina di regia, ma nel senso che produce vantaggi immediati a chi deve governare con parole semplici.
Perché dopo Torino la dinamica è prevedibile: “basta buonismo”, “tolleranza zero”, “servono strumenti”, “non possiamo aspettare”. La politica della sicurezza vive di questo: un episodio violento funziona come accelerante. In una stagione già tesa, basta una notte e cambia il clima. Il governo si ritrova tra le mani l’argomento migliore: non un ragionamento, ma una scena. E sulle scene si costruiscono decreti, pacchetti sicurezza, strette preventive, nuove fattispecie, nuove corsie procedurali. Non è un complotto: è il modo normale in cui la paura diventa norma.
Il paradosso è che, spesso, i facinorosi ottengono ciò che cercano – la rottura, lo scontro, la prova di forza – e il governo ottiene ciò che cerca – il consenso per irrigidire. Il prezzo lo pagano gli altri: chi manifestava senza voler la guerriglia; chi avrebbe voluto che si parlasse del merito (un luogo, una scelta urbana, un conflitto sociale) e si ritrova dentro un racconto unico; chi, dall’altra parte, indossa una divisa e finisce a essere pedina simbolica di una guerra culturale.
E qui c’è un punto delicato, ma necessario: la retorica che cancella le distinzioni (“sono tutti violenti”, “sono tutti complici”) è comoda, però è tossica. Se ogni corteo diventa sospetto in quanto tale, la democrazia si restringe senza bisogno di dichiararlo. Se ogni manifestazione viene letta come “fronte nemico”, allora le parole cambiano la realtà prima ancora delle leggi: non si governa più una società, si gestisce un campo ostile.
Torino ci consegna questa domanda: perché basta così poco per far saltare una piazza? È una domanda che riguarda anche i movimenti, le reti, gli organizzatori: la capacità di isolare chi cerca lo scontro non è un dettaglio etico, è una condizione di sopravvivenza politica. Ma riguarda anche lo Stato: perché la risposta più rapida è sempre la stretta e quasi mai l’intelligenza sociale, la mediazione, l’ascolto dei conflitti prima che diventino esplosivi? Governare non è solo punire: è anche togliere terreno al reclutamento degli “utili idioti”.
In fondo, a Torino si è visto il meccanismo intero: la piazza reale, la piazza in video, la piazza in narrazione, la piazza in decreto. Nel mezzo, come sempre, la parte più fragile: la verità lenta, fatta di contesti, di ragioni, di responsabilità differenziate. E la verità lenta oggi perde quasi sempre contro la verità veloce.
Ma se la politica vive di verità veloci, e i facinorosi vivono di immagini veloci, allora il disordine non è solo un incidente: diventa un linguaggio condiviso — per ragioni opposte — da chi vuole incendiare e da chi vuole stringere. E questo, più di ogni slogan, dovrebbe inquietare: perché indica che la società sta smarrendo il lessico del limite, e si sta abituando a pensare che l’unico modo di fare ordine sia attendere il caos.