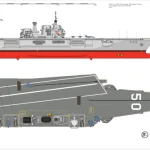Inizio 2026. Mentre a Washington la March for Life torna a riempire le strade e il Papa richiama la responsabilità di una società che “protegge la vita umana”, riemerge – quasi per inerzia storica – un interrogativo che non smette di dividere: perché la Chiesa può mettere in guardia proprio quei movimenti che dichiarano di difendere “principi cristiani” contro la modernità che disgrega? Il caso di Tradition, Family and Property resta il più istruttivo, perché mostra come un lessico apparentemente irreprensibile possa trasformarsi in dispositivo identitario.
La questione non è l’elenco dei valori. È la forma che quei valori prendono quando diventano cultura, prassi, potere. La Chiesa non giudica un movimento perché pronuncia parole giuste; lo valuta per la sua ecclesialità concreta: comunione effettiva, trasparenza, libertà delle coscienze, obbedienza non selettiva, capacità di rimanere dentro il corpo vivo della Chiesa senza costruire un “dentro” e un “fuori” secondo criteri ideologici. È in questa prospettiva che va compresa la frattura storica tra la TFP e una parte significativa dell’episcopato brasiliano.
Nel 1985 la Conferenza episcopale del Brasile pubblicò un documento di condanna tra i più severi del secondo dopoguerra contro un soggetto laicale organizzato. Non fu una disputa di sfumature: vennero contestati la mancanza di comunione con la Chiesa e i pastori, l’impianto settario e opaco, il fanatismo religioso, fino al sospetto di un culto della personalità attorno al leader e alla madre. La conclusione era pastorale e drastica: sconsigliare ai cattolici adesione e collaborazione. In quella pagina si riconosce il criterio tipico del discernimento ecclesiale: non basta dire “tradizione”; occorre vedere se la tradizione è memoria viva che genera comunione o bandiera che produce separazione.
La TFP nacque come “contro-rivoluzione”: una lettura totale della modernità come deriva, e quindi una mobilitazione permanente per difendere un ordine ritenuto cristiano. È qui che appare il limite strutturale di molte ideologie identitarie in veste religiosa: la tentazione di scambiare la fede con l’identità da difendere e la Chiesa con il campo da controllare. Quando si consolida l’idea di essere l’ultima trincea della vera fede, la comunione diventa condizionata: si accetta ciò che conferma l’identità e si sospetta ciò che la mette in crisi. La fede, invece di restare Vangelo che converte, diventa appartenenza che separa.
Il nodo si illumina ancora di più se collocato nel contesto politico-culturale dell’ultimo quadriennio. Dal 2022 al 2026 l’Occidente ha attraversato un ciclo di insicurezze – guerra, inflazione, crisi energetica, migrazioni, trasformazioni tecnologiche – che ha rafforzato la domanda di protezione simbolica. In questo clima, la retorica dell’ordine e delle radici ha conosciuto un ritorno di fiamma. Accanto alle destre parlamentari e ai populismi di governo, si è tentata una federazione transnazionale del sovranismo, con l’impronta di Steve Bannon: una “internazionale” anti-élite e anti-Bruxelles, costruita con tecniche moderne di mobilitazione e con reti finanziarie tutt’altro che marginali. In parallelo, l’immaginario geopolitico più radicale ha incrociato, in alcuni ambienti europei, la retorica civilizzatrice di Mosca e la mitologia di un’anti-modernità “spirituale” opposta all’Occidente liberale. In quel circuito, il nome di Aleksandr Dugin è diventato simbolico; l’uccisione della figlia Darya Dugina nell’agosto 2022 ha trasformato una galassia ideologica in fatto emotivo e mediatico, con un effetto di accelerazione e radicalizzazione del discorso pubblico.
Dentro questa temperatura culturale, l’Italia ha conosciuto anche una variante più “metapolitica”, meno movimentista: l’area che ruota attorno a Roberto de Mattei e all’esperienza di Lepanto. Un progetto culturale e militante, capace di produrre contenuti, relazioni e formazione, ma – rispetto al mainstream sovranista dell’epoca Bannon – strutturalmente meno potente sul piano dell’impatto di massa. Ciò non implica irrilevanza, ma indica una differenza di funzione: non motore di piazza, bensì laboratorio di idee, spesso centrato sulla lettura della crisi ecclesiale e sulla questione liturgica come frontiera identitaria.
È qui che la pagina torna a essere ecclesiologica. Quando la fede viene compressa in una forma di identità, la liturgia rischia di diventare bandiera, non fonte. La linea si irrigidisce: “noi” custodi, “loro” traditori; “noi” puri, “loro” contaminati. In questo schema alcune figure ecclesiastiche diventano icone politiche, più che pastori; tra queste, negli ultimi anni, Raymond Leo Burke è stato frequentemente collocato come riferimento simbolico nel mondo tradizionalista. Il risultato è una religione che assomiglia troppo a una militanza: energica, compatta, spesso efficace nel comunicare; ma povera di quell’elemento decisivo che la Chiesa riconosce come criterio evangelico, cioè la capacità di generare comunione senza ridurre la verità a recinto.
In questo orizzonte si comprendono anche alcune “influenze” su realtà ecclesiali e percorsi comunitari che, a un certo punto, hanno assunto una svolta identitaria tradizionalista. Quando la logica del “baluardo” prende il sopravvento, cresce la dipendenza da figure-guida e cresce la tentazione di interpretare la vita ecclesiale come guerra totale. È una dinamica che produce fedeltà selettive, mitologie interne, spirito di accerchiamento: tratti tipici di una falsa coscienza religiosa, capace di sentirsi più cattolica della Chiesa.
Ecco allora perché la Chiesa può contestare movimenti che proclamano tradizione, patria, famiglia senza contestare quei valori in sé. Perché, cristianamente intesi, essi non sono slogan: la tradizione è memoria viva che genera comunione; la patria è responsabilità per un popolo concreto, non idolatria del confine; la famiglia è cura delle persone, non clava culturale. Quando questi beni diventano recinto, si aggiunge un quarto termine non dichiarato: il potere. E il potere, anche quando parla con lingua devota, resta il concorrente più sottile del Vangelo.
Inizio 2026 offre così una chiave: in un tempo di paura e polarizzazione torna seducente l’idea di salvare la fede chiudendola. Ma l’esperienza storica mostra che la fede si custodisce in modo opposto: aprendola alla conversione, alla verifica ecclesiale, alla comunione reale. Il cristianesimo non è un club dei puri. È un popolo di salvati.