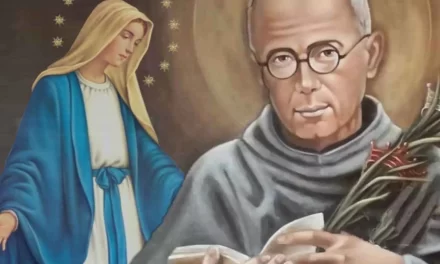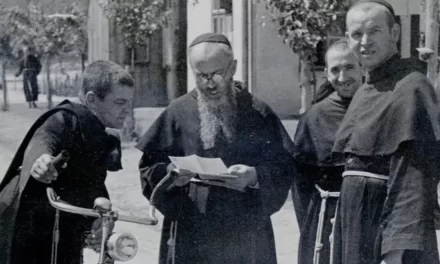Il card. Muller rilascia un’intervista che fa discutere
C’è un tratto che colpisce nel recente colloquio tra il cardinale Müller e Diane Montagna: non la franchezza — virtù sempre gradita — ma la confusione dei piani. Un minestrone, letteralmente: politica, paura dell’Islam, nostalgia di un’Europa cristiana idealizzata, allarmi catastrofisti, giudizi sommari sul mondo LGBT, invettive contro vescovi considerati “timorosi”, sospetti sul sinodo, affermazioni apocalittiche sulla Germania “già musulmana”. Tutto nello stesso calderone, senza distinzione tra fatti, opinioni, dottrina, prudenza pastorale, letture sociologiche.
A stupire non è l’esistenza di domande difficili — quelle la Chiesa le ha sempre affrontate — ma la semplificazione brutale con cui vengono trattate. E stupisce di più perché la voce è autorevole: un teologo di lungo corso, che ha studiato Gutiérrez, conosce le fragilità delle società moderne e sa bene quanto sia ingannevole costruire narrazioni in cui il mondo è diviso in noi contro loro, buoni e cattivi, puri e corrotti.
Eppure l’intervista — sollecitata da una giornalista che, da anni, intercetta tutte le inquietudini del campo tradizionalista e le amplifica senza filtro — si muove esattamente così: offrendo ai lettori un Vangelo trasformato in arma identitaria, un cristianesimo ridotto a muraglia contro tutto ciò che appare nuovo o inatteso, un’allerta permanente dove ogni fenomeno diventa minaccia.
Il caso più clamoroso è la canonizzazione simbolica di Charlie Kirk, presentato come “martire cristiano”, vittima di una “ideologia satanica”. È un salto logico enorme, che riduce la complessità della vita pubblica americana a uno scontro cosmico tra forze del bene e del male. Il martirio, nella tradizione cattolica, ha un peso teologico enorme: non può diventare un distintivo da appuntare sul petto di un attivista politico per rafforzare una narrativa di guerra culturale.
Lo stesso avviene nell’analisi dell’Islam, trattato non come una realtà plurale ma come un monolite invadente, destinato — quasi fisiologicamente — a sovrastare l’Europa. Qui non troviamo la sapienza di Nostra Aetate, né il coraggio di Francesco o ora di Leone XIV nel coltivare una “cultura dell’incontro”, ma uno schema basico: più migranti musulmani entrano, meno cristiani rimangono. Come se la fede fosse un prodotto demografico, invece di una scelta libera, un annuncio, un cammino ecclesiale.
Sul mondo LGBT, poi, il tono si irrigidisce ulteriormente: ogni gesto pastorale è interpretato come cedimento, ogni incontro come complicità, ogni tensione come sacrilegio. Nessuna distinzione tra persone e ideologie, tra peccato e percorso, tra scandalo e accompagnamento. È la logica del tribunale, non quella del pastore.
Non aiuta che tutto questo venga raccolto senza contraddittorio da una giornalista che ha fatto della polarizzazione ecclesiale il proprio campo d’azione. Il rischio evidente — e ormai ricorrente — è che una parte della Chiesa, ferita, impaurita o semplicemente arrabbiata, venga nutrita non con il pane del discernimento, ma con un miscuglio di slogan, allarmi e nostalgie che poco hanno a che vedere con il Vangelo.
Il problema non è che il cardinale Müller critichi, o esprima timori: è legittimo, anzi necessario in certi casi. Il problema è che questo modo di criticare non costruisce nulla.
Non illumina, non accompagna, non offre criteri.
Diventa un grido nella notte, e come ogni grido rischia di far perdere la bussola.
In un tempo in cui la Chiesa — con Leone XIV come con Francesco — tenta faticosamente di guarire ferite e di ricucire unità, servirebbe ben altro: la capacità di distinguere, la pazienza di ascoltare, la verità detta senza urlare, la libertà di criticare senza demolire. Servirebbe, soprattutto, tornare a parlare di Cristo senza trasformarlo in un vessillo di parte.
L’ultima cosa di cui la comunità cristiana ha bisogno è un altro minestrone ideologico travestito da profezia. La profezia — quella vera — ha il sapore della chiarezza, della mitezza e della speranza. Non della paura. Non dell’assedio. Non della polarizzazione.
E men che meno della propaganda.