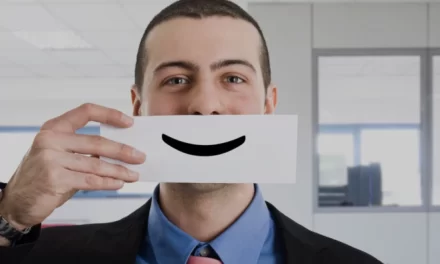L’11 settembre 2001 rimane una ferita aperta nella memoria globale. Le immagini delle Torri Gemelle che crollano, degli aerei trasformati in armi e del dolore di migliaia di vittime hanno segnato l’inizio del XXI secolo. Ma a ventiquattro anni di distanza, l’eco di quel giorno risuona non solo nel ricordo, bensì nelle conseguenze geopolitiche che hanno ridisegnato il mondo.
Dal “clash of civilizations” al disordine globale
All’indomani degli attentati, il dibattito internazionale si concentrò sulla teoria dello “scontro di civiltà” di Samuel Huntington: l’idea che il conflitto tra Occidente e Islam fosse il paradigma interpretativo del nuovo secolo. Una visione riduttiva, che rischiava di trasformare una tragedia terroristica in uno schema ideologico permanente.
Col tempo, però, quella lettura ha mostrato i suoi limiti. L’11 settembre ha certamente inasprito la frattura tra Nord e Sud del mondo, ma i conflitti emersi negli anni successivi – dalla guerra in Iraq alla crisi siriana, fino alla sfida tra Stati Uniti e Cina – hanno dimostrato che il nuovo ordine globale non si riduce a una semplice contrapposizione tra civiltà religiose o culturali. È piuttosto un mosaico di potenze in competizione, dove economie, tecnologie e risorse energetiche contano quanto, se non più, delle identità culturali.
Afghanistan: la sconfitta dell’Occidente
Se c’è un simbolo di questo fallimento, è l’Afghanistan. Vent’anni di guerra, migliaia di morti, ingenti spese militari e la promessa di costruire uno Stato democratico si sono conclusi nell’agosto 2021 con il ritiro disordinato delle truppe occidentali e il ritorno al potere dei talebani.
Secondo i dati del progetto Costs of War della Brown University, la guerra in Afghanistan è costata agli Stati Uniti oltre 2.300 miliardi di dollari, con 243 mila vittime complessive, di cui più di 71 mila civili. L’immagine dei C-17 in decollo dall’aeroporto di Kabul, con civili aggrappati alle ruote, resta una delle pagine più umilianti per gli Stati Uniti e i loro alleati, segno di un progetto politico fallito e di un costo umano altissimo.
Nuovi equilibri e “Stati canaglia”
Negli anni successivi, il quadro internazionale è cambiato radicalmente. La Cina è divenuta una potenza globale capace di competere con Washington sul piano economico e tecnologico; la Russia, con la guerra in Ucraina, ha messo in discussione gli equilibri europei; il Medio Oriente resta epicentro di tensioni, con Israele e Iran come attori chiave.
In questo contesto, l’etichetta di “Stato canaglia” – un tempo riservata dall’Occidente a regimi come l’Iran, la Corea del Nord o l’Iraq di Saddam Hussein – appare oggi più relativa. Secondo l’ONG Airwars, dal 2001 a oggi i bombardamenti americani in Medio Oriente hanno causato tra 300 e 350 mila vittime civili. Allo stesso modo, i recenti attacchi israeliani a Gaza e in Libano hanno suscitato accuse di crimini di guerra presso le Nazioni Unite. Le pratiche di violenza indiscriminata, gli abusi del diritto internazionale, gli interventi militari unilaterali hanno coinvolto anche potenze democratiche, che a parole si presentano come garanti dell’ordine mondiale.
Bin Laden, Al-Qaida e le nuove minacce
L’uccisione di Osama bin Laden, avvenuta nel maggio 2011 ad Abbottabad per mano delle forze speciali statunitensi, fu salutata come una svolta storica. Ma la fine del leader di Al-Qaida non ha significato la fine del jihadismo globale.
Oggi Al-Qaida esiste ancora, sebbene indebolita e frammentata, con roccaforti in aree periferiche come lo Yemen (Al-Qaida nella Penisola Arabica) e il Sahel (Gruppo per il Supporto all’Islam e ai Musulmani). La sua capacità di colpire l’Occidente è ridotta, ma il gruppo resta radicato in contesti di fragilità statale e continua a ispirare nuovi militanti.
Ancora più devastante è stata l’ascesa dell’ISIS, che tra il 2014 e il 2019 ha controllato ampie porzioni di Siria e Iraq, proclamando un “califfato” e attirando decine di migliaia di foreign fighters. Pur sconfitto militarmente, lo Stato islamico si è riorganizzato in cellule sparse, attive dall’Africa subsahariana al Sud-Est asiatico. Secondo l’ONU, nel 2025 le sue filiali africane – in Nigeria, Mozambico, Congo – sono tra le più violente al mondo, con migliaia di vittime civili ogni anno.
Un anniversario che interpella
Ricordare l’11 settembre non significa soltanto commemorare le vittime del terrorismo, ma interrogarsi sulla risposta che il mondo ha dato. La guerra al terrore, più che sconfiggere il radicalismo, ha contribuito ad alimentare nuove insicurezze e ondate migratorie: si stima che oltre 38 milioni di persone siano state costrette a fuggire da Afghanistan, Iraq, Siria, Yemen e altri Paesi teatro delle guerre post-2001.
Nel 2025 il pianeta non vive un conflitto di civiltà, ma un disordine diffuso in cui potenze regionali e globali si contendono sfere d’influenza. E in questo disordine, la pace sembra più lontana. L’unica vera alternativa è quella di costruire un ordine internazionale basato non sulla vendetta o sulla forza, ma sul rispetto del diritto, sulla giustizia e sul dialogo tra i popoli.
Ventiquattro anni dopo, l’11 settembre continua a chiederci non di dividere il mondo in blocchi contrapposti, ma di riscoprire il senso della convivenza e della dignità umana.