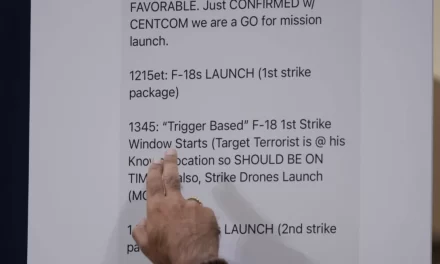Dal colloquio a Castel Gandolfo con Papa Leone XIV all’incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, Zelensky rilancia il piano di pace ridotto a 20 punti e invita il Pontefice a Kiev. Intanto Trump accusa l’Ucraina di “usare la guerra per non votare” e sostiene che Kiev “sta perdendo”, mentre l’Europa difende la propria leadership e teme che il nuovo asse Washington-Mosca possa piegare la sovranità ucraina.
Zelensky che arriva a Palazzo Chigi dopo Castel Gandolfo è l’immagine plastica di un’Europa tirata per la giacca da tutte le parti: dal fronte del Donbass, dai tweet del Cremlino, dalle interviste di Trump, e insieme dalla propria coscienza di “progetto di pace” messo alla prova dalle bombe. In mezzo, l’Italia e la sua premier, Giorgia Meloni, si ritrovano improvvisamente chiamate per nome: «Per i negoziati mi fido di lei», dice il presidente ucraino. Non è solo un complimento: è una delega, ed è anche una responsabilità.
La giornata di Zelensky è un itinerario simbolico. La mattina a Castel Gandolfo, dal Papa – Leone XIV – con un invito che pesa più di molti documenti: «Venga a Kiev». Il linguaggio è quello delle visite pastorali, ma il sottotesto è brutalmente politico: l’Ucraina cerca un sigillo morale, una presenza che dica al mondo che il suo martirio non è una questione periferica. Il pomeriggio a Palazzo Chigi, nella capitale di un Paese che, pur tra ambiguità e riserbi, continua a garantire sostegno militare e diplomatico. Nel mezzo, un piano di pace americano che passa da 28 a 20 punti: via otto capitoli, ma non è affatto certo che siano stati tagliati quelli più indulgenti verso Mosca. Il riassunto non equivale alla conversione.
Su questo quadro già complesso, si staglia la voce di Donald Trump, che interviene come se la guerra in Ucraina fosse un dossier di campagna elettorale interna: «L’Ucraina deve tenere le elezioni… stanno usando la guerra per non farle… Zelensky sta perdendo, deve accettare la situazione». L’argomento non è nuovo, ma l’insistenza suona diversa in un contesto in cui il Cremlino si affretta, quasi con gratitudine, a rilanciare le parole del presidente americano. Il linguaggio è rivelatore: dall’altra parte del mondo, il tycoon parla di leader europei «deboli», di Paesi «decadenti», di capitali congestionate dai migranti; a Mosca, il consigliere Dmitriev applaude e invita l’Unione a «ascoltare il Paparino» per salvarsi dal declino. È un asse retorico, prima ancora che geopolitico: lo stesso ritornello suona a Washington e sulla Moscova, con minime variazioni sul tema.
Bruxelles reagisce ricordando che l’Europa è «orgogliosa dei propri leader» e rivendica la fatica di tenere insieme libertà di espressione e tutela democratica nello spazio digitale. Antonio Costa, dalla presidenza del Consiglio europeo, mette il dito nella piaga: se Mosca dice di condividere la visione di Washington sull’Europa, almeno qualche domanda bisognerebbe porsela. Non è solo polemica: è la presa d’atto che il rapporto transatlantico non è più l’asse scontato di un tempo, ma un terreno accidentato, in cui la Casa Bianca può usare le stesse parole di un oligarca russo e un tecno-oligarca californiano può paragonare l’Unione al Terzo Reich.
In questo scenario, l’Italia diventa per un giorno una piccola piattaforma di incrocio. Zelensky che si affida a Meloni «per i negoziati» non significa che Roma sia improvvisamente diventata l’architrave di un nuovo ordine europeo. Più sobriamente, dice che l’Ucraina cerca – oltre Berlino e Parigi – anche una sponda mediterranea, un Paese che ha ancora credibilità in certi ambienti americani e che, allo stesso tempo, non è percepito a Mosca come il più aggressivo dei falchi. È un equilibrio precario, ma è un ruolo.
Resta la domanda di fondo: che cosa significa oggi “negoziare”, quando uno dei leader del principale alleato occidentale dell’Ucraina sostiene che Kiev «sta perdendo» e deve «accettare le cose»? Se il messaggio che arriva da Washington è: arrangiatevi tra voi, l’Europa paghi e l’Ucraina si accontenti, i 20 punti del piano di pace rischiano di assomigliare più a un atto notarile di resa graduale che a una vera architettura di sicurezza. La trappola, per l’Europa, è doppia: non può abbandonare Kiev senza compromettere la propria stessa idea di democrazia e di sovranità; ma non può neppure limitarsi a fare da cassiere riluttante di una strategia scritta altrove e applaudita dal Cremlino.
In questo gioco di specchi, la figura del Papa – che riceve Zelensky in una mattina di dicembre e ascolta il racconto dei bambini rapiti, dei prigionieri da scambiare, delle città devastate – appare come l’unico attore globale che si rifiuta di parlare in termini di vittoria o sconfitta. Quando Roma insiste sugli scambi di prigionieri, sulla restituzione dei minori deportati, sulla “pace giusta e duratura”, non sta dettando confini, ma sta tracciando una linea etica: qualunque accordo passi sopra i corpi dei più vulnerabili non è pace, è solo sospensione di fuoco. È un richiamo scomodo per tutti: per Mosca, per Kiev, per Washington, per Bruxelles.
Castel Gandolfo e Palazzo Chigi, in questo 9 dicembre, diventano così i due poli di una stessa tensione. Da una parte, il dialogo con un’istituzione – la Chiesa – che guarda oltre i cicli elettorali e rifiuta di confondere la democrazia con il rito periodico delle urne in mezzo alle macerie. Dall’altra, il confronto con una premier che si sente dire, dal leader di un Paese in guerra: «Mi fido di lei». È il tipo di fiducia che non ammette scorciatoie propagandistiche: perché il giorno in cui l’Europa accettasse che il prezzo della pace è la normalizzazione dell’aggressione, allora sì che il lessico di Trump sulla “democrazia” in Ucraina diventerebbe un cupo presagio per tutti.
Intanto, mentre Zelensky espone il piano di pace “rivisto”, la Russia celebra i suoi eroi decorati e racconta l’«inseparabilità della storia e del destino» della Madrepatria. È un linguaggio del passato che pretende di decidere il futuro. L’Europa, se vuole avere voce, deve trovare parole nuove che non siano né il riflesso condizionato del “Paparino” d’oltreoceano, né l’eco rassegnata del fatalismo russo.