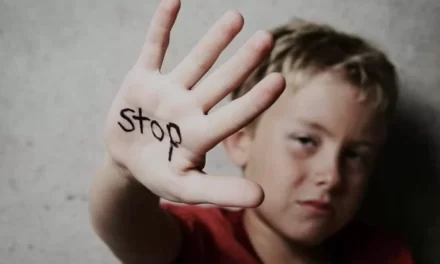A trentatré anni dalla strage, la verità processuale su via D’Amelio ha aperto spiragli inquietanti, tra depistaggi e trattative occulte. Eppure, molto resta da chiarire. La verità storica attende ancora di essere pienamente scritta.
Il 19 luglio 1992 non è soltanto il giorno di una strage, quella di via D’Amelio. È il simbolo amaro della resistenza civile e morale di Paolo Borsellino, il magistrato che, insieme a Giovanni Falcone, aveva osato sfidare apertamente il potere mafioso, mettendo in luce le connivenze oscure e i legami perversi tra Cosa nostra e settori deviati dello Stato.
A trentatré anni dalla sua uccisione, avvenuta attraverso un’autobomba che devastò Palermo, la ricerca della verità non si è ancora conclusa. Anzi, via via che emergono frammenti di realtà giudiziarie, diventa sempre più evidente che quello fu molto più di un attentato mafioso. Fu un colpo sferrato al cuore dello Stato per destabilizzarlo e ricostruire equilibri criminali che Falcone e Borsellino avevano spezzato con le loro indagini coraggiose.
Le parole di Borsellino pochi giorni prima della strage sono diventate profetiche: «Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola». E lui non aveva paura, aveva compreso fin troppo bene la posta in gioco. Aveva intuito l’esistenza della trattativa tra pezzi delle istituzioni e i capi mafia, un accordo criminale che avrebbe dovuto garantire silenzio e impunità in cambio della fine delle stragi.
Ma non fu soltanto mafia: dietro la strage di via D’Amelio agivano ombre, apparati deviati, servizi segreti infedeli che hanno protetto mandanti rimasti troppo a lungo impuniti. Così, quella di Borsellino non fu solo una morte violenta, fu una morte strategica, parte di un più ampio piano di destabilizzazione del Paese, un tentativo di mettere in ginocchio la legalità per aprire varchi a interessi ancora più oscuri.
Quel giorno persero la vita con lui anche gli uomini della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Giovani che avevano scelto con coraggio di stare dalla parte della legalità, consapevoli del rischio, silenziosi eroi di una guerra che ancora oggi continua nelle aule di tribunale e nella coscienza civile del Paese.
Paolo Borsellino era un uomo di fede cattolica, vissuta come impegno concreto, come dovere di verità e giustizia. La sua fede non era disgiunta dall’azione quotidiana, non era astratta preghiera, ma una costante ricerca della verità che deve accompagnarsi sempre alla giustizia. Questo aspetto profondamente spirituale oggi lo rende un riferimento morale autentico, ben oltre la retorica commemorativa.
La famiglia di Borsellino, ferita ma indomita, non si è mai fermata nella ricerca della verità. Indignata dinanzi ai depistaggi, alle menzogne, ai silenzi colpevoli, è scesa in campo nella vita civile e politica del Paese, divenendo testimonianza vivente della necessità di mantenere sempre alta la guardia contro ogni forma di compromesso morale.
Dalla verità processuale è emersa una realtà inquietante: depistaggi, falsi pentiti e confessioni estorte hanno inquinato per anni le indagini, impedendo di risalire ai veri mandanti. Solo recentemente sono stati riconosciuti in sede giudiziaria questi gravissimi errori, aprendo nuove possibilità di ricostruzione della strage. Tuttavia, molto resta ancora oscuro. La verità storica, quella capace di spiegare pienamente motivazioni, complicità e obiettivi, non è ancora stata pienamente scritta. Rimane un debito aperto con Borsellino e con la giustizia.
Cosa lascia oggi il sacrificio di Paolo Borsellino? Lascia un debito di verità, una lezione di coraggio, l’urgenza di una lotta intransigente alla criminalità organizzata. Lascia la responsabilità a ciascuno di noi di essere cittadini vigili e consapevoli, impegnati perché l’Italia non torni più indietro nei bui sentieri delle trattative segrete.
Trentatré anni dopo, la memoria di Borsellino ci chiama ancora una volta all’impegno civile, alla giustizia autentica, quella che non teme di illuminare anche le pagine più oscure della nostra storia recente.