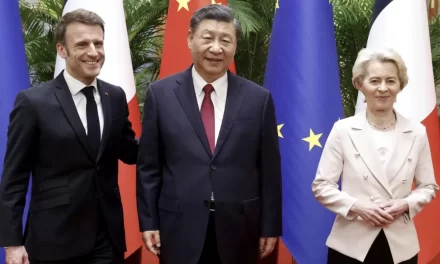L’M23 lascia Uvira sotto le pressioni di Trump
Il 16 dicembre, nell’est della Repubblica Democratica del Congo, la parola “pace” ha assunto ancora una volta la forma ambigua dell’annuncio. Il gruppo ribelle M23, sostenuto dall’esercito ruandese, ha dichiarato che si ritirerà da Uvira, città strategica del Sud Kivu conquistata appena pochi giorni prima. Una decisione presa — è bene sottolinearlo — non per un improvviso sussulto di responsabilità regionale, ma su richiesta degli Stati Uniti, che hanno denunciato una “chiara violazione” dell’accordo di pace firmato a Washington all’inizio del mese.
La scena è ormai familiare a chi segue da anni le tragedie dei Grandi Laghi: un accordo di pace celebrato nelle capitali occidentali, una nuova offensiva militare che lo smentisce sul terreno, e infine una marcia indietro tattica, annunciata più che verificata. A Uvira, città-chiave perché collega la RDC al Burundi — alleato militare di Kinshasa — la popolazione attende ancora di capire se il ritiro sarà reale o soltanto una mossa per “tenere buoni gli americani”, come ha detto con amara lucidità un rappresentante della società civile locale.
Il contesto rende il tutto ancora più eloquente. Mentre a Washington i presidenti Félix Tshisekedi e Paul Kagame firmavano un accordo di pace sotto l’egida di Donald Trump, l’M23 avanzava sul campo, conquistando Uvira il 10 dicembre e tagliando i collegamenti logistici dell’esercito congolese. La guerra, come spesso accade in Africa, non aspettava i comunicati congiunti.
Solo dopo le pressioni dirette di Washington — e le accuse esplicite rivolte a Kigali dall’ambasciatore Usa all’Onu, Mike Waltz — è arrivato l’annuncio del ritiro. Ma anche qui, le parole contano: Corneille Nangaa, leader politico dell’M23, ha parlato di ritiro “unilaterale”, subordinandolo però a condizioni pesanti — smilitarizzazione della città, forza neutrale, protezione dei civili — che suonano più come una negoziazione armata che come un passo verso la pace.
Il Ruanda, come sempre, nega ufficialmente ogni coinvolgimento diretto. Eppure le stesse autorità statunitensi parlano di cinquemila-settemila soldati ruandesi presenti nell’est del Congo. Numeri che smentiscono la retorica dell’“instabilità locale” e riportano il conflitto alla sua vera dimensione: una guerra regionale combattuta per procura, in cui i ribelli sono strumenti e le popolazioni civili carne da sfollamento.
Dietro la diplomazia, infatti, si muove un’altra mappa: quella delle risorse strategiche. L’accordo di pace firmato il 4 dicembre a Washington non riguarda solo sicurezza e confini, ma anche patti bilaterali che garantiscono agli Stati Uniti accesso privilegiato ai minerali congolesi. La RDC non è soltanto un Paese in guerra: è il primo produttore mondiale di cobalto, essenziale per la transizione energetica, e detiene circa il 60 per cento delle riserve globali di coltan, cuore pulsante dell’industria elettronica.
È qui che la pace rischia di rivelare il suo volto più cinico. Quando la stabilità viene cercata non per le persone ma per le catene di approvvigionamento, la guerra non finisce: cambia solo intensità. E Uvira diventa un nome in più nella lunga lista di città congolesi usate come pedine in una partita che si gioca altrove.
Intanto, secondo le Nazioni Unite, l’offensiva dell’M23 ha già provocato decine di morti e oltre 200mila sfollati. Numeri che non entrano nei comunicati ufficiali, ma che raccontano la verità del conflitto: una popolazione che continua a pagare il prezzo di accordi firmati lontano, spesso senza di essa.
Il 16 dicembre, dunque, non segna una svolta, ma una sospensione. Un ritiro annunciato, non ancora verificato. Una pace evocata, non ancora incarnata. Finché la sicurezza dell’est del Congo sarà subordinata agli equilibri regionali e agli appetiti globali, Uvira resterà ciò che è sempre stata: una frontiera instabile, dove la diplomazia arriva sempre dopo le armi.