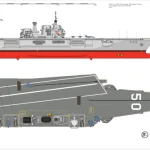A Gaza il Natale non comincia con le luci, ma con una presenza. Non con l’abbondanza, ma con il ritorno di un pastore. L’arrivo del cardinale Pierbattista Pizzaballa alla parrocchia della Sacra Famiglia non ha il sapore dell’evento, bensì quello della fedeltà. In una terra in cui tutto è provvisorio, anche la tregua, ciò che colpisce è la continuità: esserci, tornare, non lasciare soli.
Sotto un cielo che per qualche ora non conosce il rombo delle bombe, la comunità cristiana – poche centinaia di persone raccolte attorno alla chiesa – ritrova un ritmo diverso. Non quello della guerra, ma quello delle relazioni. Gli abbracci, i canti dei bambini, i passi incerti delle danze tradizionali non sono folclore: sono una forma di resistenza. La più disarmata e, proprio per questo, la più eloquente.
Il Natale di Gaza non ha bisogno di grandi parole. Comincia con una visita, continua con una liturgia curata, si fa carne in un Battesimo, in sette Prime Comunioni. Segni minuscoli, quasi invisibili sulla mappa del mondo, ma enormi per chi vive sotto assedio. In un luogo dove la vita è continuamente rimandata, il sacramento diventa affermazione ostinata del futuro. Battezzare un bambino oggi, a Gaza, significa dire che il domani non è stato cancellato.
C’è qualcosa di profondamente evangelico in questa normalità custodita. La parrocchia non è solo rifugio, ma spazio di dignità. Qui la Chiesa non discute di geopolitica, ma distribuisce uova, un pollo per famiglia, coperte, vestiti. Qui la carità non è un’idea, ma una logistica paziente. E mentre fuori la guerra continua a ridefinire confini e poteri, dentro si misura il tempo con altri criteri: la visita ai malati, l’attenzione agli anziani, la cura dei disabili.
La figura del parroco, che ha scelto di restare quando tutto spingeva a fuggire, racconta una Chiesa che non cerca eroismi, ma perseveranza. Restare non come sfida, ma come servizio. Non come gesto spettacolare, ma come atto quotidiano di responsabilità. In questo senso, il Natale di Gaza non è un’eccezione pietosa: è una lezione severa.
Anche la presenza discreta, ma costante, del Papa – le telefonate, i messaggi – e la vicinanza del nuovo Pontefice, parlano una lingua precisa: la Chiesa non risolve i conflitti, ma rifiuta l’indifferenza. Non ferma le armi, ma impedisce che il dolore diventi invisibile. In un mondo abituato a contare solo ciò che pesa, Gaza ricorda che esistono realtà che resistono perché sono leggere.
Il Natale, lì, non può essere rumoroso. Non ci sono grandi festeggiamenti, né piazze illuminate. C’è una liturgia sobria, un presepe vivente preparato dai bambini, qualche dolce trovato al mercato. È poco, ma è vero. È il Natale spogliato di ogni superfluo, restituito alla sua origine: Dio che entra nella storia senza protezioni.
Forse è questo che Gaza insegna, senza volerlo, a un Occidente distratto: il Natale non è ciò che aggiungiamo, ma ciò che resta quando tutto il resto viene tolto. E quando resta la fede, la fraternità, la cura reciproca, allora – anche sotto un telone, anche tra macerie – il Natale può cominciare davvero.