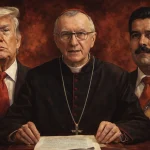Il “no” di Trump ai missili Tomahawk per Kiev non è solo una scelta politica. È il segno di un conflitto che rischia di divorare se stesso, mentre l’Europa fatica a trovare la bussola tra prudenza, solidarietà e realismo.
Donald Trump ha detto no. Nessun missile Tomahawk per l’Ucraina. In compenso, una nuova raffica di sanzioni contro il petrolio russo, le più dure mai imposte, che colpiscono Rosneft e Lukoil, i due polmoni dell’economia di guerra del Cremlino.
Molti analisti hanno letto questa decisione come l’ennesimo segnale di ambiguità del presidente americano: duro nelle parole, esitante nei fatti. Ma la realtà, se la si guarda con occhio meno ideologico e più concreto, è che dietro quella scelta c’è un calcolo preciso, e perfino una logica morale: evitare che la guerra travolga ciò che resta della pace.
I limiti della forza
I Tomahawk non sono “armi da consegna”, come si inviano i droni o i carri armati. Sono missili da crociera che richiedono piattaforme di lancio navali o sottomarine e personale altamente addestrato. In breve: senza militari americani sul campo, nessuno a Kiev potrebbe usarli. Trump lo ha detto con la sua consueta rudezza: «Ci vuole un anno per imparare a usarli. Gli ucraini non possono farlo. L’unico modo per lanciarli è se lo facciamo noi».
Dietro l’apparente arroganza, c’è un realismo crudo: fornire i Tomahawk all’Ucraina significherebbe coinvolgere direttamente gli Stati Uniti nella guerra contro la Russia. Sarebbe, in sostanza, dichiarare guerra a una potenza nucleare.
Il “no” di Trump, allora, va letto non come un cedimento, ma come un argine. Perché ogni guerra, prima o poi, deve fare i conti con la realtà dei limiti. E riconoscerli non è segno di debolezza, ma di ragione.
L’altra arma: il denaro
Mentre i missili restano nei silos, le sanzioni si moltiplicano. L’arma del dollaro, per gli Stati Uniti, è spesso più potente di quella militare. Rosneft e Lukoil sono ora escluse dai circuiti finanziari in valuta americana. In pratica, Mosca perde la possibilità di commerciare in dollari, il sangue del mercato petrolifero globale.
Non si tratta solo di punire la Russia, ma di limitarne la capacità di finanziare la guerra. La vera battaglia, oggi, si combatte nelle borse e nei porti: se Cina e India ridurranno davvero le importazioni di greggio russo, l’economia del Cremlino ne uscirà stremata.
Ma le sanzioni non sono mai un’arma “pulita”. Colpiscono i regimi, ma anche i popoli. Rendono più difficile la guerra, ma anche la vita. E per questo, accanto alla strategia economica, serve una bussola etica che impedisca di trasformare la giustizia in rappresaglia.
La pace come rischio
Trump spera che l’isolamento economico convinca Putin a negoziare. Ma la guerra non si ferma con un embargo, e la pace non si costruisce con la sola pressione.
Il vertice di Budapest è saltato, i contatti diplomatici si diradano, e la sensazione è che tutti, da Washington a Mosca, stiano guadagnando tempo. Solo l’Ucraina continua a perdere: uomini, case, energia, speranza.
Nel frattempo, l’Europa si divide. Giorgia Meloni, stretta tra gli alleati americani e la Lega, prova a mantenere una linea di prudenza. Roma non vuole essere complice di un’escalation, ma neppure spettatrice passiva. Così, tra esitazioni e compromessi, la guerra continua.
Zelensky, più pragmatico di molti suoi sostenitori, chiede generatori per superare l’inverno. È un segno eloquente: più che armi, l’Ucraina oggi ha bisogno di luce. E di calore umano.
Un conflitto che ci riguarda
Da questa parte del mondo, il rischio è l’indifferenza. Ogni notizia di un missile o di una sanzione scivola via come un titolo tra i tanti. Ma la guerra d’Ucraina è anche un nostro esame di coscienza: fino a che punto crediamo che la pace valga più del potere?
La prudenza non è codardia, come la fermezza non è sempre virtù. È tempo che l’Occidente ritrovi la misura: sostenere l’Ucraina non significa inseguire la vittoria a ogni costo, ma difendere un principio – la dignità della vita – che nessun missile può proteggere.
“Beati gli operatori di pace”, dice il Vangelo. Ma per esserlo davvero occorre coraggio: il coraggio di non cedere né all’odio né all’illusione della forza.
Trump può essere accusato di calcolo, non di incoscienza. Ha scelto di colpire con le sanzioni, non con i missili. Forse non è un gesto eroico, ma è almeno un gesto che tiene aperta la porta della diplomazia. E in un tempo in cui le armi sembrano parlare più degli uomini, può bastare, per ora, a ricordarci che la pace non si costruisce con la paura, ma con la responsabilità.