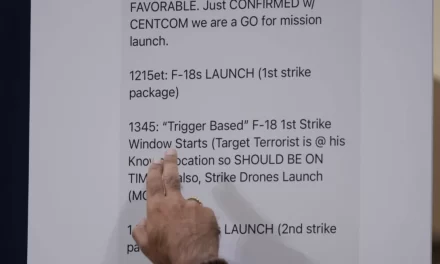Donald Trump ha parlato per quasi un’ora all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ben oltre i 15 minuti consigliati ai leader mondiali. Ne è uscito un discorso lungo, caotico, pieno di rimostranze personali (una scala mobile rotta, un teleprompter bloccato, un appalto mancato per ristrutturare il Palazzo di Vetro), ma anche segnato da parole pesanti: attacchi agli ambientalisti accusati di voler “uccidere tutte le mucche”, insulti al sindaco musulmano di Londra, diffidenze verso la stessa utilità dell’ONU.
Dietro la spettacolarizzazione, tuttavia, si intravede un progetto politico preciso: smontare il multilateralismo costruito faticosamente dal 1945 e sostituirlo con una logica di rapporti bilaterali, di forza, di commercio. Lo stesso Trump lo ha detto: «Qual è lo scopo delle Nazioni Unite?». La sua risposta implicita è che a governare il mondo non debba essere un’assemblea di popoli, ma la potenza del più forte.
Il rovesciamento del multilateralismo
Trump non ha nascosto la sua antipatia per le istituzioni globali: ha tagliato fondi all’ONU, ha ritirato gli Stati Uniti dal Consiglio per i diritti umani, ha ridimensionato gli aiuti internazionali. Ora rilancia questa visione davanti a capi di Stato e di governo: «parole vuote», ha definito le risoluzioni delle Nazioni Unite, contrapponendo l’azione unilaterale americana al dialogo multilaterale.
Eppure, l’ONU nacque proprio per impedire che la forza del più potente decidesse le sorti del pianeta. Roosevelt, De Gasperi, Adenauer e tanti altri credettero che il “mai più la guerra” non fosse un’illusione ma un progetto politico. Mettere in discussione questo fondamento significa ridurre l’ONU a un guscio svuotato e privare il mondo dell’unica tribuna dove tutti, grandi e piccoli, possono avere voce.
Ucraina e Gaza: la doppia ambiguità
Il discorso è stato anche contraddittorio. Trump, che fino a ieri chiedeva a Kiev di cedere territori, ora si dice convinto che l’Ucraina possa riconquistare “tutta la sua forma originaria”. Ma l’appoggio non nasce da una visione di giustizia: è il riflesso di un’industria della difesa che vede crescere i suoi profitti in Borsa ogni volta che il presidente americano alza i toni.
Sulla Palestina, invece, poche parole: nessuna apertura alla soluzione a due Stati, nessuna pressione su Israele per fermare l’avanzata militare a Gaza, solo la condizione — reale ma insufficiente — del rilascio degli ostaggi. E intanto i leader palestinesi sono rimasti fuori dalle Nazioni Unite per il rifiuto dei visti.
Macron e l’Europa
Tra le reazioni europee, quella di Emmanuel Macron è stata tra le più nette. Il presidente francese ha ricordato che “l’ONU resta indispensabile, perché nessun Paese da solo può affrontare sfide globali come la pace, il clima, le migrazioni”. Non un’istituzione perfetta, ma l’unico spazio politico in cui si possono prevenire conflitti planetari.
Macron ha respinto con forza le accuse di Trump sugli ambientalisti e sul cambiamento climatico, ribadendo che l’Europa non può tornare a un modello fondato sul carbone e sugli idrocarburi. «Il nostro compito non è uccidere le mucche, ma salvare la casa comune», ha detto con ironia, raccogliendo applausi nella platea.
Sulla guerra in Ucraina, il leader francese ha apprezzato il “cambio di tono” americano, ma ha precisato che la difesa di Kiev non può ridursi a una logica di contratti d’armi: serve una strategia politica, un’unità europea, un progetto di pace che non lasci all’industria bellica la regia del futuro.
Il clima e la casa comune
Particolarmente inquietante il passaggio sul cambiamento climatico: Trump lo ha definito «la più grande truffa del mondo» e ha ironizzato sulle mucche da abbattere. In un momento storico in cui i dati scientifici mostrano la gravità della crisi ambientale, parole simili sono un insulto non solo alla comunità scientifica, ma soprattutto ai popoli più poveri, che pagano i costi più alti della crisi climatica.
La Laudato si’ di papa Francesco e le recenti parole di Leone XIV hanno parlato chiaro: la terra è la nostra casa comune, e negare il cambiamento climatico significa sottrarsi alla responsabilità verso i poveri e verso le generazioni future. Proprio Leone XIV, aprendo l’anno giubilare, ha invitato a «custodire la creazione come segno di speranza per l’umanità intera», ricordando che la pace non è separabile dalla giustizia ecologica.
Lo spettacolo e la responsabilità
La giornata di Trump a New York è stata raccontata dai media anche come un susseguirsi di gag: la scala mobile bloccata, il teleprompter fuori uso, le battute improvvisate. Ma dietro lo show resta la sostanza: la più grande potenza mondiale sta dicendo al pianeta che non crede più nelle istituzioni comuni, che non intende sottoporre la propria forza a limiti condivisi.
Non è solo questione di stile, ma di etica politica. Se il diritto internazionale diventa carta straccia, se la logica è “io comando e gli altri obbediscono”, la pace diventa sempre più fragile. È proprio in questo contesto che l’Europa dovrebbe ritrovare la sua voce: non come cliente del mercato delle armi, ma come soggetto politico che rilancia il multilateralismo, il diritto, la diplomazia.
La Dottrina sociale della Chiesa lo ricorda: «La pace si costruisce giorno per giorno, nel perseguimento di un ordine voluto da Dio, che comporta una giustizia più perfetta tra gli uomini» (Pacem in terris, 1). Davanti ai toni e alle semplificazioni di Trump, serve una voce profetica che rimetta al centro i popoli, non gli interessi.