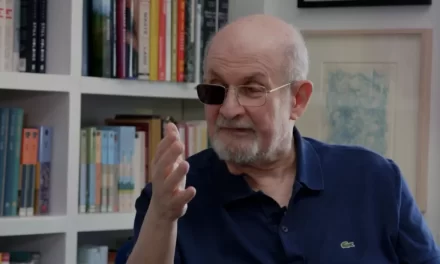Lo Stato, nella sua configurazione giuridica più alta, non può essere ridotto né a mera tecnica di governo, né a semplice apparato amministrativo al servizio di interessi contingenti. Esso si presenta, piuttosto, come forma istituzionale della convivenza giuridicamente ordinata, nella quale le molteplici energie della società – persone, famiglie, comunità intermedie, corpi sociali, istituzioni – vengono armonizzate in vista del bene comune, secondo la misura esigente della giustizia sociale e sotto il sigillo della dignità umana.
Lo Stato suppone, non crea, le attività spirituali, culturali, economiche e religiose che lo precedono e lo trascendono, ma ha il compito ineludibile di garantire le condizioni generali perché esse possano svolgersi secondo le proprie leggi, senza essere assorbite in una totalità politica che pretenda di farsi criterio ultimo del senso e del destino della persona. In questa prospettiva, il fine connaturale dello Stato è il bene comune, inteso non come somma aritmetica di interessi particolari, né come pretesto retorico per la conservazione di privilegi, ma come architettura dinamica di condizioni istituzionali, giuridiche, economiche e culturali che consentano a ogni persona e ad ogni gruppo sociale di sviluppare in pienezza le proprie energie, di “essere di più” e non soltanto di “avere di più”, secondo la lezione, ancora attualissima, dello sviluppo integrale dei popoli. Il bene comune, così inteso, è inseparabile dalla giustizia sociale e dalla fraternità: esso esige che i rapporti politici si strutturino come spazio di riconoscimento reciproco e non come arena di dominio, e che la sovranità statale sia esercitata come responsabilità al servizio della persona e dei popoli, non come titolo di autosufficienza assoluta. La legittimità dello Stato, pertanto, non si fonda su un atto di pura volontà, né su un’autosacralizzazione della “ragion di Stato”, ma sul riconoscimento della legge morale e dei principi fondamentali dell’ordine giuridico: la verità, la giustizia, la libertà, la solidarietà. Lo Stato è tanto più conforme alla propria essenza quanto più riconosce che il diritto precede il potere e che la forza vincolante delle sue leggi è misurata dal loro radicamento nello ius, e non dalla mera efficacia coattiva. In questo senso, l’ordinamento giuridico non è un semplice strumento operativo dello Stato, ma la trama normativa attraverso la quale la giustizia si fa forma storica e la convivenza diviene ordine, sottraendosi alla doppia deriva della violenza anarchica e dell’arbitrio legalmente organizzato.
Giustizia sociale, diritti e partecipazione
La giustizia sociale si manifesta come esigenza di “riconoscere, rispettare e garantire” l’eguale dignità di ogni persona e di ogni popolo: in questa prospettiva, compito e fine dello Stato. Essa chiede, da un lato, la tutela effettiva dei diritti degli individui, delle famiglie, delle minoranze e delle diverse comunità sociali; dall’altro, una cura diligente degli interessi comuni, in particolare là dove solo l’azione pubblica, coordinando le energie dei singoli, può rimuovere ostacoli strutturali e superare disuguaglianze che altrimenti si perpetuerebbero. Ne deriva una concezione “relazionale” della giuridicità: il diritto non è solo insieme di norme, ma spazio di riconoscimento, nel quale il soggetto si scopre se stesso “come un altro” e si comprende come nodo responsabile di una rete di relazioni che fondano la responsabilità e l’imputabilità. Da tale impostazione discendono precise esigenze istituzionali. Anzitutto, la libertà delle forze sociali: lo Stato, per essere giusto, deve lasciare agli individui, alle famiglie e alle comunità intermedie la possibilità di vivere secondo le leggi della propria natura e delle proprie finalità specifiche, senza sostituirsi loro né occupare ogni spazio disponibile. Un ordinamento realmente democratico non coincide con lo “Stato totale” che assorbe in sé ogni funzione, ma con uno Stato che, riconoscendo la priorità della società rispetto al potere politico, si autolimita e si articola sussidiariamente, assumendo solo ciò che le forze sociali non possono da sole garantire. In secondo luogo, l’eguaglianza giuridica: nessun privilegio, positivo o negativo, può essere legittimamente fondato su razza, classe, ideologia, condizione economica, origine nazionale o appartenenza religiosa. La cittadinanza, nella sua pienezza di diritti e doveri, non tollera zone d’ombra, né “vite di scarto”, né periferie permanenti, sia sul piano interno sia nelle relazioni internazionali. In tale quadro, il rapporto tra Stato e diritto assume una funzione dirimente. Il diritto alla libertà personale – libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di associazione, di iniziativa economica nei limiti del bene comune – costituisce la prima ragione d’essere dell’ordinamento giuridico e la misura della sua giustizia. L’autorità politica è autentica solo se riconosce di essere a sua volta “sotto” la legge, e non al di sopra di essa. Quando la legge positiva si separa dalla legge morale, quando nega la dignità della persona o contraddice il bene comune, essa perde la propria forza legittimante e genera, nel cittadino, non soltanto il diritto, ma talora il dovere di resistenza non violenta, come espressione ultima della responsabilità di coscienza. In questa luce, l’obbedienza alle leggi cessa di essere cieca sottomissione e diventa adesione consapevole, verifica critica, vigilanza etica sulla qualità della vita pubblica. La partecipazione alla vita dello Stato emerge così come un dovere fondamentale. Non si tratta di un’opzione facoltativa, ma di una dimensione essenziale della moralità sociale della persona. La democrazia, infatti, non si riduce a procedura elettorale periodica, bensì è stile di governo e di convivenza, fondato sul concorso responsabile di tutti alla definizione dell’indirizzo politico, alla formazione delle leggi, al controllo dell’esercizio del potere. Ritrovare una vocazione allo Stato nella necessità di “un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale” che non si limiti alle parole: questo sogno, sul piano istituzionale, si traduce in strutture che garantiscano il diritto di tutti a partecipare – personalmente e mediante le proprie rappresentanze – alle funzioni legislative, amministrative e giudiziarie, e in un sistema di responsabilità, anche giuridica, nei confronti di chi esercita la pubblica autorità. Le libertà politiche – di espressione, di stampa, di riunione, di associazione – costituiscono, in tale orizzonte, condizioni imprescindibili di un ordine statale legittimo. Esse non sono concessioni revocabili, ma articolazioni concrete della dignità della persona e della logica del riconoscimento reciproco: là dove il dissenso è represso, la critica imbavagliata, la pluralità delle voci ridotta a mero ornamento, la vita politica si trasforma in gestione oligarchica degli interessi, e il corpo sociale viene progressivamente espropriato della propria voce. L’etica del riconoscimento, come passaggio dal misconoscimento originario alla reciprocità istituzionale, suggerisce qui un criterio esigente: la qualità democratica di uno Stato si misura dalla capacità delle sue istituzioni di trasformare il conflitto in confronto regolato, il dissenso in risorsa, la differenza in dialogo.
Libertà delle coscienze, sacrificio civico ed ethos della giustizia
La libertà delle coscienze costituisce, a sua volta, un pilastro non negoziabile dell’ordine politico. Essendo i beni spirituali primari nella gerarchia dei fini umani, la convivenza giuridica deve riconoscere ad ogni persona il diritto di aderire alla verità secondo la propria ricerca e di conformarsi, entro i limiti del bene comune, alle esigenze della propria coscienza anche quando essa, in buona fede, sia in errore. Il principio della “schietta tolleranza” in materia religiosa non nasce da relativismo indifferente, ma dalla consapevolezza che la fede non può essere imposta e che la maturità morale esige l’atto libero. Al contempo, la libertà di coscienza non può essere piegata a giustificare l’ingiustizia o la violenza: essa trova il proprio limite nella tutela effettiva dei diritti altrui e nella salvaguardia della pace sociale. Non meno rilevante è la questione dei sacrifici richiesti ai cittadini. Il contributo patrimoniale, attraverso il sistema tributario, e il sacrificio personale, fino all’eventuale difesa armata in caso di guerra davvero giusta, devono essere rigorosamente determinati dalla legge, proporzionati alle reali capacità economiche e alle necessità del bene comune, trasparenti nella loro gestione. Ogni forma di imposizione che superi tali limiti, che si fondi sull’arbitrio, su logiche di potere o su opacità amministrativa, contraddice la giustizia distributiva e incrina il patto fiduciario tra Stato e cittadini. L’uso del denaro pubblico, in particolare, emerge come banco di prova della moralità dell’autorità: la dissipazione, la corruzione, l’appropriazione indebita di risorse comuni non sono mere irregolarità tecniche, ma veri attentati alla giustizia, che colpiscono anzitutto i più deboli e minano alle radici la credibilità delle istituzioni. In questa cornice, l’attività dello Stato deve configurarsi come lotta costante contro la violenza e l’arbitrio, sia quando essi si manifestano in forme eclatanti sia quando assumono la veste più subdola di legalità apparente: norme modellate su interessi di parte, manipolazione delle procedure, concentrazione dei media, uso selettivo del diritto penale. La “cultura dei muri”, segregazione difensiva e chiusura all’alterità, può infatti replicarsi all’interno stesso dello Stato, quando si erigono barriere giuridiche e politiche per escludere intere categorie dalla piena cittadinanza o per blindare posizioni di potere, trasformando l’ordinamento in strumento di marginalizzazione anziché in garanzia di inclusione. In ultima analisi, ogni architettura istituzionale, per quanto raffinata, resta esposta al rischio di svuotarsi se non è sorretta, nei governanti come nei governati, da un ethos di giustizia e di carità. L’enciclica Fratelli tutti insiste sull’urgenza di una fraternità che si faccia stile di vita personale, sociale e politico: senza questa attitudine di apertura all’altro – allo straniero, al vulnerabile, al povero, a chi è “altro” per cultura, religione, opinione – lo Stato può diventare formalmente corretto, ma sostanzialmente ingiusto, tecnicamente efficiente ma eticamente disumano. La prospettiva del riconoscimento indica il passaggio necessario da un’idea di soggetto chiuso e autoreferenziale ad un soggetto che si comprende come “sé-nell’insieme-degli-altri”: solo uno Stato pensato e vissuto come istituzione di riconoscimento reciproco – spazio in cui le alterità si riconoscono nella loro dignità e si vincolano, per promessa, a perseguire insieme il bene comune – potrà essere all’altezza delle sfide del nostro tempo e contribuire effettivamente a quell’“amicizia sociale” che oggi appare, più che un ideale astratto, una condizione di sopravvivenza per la famiglia umana.