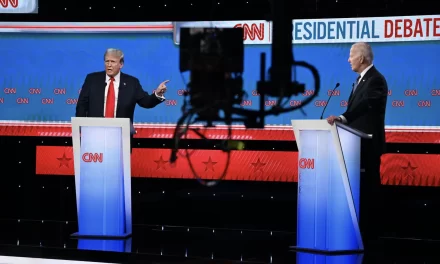Sulla frontiera dimenticata tra Thailandia e Cambogia la guerra non ha mai davvero smesso di bussare. Tregue che si sfaldano, villaggi che tremano, vite sospese nell’attesa del prossimo colpo: è il volto di un conflitto che non fa notizia ma divora ogni giorno la speranza dei più poveri. E ci ricorda che, dove la politica fallisce, il fragile mestiere della pace resta affidato solo alle mani nude della gente comune.
C’è un lembo della mappa asiatica dove il mondo sembra non aver imparato nulla. Un confine tracciato un secolo fa, durante la stagione coloniale, continua a gettare ombre lunghissime sulle vite dei poveri della terra. È la frontiera tra Thailandia e Cambogia: una linea invisibile che, da anni, si riaccende come una brace mai del tutto spenta.
Qui, nel silenzio delle risaie e dei villaggi di lamiera ondulata, la paura è diventata un’abitudine quotidiana. A Ban Phue, una stazione di servizio appena ricostruita nasconde le cicatrici di luglio: il 7-Eleven raso al suolo da un colpo di artiglieria, otto morti, quattro erano bambini. Le famiglie tornano a vivere, ma non a dormire: c’è chi tiene le valigie pronte, chi prende ansiolitici per ignorare il suono che forse non verrà, ma potrebbe.
La tregua firmata in ottobre — con tanto di benedizione diplomatica internazionale — è durata meno di un sospiro. Mine esplose sotto i piedi di soldati, accuse reciproche, droni che sorvolano il nulla più conteso del Sud-Est asiatico. Il primo ministro thailandese ha definito “terminato” il processo di pace; quello cambogiano denuncia “violenza ingiustificata”. Intanto i villaggi attendono, stringendo le mascelle.
A Surin, nell’ospedale colpito dai tiri cambogiani, il personale continua a curare senza sapere se domani ci sarà un tetto. In un’altra provincia, un’anziana signora ha già caricato la valigia in macchina: non vuole più farsi trovare impreparata come l’ultima volta, quando un obice le spazzò via la casa. E a Phum Srol, vicino al tempio di Preah Vihear, ogni parola sembra bagnata di risentimento, ogni sguardo un confine psicologico durissimo. «Non ci si può fidare dei cambogiani», dicono alcuni. E dall’altra parte del confine si ripete la stessa frase a ruoli invertiti.
La frontiera della paura funziona così: non delimita il territorio, delimita il cuore.
Più ci si avvicina alla linea, più cresce la tentazione di credere che solo la forza risolva, che l’altro sia minaccia, che la pace sia debolezza. È lo stesso meccanismo che attraversa tante altre periferie del mondo: posti dove gli Stati arrivano tardi, l’economia non arriva affatto, e il nazionalismo diventa rifugio identitario, come un’armatura contro l’instabilità.
Eppure, in questi villaggi, c’è una verità che non può essere assorbita dal rumore delle armi: gli unici a ricostruire davvero sono i poveri. Sono loro che rimettono assieme case sventrate, che portano sacchi di riso agli sfollati, che riparano un tetto in attesa di capire se servirà un’altra volta. Mentre i governi litigano sul “chi ha iniziato per primo”, la gente comune svolge il mestiere umile della pace: quello che non porta titoli, ma tiene in piedi il mondo.
La vera domanda, in fondo, non è chi ha ragione militarmente — nessuno dei due.
È un’altra: quanto può resistere un popolo quando la paura diventa routine e la vita è sospesa tra una tregua fragile e un conflitto sempre possibile?
La comunità internazionale guarda altrove, distratta da altre urgenze. Eppure, quello che accade tra Cambogia e Thailandia è un monito. Ci ricorda che i conflitti dimenticati non sono meno pericolosi di quelli visibili: sono più corrosivi. Lasciano le popolazioni in una terra di nessuno psicologica, dove la pace è sempre “quasi”, e la guerra è sempre “quasi”. Tra questi due quasi si consuma l’esistenza di chi non ha colpe e non ha voce.
L’elzeviro non offre soluzioni militari. Ma offre uno sguardo: quello sulla dignità dei semplici. Il mondo si regge sui fragili equilibri costruiti da chi non appare. Da una commerciante che riapre il suo negozio, da un contadino che distribuisce viveri ai vicini, da una figlia che chiede al padre di non dormire vicino alla finestra, “casomai ricominciassero a sparare”.
E forse è questa la domanda ultima che ci colpisce davanti alla frontiera della paura: chi si prenderà cura di questa gente?
Non i confini.
Non le mappe.
Non la geopolitica.