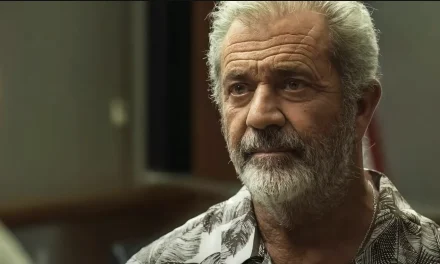Alla fine dell’estate del 2021, Greer Jarrett ha issato le vele per un viaggio nel tempo: ventisei spedizioni lungo le rotte marittime dei Vichinghi, per scoprire non solo dove approdavano, ma come navigavano. A bordo di imbarcazioni ricostruite secondo le tecniche di un millennio fa, tra venti gelidi, correnti insidiose e approdi nascosti, ha unito teoria e pratica in un’archeologia sperimentale che riscrive la geografia segreta dell’Età vichinga.
La fine dell’estate del 2021 segnò l’inizio di un’avventura che avrebbe intrecciato scienza, archeologia e salmastro. Greer Jarrett, dottorando in archeologia all’Università di Lund, si imbarcò nel primo di ventisei viaggi destinati a ripercorrere le antiche rotte marittime dei marinai norvegesi dell’Età vichinga (800–1050 d.C.). Non gli interessavano solo le mete finali, ma i percorsi, le scelte, i punti d’approdo nascosti che avevano permesso a questi navigatori di stendere la loro rete commerciale fino a Baghdad.
Per tre anni, Jarrett e i suoi equipaggi – studenti e volontari – affrontarono il cuore della navigazione norrena: la costa occidentale della penisola scandinava. Non a bordo delle leggendarie longship – navi lunghe e da guerra – ma su fyringerda 30 piedi, velieri squadrati e aperti, costruiti secondo la tradizione di Afjord, con scafi in abete rosso e giunzioni metalliche alla maniera dell’anno Mille.
Tra correnti, fallvinder e balene curiose
Gli ostacoli non mancarono: correnti di marea impetuose, incontri ravvicinati con sottomarini e balene, onde di 4 metri e improvvisi fallvinder, venti gelidi che precipitano dai fianchi delle montagne con forza da tornado. Un giorno, una collisione con un’altra imbarcazione spezzò la yard, l’antenna dell’albero. Con il mare che si scuriva e il vento in aumento, Jarrett e il suo equipaggio dovettero riparare d’urgenza, fissando le parti con una morsa da carpentiere e riprendendo la rotta verso Brettingsneset.
Fu lì che il fallvinder colpì. Il pensiero dell’acqua a 4°C e dell’ipotermia lo attraversò come un lampo, ma la paura fu domata: vela ammainata, remi pronti, barca stabilizzata. E quando, ore dopo, attraccarono sani e salvi, Jarrett sapeva che avrebbero potuto affrontare qualsiasi condizione.
I paradisi nascosti dei Vichinghi
Questo lavoro sul campo aveva uno scopo preciso: scoprire le rotte e i porti dimenticati dell’Età vichinga. Non grandi città come Bergen o Dublino, ma piccoli “paradisi” nascosti su isole e penisole remote, zone di transizione tra il mare aperto e i fiordi. Jarrett ne identificò quattro, mai documentati prima, luoghi che offrivano acqua dolce, riparo e un punto d’osservazione. Spazi sicuri, raggiungibili con varie condizioni meteo, in cui i marinai potevano rifornirsi, scambiare merci o semplicemente aspettare che passasse la tempesta.
Per individuarli, Jarrett combinò osservazioni dirette, racconti dei pescatori locali e modellazioni digitali della costa norvegese com’era mille anni fa. Il rimbalzo isostatico aveva mutato profondamente il paesaggio: alcuni rifugi oggi emersi erano allora sotto il mare.
Archeologia sperimentale in alto mare
Le conclusioni, pubblicate sul Journal of Archaeological Method and Theory, ribaltano un pregiudizio diffuso: i Vichinghi non si limitavano alla navigazione costiera, ma affrontavano tratti di oceano aperto più spesso di quanto si pensasse. La loro abilità non stava solo nella robustezza delle navi, ma nella coesione degli equipaggi e nella conoscenza fine dei venti, delle correnti e dei segni del cielo.
Per Jarrett, ogni miglio percorso in fyringer è stato un ponte gettato verso quei marinai di un millennio fa. Non un esercizio romantico, ma un metodo per capire il passato con il corpo, non solo con la mente: sentire il rollio, annusare l’odore della pece e del legno bagnato, misurare la distanza con la sola vista e il cuore.
E, come un esploratore che chiude il diario di bordo al tramonto, lascia ai posteri una lezione: la storia non vive solo nei libri, ma anche nelle mani callose e negli occhi salati di chi osa riviverla.
dal New York Times