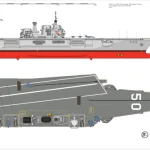Il 2 agosto, ancora una volta, il suono delle sirene e il silenzio delle coscienze oneste ha rotto il ritmo di un’estate distratta. Sono passati 45 anni dall’esplosione alla stazione di Bologna che spezzò la vita di 85 persone e ne ferì oltre 200. Una strage neofascista, come ha riconosciuto con nettezza la Cassazione nell’ultima sentenza del primo luglio scorso, che ha aggiunto al novero dei colpevoli materiali Paolo Bellini e ha confermato, anche per via giudiziaria, i mandanti e i protettori: loggia P2, apparati deviati dello Stato, eversori neri. Non è più solo memoria: è verità storica e giudiziaria.
Eppure la battaglia delle parole è tutt’altro che chiusa. La commemorazione è stata attraversata dall’ennesima polemica, questa volta tra Paolo Bolognesi – presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime – e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A riaccendere lo scontro, le parole di Bolognesi: «Le radici di quell’attentato affondano nella storia del postfascismo italiano. Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale oggi figurano a pieno titolo nella destra italiana di governo». Una constatazione sostenuta dalle sentenze, ma che ha provocato la dura replica della premier, secondo cui tali parole costituirebbero persino un pericolo per l’“incolumità personale” dei rappresentanti istituzionali. Una reazione che ha lasciato sgomenti: rovesciare il ruolo tra vittime e potere è sempre un’operazione pericolosa.
Lo ha ricordato anche il presidente Mattarella, con parole limpide: la strage fu frutto «di una spietata strategia eversiva neofascista nutrita di complicità annidate in consorterie sovversive». Quelle complicità, come ha ricostruito la Commissione Anselmi, andavano ben oltre la manovalanza dei Nar e si infilavano nei gangli dello Stato, tra i finanziamenti della P2, le coperture dei Servizi, i depistaggi istituzionali e persino due segreti di Stato apposti da Spadolini e Craxi.
Tutto questo non è passato. Nomi, simboli, legami sono oggi parte del presente: la fiamma nel simbolo di Fratelli d’Italia non è un refuso araldico; è un richiamo esplicito. Gli eredi di quelle trame nere siedono in Parlamento e in Governo. E se si dice che quelle radici oggi fanno parte della destra al potere, si dice un fatto. Negarlo non è diritto di difesa, ma tentativo di revisionismo. E tentare di riscrivere la storia per via parlamentare – come vorrebbe chi propone l’ennesima Commissione sugli “anni di piombo” per riesumare la pista palestinese – è una forzatura tanto grave quanto già sconfessata dai tribunali.
Nel contesto di questa battaglia di memoria e verità si iscrive anche la storia della strage dell’Italicus, avvenuta esattamente dieci anni prima, il 4 agosto 1974: 12 morti, 50 feriti. Allora furono incriminati tre esponenti del Fronte Nazionale Rivoluzionario toscano – Tuti, Melentacchi, Franci – tutti poi assolti. Ma solo 48 ore dopo quelle incriminazioni, un’altra bomba – quella di Bologna – alzava la soglia dell’orrore a un livello mai visto. Non fu un caso: fu un messaggio. Il romanzo nero della Repubblica non si interrompe lì: dal treno deragliato a Gioia Tauro nel 1970 all’Italicus, dal Rapido 904 alla strage del rapido Palermo-Milano nel 1983, il filo rosso delle bombe attraversa i binari come le piazze.
I protagonisti sono spesso gli stessi: Mambro, Fioravanti, Ciavardini, Cavallini. E i mandanti pure: Gelli, Ortolani, D’Amato, Tedeschi. La verità storica non si ferma alle condanne. Prosegue nelle coperture, nei falsi, come quello di Giorgio Almirante che, 19 giorni prima dell’attentato all’Italicus, tentò di indirizzare i sospetti verso gruppi di sinistra extraparlamentare. Anche quella è storia, anche se a Palazzo Chigi – pochi mesi fa – qualcuno ha pensato bene di inserire Almirante tra i “padri della patria”, salvo poi cancellare in fretta il post.
Ecco allora che, di fronte al tentativo di ridurre tutto alla formula anodina del “terrorismo”, occorre ribadire ciò che la verità – quella delle sentenze e quella delle coscienze – ha già accertato: fu terrorismo neofascista, con complicità interne. Farlo non è una forma di ostilità ideologica, ma un atto di responsabilità democratica. Non si tratta di “fare la vittima”, come ha detto polemicamente Bolognesi a Meloni, ma di non prenderle in giro. Le ferite della Repubblica non si rimarginano col silenzio o con l’equilibrismo delle formule.
La Dottrina sociale della Chiesa ci insegna che la verità è fondamento della giustizia, e la giustizia è il presupposto della pace. Pacem in veritate – la pace nella verità – diceva Benedetto XVI. Non si costruisce futuro se si annaffiano ancora oggi le radici velenose di un passato mai reciso. Per questo, come ha detto il cardinale Zuppi, non basta condannare l’atto: bisogna rompere le complicità. E la Chiesa, in questa memoria ferita, non può tacere. Come Silver Sirotti, il ferroviere morto per salvare i passeggeri dell’Italicus, anche noi dobbiamo essere sentinelle della coscienza pubblica. Perché ogni volta che si nasconde la verità sotto la polvere dell’oblio, la democrazia rischia di deragliare