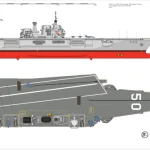Esiste un modo diverso per assicurare la sicurezza e la difesa alla Patria?
C’è una parola che ritorna, con una certa esitazione, nel dibattito strategico occidentale: aggiornamento. Non riforma, che promette discontinuità ordinate, né rivoluzione, che evoca rotture salvifiche, ma qualcosa di più silenzioso e per questo più impegnativo. Aggiornare significa riconoscere che ciò che ha funzionato non funziona più allo stesso modo; che le categorie con cui si è vinta una guerra non bastano a evitarne un’altra; che il mondo non aspetta chi resta prigioniero della propria memoria. È in questo orizzonte che va letta, insieme, la discussione americana sul “nuovo servizio” e quella europea sul riarmo: due risposte diverse a una stessa crisi di transizione dell’Occidente.
Negli Stati Uniti la diagnosi è ormai esplicita, talvolta brutale. L’esercito, così come è strutturato, mostra segni di affaticamento. Non per carenza di risorse o di tecnologia, ma per una frattura più profonda: quella tra società e difesa. La sicurezza nazionale, un tempo esperienza diffusa e quasi naturale, è diventata materia specialistica, delegata a un corpo sempre più ristretto di cittadini in uniforme. Il dato simbolico è noto: la percentuale di veterani è crollata, il servizio militare non è più un passaggio comune, l’immaginario collettivo si è allontanato dalla realtà delle forze armate. Quando il servizio diventa eccezione, la difesa perde radicamento democratico.
È in questo vuoto che emergono figure nuove, lontane dal patriottismo classico ma non per questo disimpegnate. Giovani che non scelgono necessariamente l’uniforme, eppure non rinunciano all’idea di servire il Paese. Lo fanno attraverso la tecnologia, l’industria, l’innovazione applicata alla difesa. È un patriottismo operativo, privo di retorica, che nasce dall’incontro tra competenze civili e necessità strategiche. Non vogliono “fare carriera nella guerra”, ma evitare che la guerra arrivi perché l’apparato è rimasto inadeguato.
Qui si manifesta il nodo dell’aggiornamento americano. La guerra del XXI secolo non è più – o non è solo – questione di trincee, divisioni corazzate e superiorità numerica. È una guerra di sistemi: droni autonomi, intelligenza artificiale, cyberattacchi, spazio, catene logistiche vulnerabili, capacità industriale di sostenere sforzi prolungati. In questo scenario il soldato resta decisivo, ma non è più l’unico attore. Servono programmatori, ingegneri, analisti, progettisti. Servono menti capaci di pensare in termini di architetture complesse, non soltanto di comando e controllo.
L’America lo sa, ma fatica ad accettarne tutte le conseguenze. Da un lato investe somme enormi nella tecnologia della difesa; dall’altro mantiene un’idea di servizio ancora legata a un ethos esclusivo, quasi identitario, che restringe l’accesso invece di ampliarlo. La contraddizione è evidente: mentre il tessuto tecnologico e industriale privato si mostra disponibile a contribuire, l’apparato pubblico resta prigioniero di una definizione novecentesca del servizio. Il risultato è un esercito potente ma isolato, ricco ma culturalmente distante dalla società che dovrebbe difendere.
Ed è qui che il discorso americano incrocia quello europeo. L’Europa parla oggi di riarmo, di autonomia strategica, di industria della difesa comune. Lo fa spesso in tono emergenziale, sospinta dalla guerra in Ucraina e dalla scoperta della propria vulnerabilità. Ma il rischio è analogo: pensare il riarmo come accumulo di mezzi, non come aggiornamento di visione. Senza una ridefinizione del rapporto tra società, industria e difesa, il riarmo rischia di essere tecnicamente imponente ma politicamente fragile.
L’esperienza americana offre dunque una lezione indiretta all’Europa. Non basta aumentare la spesa militare se la difesa resta percepita come corpo estraneo. Non basta produrre armamenti se manca una cultura condivisa del servizio pubblico. Non basta invocare la sicurezza se non si chiarisce per chi e per che cosa si è disposti a servire. In una democrazia, la difesa non è solo deterrenza: è legame civico.
A complicare ulteriormente il quadro è il rapporto ambiguo con il settore privato. Negli Stati Uniti la Silicon Valley entra sempre più apertamente nel mondo della difesa, portando capitali, innovazione, velocità. Ma porta anche interessi, asimmetrie, nuove dipendenze. Il caso delle infrastrutture strategiche affidate a soggetti privati ha reso evidente un punto critico: quando la sicurezza dipende dal mercato, la sovranità operativa diventa negoziabile. L’Europa, che sta costruendo la propria industria della difesa, dovrà affrontare lo stesso dilemma.
Aggiornarsi significa allora anche questo: ridefinire i confini tra pubblico e privato, tra interesse nazionale e mercato globale, tra efficienza e responsabilità. È un lavoro lento, che richiede istituzioni solide, regole chiare, una visione di lungo periodo. E soprattutto richiede una nuova narrazione del servizio: non più soltanto sacrificio armato, ma contributo differenziato; non più solo obbedienza, ma competenza; non più soltanto eroismo, ma affidabilità.
In fondo, ciò che emerge su entrambe le sponde dell’Atlantico è la stessa domanda di fondo: come difendere società complesse senza tradirne i valori? Come prepararsi alla guerra senza normalizzarla? Come investire nella forza senza perdere il senso del limite? L’aggiornamento necessario non è solo tecnologico o organizzativo. È antropologico e politico. Riguarda l’idea stessa di cittadinanza.
Se l’America ha oggi la possibilità – rara – di ripensare il proprio modello di servizio in tempo di pace, l’Europa ha l’urgenza di farlo sotto pressione. Ma entrambe condividono una responsabilità storica: dimostrare che la sicurezza può essere compatibile con la democrazia e che il servizio, anche quando non indossa un’uniforme, resta una forma alta di appartenenza. Senza questo aggiornamento profondo, il riarmo rischia di restare solo rumore di fondo. E la potenza, senza una comunità che la riconosca come propria, rimane fragile.