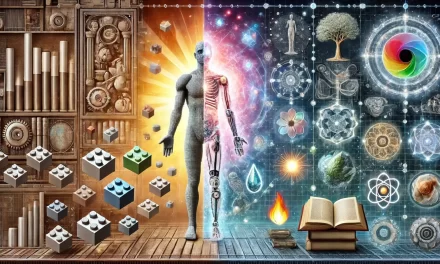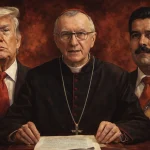Tra liste d’attesa infinite, costi crescenti e personale insufficiente, quasi un decimo della popolazione ha rinunciato a una prestazione sanitaria. Una crisi silenziosa che mette in discussione la giustizia sociale e la dignità del sistema pubblico.
C’è un’Italia che non arriva al medico. È l’Italia che si scoraggia davanti a mesi di attesa per una visita, o che non può permettersi di pagare quella stessa visita nel privato. È l’Italia delle rinunce: secondo i dati Istat e Cnel, oltre cinque milioni e mezzo di cittadini – quasi sei milioni – hanno rinunciato nel 2024 ad almeno una prestazione sanitaria.
Dietro questa cifra asciutta si nasconde un dramma collettivo, un dolore che non fa rumore ma logora lentamente il tessuto civile del Paese. Perché quando la salute diventa un lusso, anche la democrazia si ammala.
Il sintomo di un sistema esausto
Non si tratta solo di tempi d’attesa troppo lunghi, sebbene questi restino la causa principale. Si tratta di un sistema pubblico in affanno, impoverito da anni di sottofinanziamento e di fuga del personale.
Le Regioni ammettono di non riuscire più a garantire i livelli essenziali di assistenza; gli ospedali scivolano in cronica carenza di infermieri e medici; gli ambulatori territoriali, spesso deserti, non riescono a fare da filtro.
E così, la rinuncia alle cure diventa una scelta forzata, un meccanismo di autodifesa di chi non sa più dove rivolgersi. In alcuni territori del Sud, secondo le analisi, la percentuale dei rinunciatari sfiora il 15%. Un numero che racconta più di mille parole sulla frattura sanitaria tra Nord e Sud.
Il peso delle disuguaglianze
Dietro le statistiche, ci sono storie. L’anziano che rimanda la visita cardiologica perché “tanto sto meglio”, la madre sola che rinuncia al dentista per pagare i libri ai figli, il giovane precario che aspetta mesi per una risonanza.
Il diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione, rischia di diventare un diritto a metà, valido solo per chi può permetterselo.
E questo è moralmente intollerabile. Un Paese che lascia indietro i fragili, gli anziani, i poveri, tradisce la sua stessa Costituzione. Lo ha ricordato anche la Conferenza Episcopale Italiana: “la salute è un bene comune, non un privilegio”.
Un’emergenza politica, non solo sanitaria
La rinuncia alle cure non è un problema “del settore”, ma un fallimento di sistema. Significa che le politiche pubbliche non stanno più garantendo l’universalità del Servizio sanitario nazionale, uno dei pilastri morali e civili dell’Italia repubblicana.
Il governo ha la responsabilità di invertire questa rotta. Non bastano slogan o bonus una tantum: servono investimenti strutturali, personale stabile, un piano di recupero delle liste d’attesa e un sistema di monitoraggio reale, trasparente.
Perché quando sei milioni di persone rinunciano alle cure, non è un problema tecnico. È una ferita sociale. Ed è troppo grave per essere gestita con silenzi o scaricabarile tra Stato e Regioni.
Un grido che interpella la coscienza
Non possiamo abituarci a pensare che “qualcuno” debba rinunciare. Ogni rinuncia è una sconfitta collettiva.
Papa Francesco, nell’udienza ai medici cattolici del 2023, ammoniva: “Curare non è solo guarire il corpo, ma prendersi cura della persona nella sua totalità. Non può esserci cura se c’è esclusione.”
Ecco perché la questione sanitaria non riguarda solo il governo, ma ogni cittadino, ogni comunità, ogni diocesi. Le Caritas parrocchiali raccontano quotidianamente di famiglie che chiedono aiuto per esami, farmaci o trasporti verso gli ospedali. È la fotografia di un Paese che, senza volerlo, sta tornando indietro di trent’anni.
Il dovere della speranza
Ci sono, però, anche segni di reazione: medici volontari che riaprono ambulatori nei quartieri popolari, associazioni che accompagnano gli anziani alle visite, diocesi che promuovono fondi sanitari solidali.
Sono piccoli gesti, ma indicano la direzione giusta: ricostruire la prossimità. La sanità non può essere solo un bilancio, ma una forma di fraternità civile.
Occorre un “Piano per la dignità della cura”, con investimenti vincolati e tempi certi, ma anche con una visione etica: rimettere al centro la persona, non la spesa.
Quando milioni di italiani rinunciano a curarsi, non è solo la sanità a essere malata, ma la giustizia sociale.
Questa emergenza è troppo grave per il governo, perché mette in questione la credibilità stessa dello Stato. Ma è anche un’occasione per riscoprire la vocazione originaria del nostro sistema: essere la casa di tutti, specialmente dei più fragili.
La vera riforma della sanità italiana inizierà solo quando torneremo a chiederci — come faceva don Milani — “di chi è la colpa se l’ultimo resta indietro?”
«E ne ebbe compassione, perché erano come pecore senza pastore» (Mc 6,34).
Gesù non passa oltre chi soffre. Si ferma, ascolta, tocca, guarisce. La compassione è il primo atto della cura, quella che nasce dal cuore e non dai bilanci.
Quando milioni di persone rinunciano alle cure, non è solo la salute che viene meno: è la compassione che si spegne nel corpo di una nazione.
Essere cristiani, oggi, significa ridare volto umano alla sanità: non lasciare nessuno solo nella malattia, non permettere che la povertà diventi una condanna biologica.
La Chiesa non ha ambulatori ovunque, ma ha ancora il potere di guarire le coscienze: ricordando che ogni vita, anche la più fragile, è degna di essere curata — e amata.