Dai femminicidi ai nuovi abusi psicologici e digitali, la violenza che nasce dal bisogno di possesso
Dall’inizio dell’anno, in Italia, sono già una cinquantina le donne uccise da uomini che non hanno accettato la libertà dell’altra. Ma la violenza non comincia col coltello: inizia molto prima, nelle parole, nei ricatti emotivi, nell’umiliazione pubblica e digitale. Oggi, oltre ai femminicidi, si diffondono nuove forme di aggressione invisibile — dal revenge pornalla denigrazione sociale dell’ex — che devastano vite, reputazioni e famiglie. È il segno di un analfabetismo affettivo e spirituale che attraversa uomini e donne, e che interpella la coscienza collettiva.
C’è qualcosa di agghiacciante e insieme tristemente ripetitivo nel delitto di Pamela Genini (29 anni), uccisa a Milano nella tarda serata del 14 ottobre 2025 dal compagno Gianluca Soncin (52 anni), incapace di accettare la fine della loro relazione.
Dietro la cronaca di sangue, emerge la fragilità affettiva di un tempo in cui la libertà dell’altro viene vissuta come offesa personale, e l’amore si trasforma in dominio.
Il femminicidio non nasce mai da un raptus improvviso: è il punto d’arrivo di un processo di violenza progressiva, quasi sempre iniziato molto prima, fatto di controllo, isolamento, minacce, disprezzo, ricatti emotivi. È un amore che si ammala perché non conosce la differenza tra il dono e il possesso.
Gli psicologi parlano di profili ricorrenti: il narcisista, che si specchia nell’altro e non tollera di non essere ammirato; l’ossessivo, che vuole possedere ciò che ama; il paranoico, che trasforma la persona amata in un nemico da neutralizzare.
Sono disturbi della personalità che nascondono paure profonde: l’abbandono, la solitudine, la perdita di controllo.
Il maltrattante, prima di essere violento, è spesso un analfabeta affettivo incapace di gestire la frustrazione del limite.
Ma l’analfabetismo affettivo è un male diffuso, che non riguarda solo gli uomini.
Perché oggi la violenza non si manifesta soltanto con le mani, ma anche con le parole e le reti sociali.
C’è chi, dopo una rottura, non accetta di elaborare il dolore e cerca di “distruggere” l’altro — moralmente, pubblicamente, socialmente.
È una forma di vendetta che prende nuove strade: il revenge porn, cioè la diffusione di immagini intime senza consenso; o l’umiliazione diffusa, quando un ex partner — uomo o donna — delegittima l’altro presso le persone che lo stimano: amici, colleghi, superiori, familiari, parrocchia, cerchie professionali.
Si tratta di un vero e proprio omicidio simbolico della reputazione, che ferisce la dignità e la stabilità psicologica della vittima.
È un modo sottile, ma devastante, di esercitare potere: “se non posso averti, ti tolgo la stima degli altri”.
Sono forme di violenza psicologica e relazionale che la nostra società tende ancora a sottovalutare.
Non lasciano lividi visibili, ma scavano nel profondo, generando ansia, vergogna, isolamento.
Molte vittime finiscono per interiorizzare la colpa, fino a dubitare della propria percezione della realtà.
Il gaslighting, la manipolazione, la denigrazione pubblica: tutto questo distrugge lentamente l’identità dell’altro, rendendolo dipendente dal giudizio del carnefice.
Ma in questa analisi va detto anche che non tutte le violenze partono da un solo lato.
Ci sono uomini che aggrediscono fisicamente, e ci sono donne che aggrediscono psicologicamente: con umiliazioni, sarcasmi, screditamento dell’identità maschile.
Riconoscere questa reciprocità non serve a giustificare i carnefici, ma a curare le radici del male: la relazione tossica che nasce quando l’amore diventa possesso o competizione.
La parola femminicidio, come insegnava Diana Russell, non indica solo un atto criminale, ma un sistema culturale di dominio, un linguaggio che autorizza la sopraffazione.
Eppure, anche il linguaggio pubblico contemporaneo rischia di diventare ideologico, contrapponendo uomini e donne in uno schema di colpe e vittimismi.
In realtà, il femminicidio — come tutte le forme di violenza — nasce da un fallimento antropologico, non solo da un disordine sociale: è l’incapacità di vivere la reciprocità come dono, non come minaccia.
Papa Francesco ha ricordato più volte che “l’amore non possiede, ma libera”.
Il contrario dell’amore non è l’odio, ma il controllo.
Chi non sa accettare la libertà dell’altro è destinato a distruggere anche la propria.
Dietro ogni delitto di questo tipo c’è una mancanza di educazione emotiva e spirituale, che si può colmare solo con un lavoro culturale profondo: educare alla tenerezza, alla gestione del rifiuto, al rispetto dei confini.
Serve una pedagogia dell’affettività, da insegnare sin da piccoli.
Le scuole, le famiglie, le comunità cristiane devono aiutare a distinguere tra l’amore come dono e l’amore come dominio.
E la società deve imparare a riconoscere le forme invisibili di violenza — quelle psicologiche, digitali, verbali — che preparano il terreno ai gesti estremi.
Ogni donna uccisa è una sconfitta collettiva.
Ma anche ogni uomo che non trova aiuto per gestire la rabbia o l’angoscia dell’abbandono è una bomba innescata.
La cura passa attraverso la relazione sana, il perdono, la libertà.
Perché la violenza comincia nel momento in cui smettiamo di dire “tu” e iniziamo a dire “mia”.










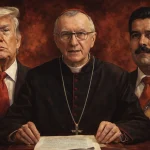








È raro che qualcuno parli con questa chiarezza e competenza. Mi ha molto aiutato quest’articolo a capire una relazione tossica.