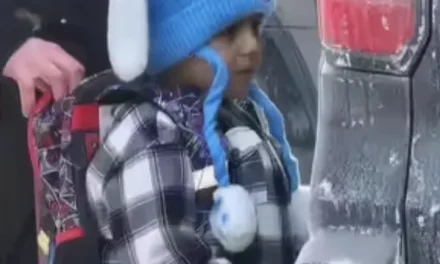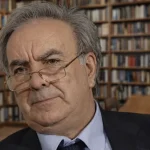Il diciannovesimo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia, annunciato dalla Commissione il 19 settembre, porta con sé l’ennesima stretta: navi “fantasma” nel mirino, criptovalute, banche di Paesi terzi e soprattutto un’accelerazione sulla fine delle importazioni di gas naturale liquefatto russo, da chiudere entro il 2026. Bruxelles rivendica la misura come un passo avanti decisivo verso l’autonomia energetica. Ma a ben vedere, il costo politico ed economico di questa strategia rischia di ricadere in gran parte sull’Europa stessa.
Un’Europa più esposta
Oggi l’Ue importa ancora il 13% del suo fabbisogno di gas da Mosca, circa 36 miliardi di metri cubi l’anno. Tagliare questa quota nell’arco di appena quindici mesi significherà riorientare forniture, stringere nuovi contratti di GNL e affrontare costi più elevati. Gli Stati Uniti, già diventati il primo fornitore europeo, non nascondono la loro soddisfazione: ogni riduzione del gas russo apre più spazio al loro GNL, con contratti a lungo termine che le utility europee faticano a rifiutare.
Il presidente Trump è stato esplicito: lo stop anticipato al gas e al petrolio russi è una condizione politica per il sostegno Usa alle nuove sanzioni. Risultato: Washington rafforza il proprio peso sul mercato energetico europeo e incassa un dividendo strategico, mentre Bruxelles deve gestire una transizione più rapida e costosa di quanto programmato.
Avarizia di strumenti, generosità di impegni
Sul fronte finanziario, il nuovo meccanismo per utilizzare gli asset russi congelati — circa 300 miliardi di euro, due terzi dei quali parcheggiati in Europa — sembra una soluzione ingegnosa: prestiti immediati a Kiev con la garanzia che verranno ripagati al termine della guerra attraverso le future riparazioni russe. Ma anche qui il peso dell’operazione cadrà inizialmente sugli Stati membri europei, che dovranno esporsi con nuove risorse e assumersi il rischio politico di toccare capitali bloccati ma non ancora confiscati.
Gli Stati Uniti, che hanno immobilizzato somme minori, partecipano all’iniziativa con entusiasmo: il grosso dell’onere resta sulle spalle dell’Europa, mentre Washington capitalizza il risultato politico.
Il nodo irrisolto
Il paradosso è evidente: l’Unione europea, più vicina geograficamente al conflitto e già colpita da un rallentamento economico, porta avanti un pacchetto di sanzioni che indebolisce Mosca ma, nel breve termine, erode la propria competitività. L’America, al contrario, vede crescere le esportazioni di GNL, consolida l’influenza strategica sull’energia europea e limita la propria esposizione finanziaria.
La domanda che rimane aperta è se l’Ue, in questa dinamica, stia giocando da protagonista o da comprimaria. Le sanzioni sono uno strumento politico necessario per contrastare l’aggressione russa, ma senza un chiaro piano industriale ed energetico condiviso, il rischio è che l’Europa finisca per pagare due volte: per finanziare la difesa di Kiev e per assicurarsi la sopravvivenza economica.