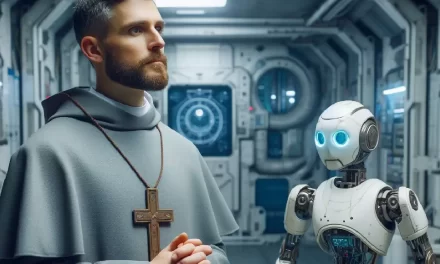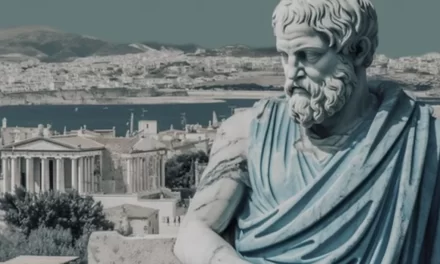Dalle voci transofobe su Brigitte Macron alle campagne diffamatorie contro il Papa, il meccanismo è sempre lo stesso: la menzogna si traveste da verità, la devozione da ideologia. Nel tempo dell’algoritmo del sospetto, non basta tacere: occorre replicare con giustizia, per non lasciare che la fede e la dignità vengano travolte dall’odio digitale. Anche nella Chiesa, dove la parola dovrebbe essere sacramento di comunione, la sfida è imparare a parlare con carità e verità, perché il silenzio, oggi, può essere la forma più pericolosa della complicità.
L’algoritmo del sospetto
Il recente caso Brigitte Macron — con dieci internauti processati per aver diffuso la falsa voce secondo cui la Première Dame sarebbe una persona trans — mostra quanto sia pericolosa la fabbrica digitale della menzogna.
Una calunnia, nata negli ambienti complottisti dell’estrema destra nel 2017, è riuscita a sopravvivere per anni, rilanciata da algoritmi che favoriscono il contenuto virale, non quello vero.
Ogni smentita, come spesso accade nel web tossico, è diventata una “prova” in più.
È il paradosso del nostro tempo: la falsità si auto-alimenta, perché ciò che scandalizza produce attenzione, e ciò che divide genera profitto.
Ma ciò che colpisce in questa vicenda è l’analogia con fenomeni che attraversano anche il mondo cattolico.
La stessa dinamica di sospetto, di vittimismo e di odio travestito da zelo si è vista in certi ambienti religiosi radicalizzati — dove la difesa della “pura fede” ha assunto i tratti di una cultura della diffamazione sistematica.
Quando il complotto entra in sagrestia
Negli ultimi anni, alcuni gruppi pseudo-tradizionalisti hanno fatto dei blog e dei social network i propri pulpiti, diffondendo voci, sospetti e accuse contro Papa Francesco, vescovi, commissari apostolici e religiosi fedeli alla Chiesa.
Un caso emblematico è quello dei Frati Francescani dell’Immacolata, dove, dopo il commissariamento canonico dell’Istituto, si è scatenata una contro-informazione ideologica volta a screditare l’autorità ecclesiale e i religiosi obbedienti al Magistero.
Secondo fonti attendibili, il fondatore sotto inchiesta, P. Stefano Manelli ha fatto diffondere in rete, con la complicità di sodali, un racconto tossico, accusando Roma di persecuzione e i frati fedeli al Papa di tradimento.
In questi ambienti, l’algoritmo della menzogna ha funzionato come un catechismo parallelo: blog, canali Telegram e siti “di difesa della verità” hanno generato milioni di visualizzazioni alimentando una faith-based outrage industry, una “industria della collera religiosa”.
Con il linguaggio del martirio e del tradimento, questi comunicatori hanno costruito un racconto semplice e tossico: noi perseguitati, loro eretici.
Un copione che coincide, nei meccanismi psicologici, con quello che ha colpito Brigitte Macron: creare un mito vittimario, produrre una comunità di “iniziati” e rendere la menzogna una forma di appartenenza.
Oggi l’epilogo parla da sé: P. Manelli è uscito dall’ordine da lui stesso fondato, i suoi seguaci più radicali e i giornalisti in pensione sono stati sconfessati. La lezione è semplice: quando la verità viene sostituita dall’ideologia, anche i fondatori finiscono per perdere ciò che volevano salvare.
I Frati Francescani dell’Immacolata, al contrario, in “vera” povertà e letizia stanno ricostruendo il loro cammino di fedeltà e obbedienza.
I blog come teologie dell’odio
Dal punto di vista mediologico, il problema non è solo morale: è strutturale.
Ogni piattaforma premia l’interazione, non la qualità.
La logica della disintermediazione — chiunque può pubblicare tutto — ha eliminato i filtri di verifica e di responsabilità.
E così, dentro la Chiesa come nella società, si moltiplicano i “profeti digitali”, spesso in cattiva fede, che usano il linguaggio della fede per esercitare potere e creare divisione.
Sono i teologi dell’odio, che manipolano simboli e dogmi come altri manipolano le notizie politiche.
La loro forza non è la credibilità, ma la quantità di clic.
La menzogna diventa “verosimile” perché risuona con ciò che molti vorrebbero credere.
Per questo, anche quando l’epilogo dei fatti smentisce i protagonisti — come nel caso Manelli e dei suoi seguaci, oggi apertamente sconfessati dalla Santa Sede e da gran parte dei frati rimasti fedeli al Papa — la rete conserva la loro eco come se nulla fosse accaduto.
Le teorie del complotto, come dice Tristan Mendès, sono teorie-zombie: non muoiono mai, ma tornano a vivere quando c’è paura e ignoranza.
Reagire senza scendere al livello del fango
Come reagire, allora, di fronte alla disinformazione e alla calunnia?
Il primo errore è pensare che basti tacere.
Nel mondo degli algoritmi, il silenzio non cancella: lascia spazio al falso.
La replica, quando è documentata, sobria e veritiera, diventa un atto di giustizia e di dignità.
Difendere la verità non è un gesto d’orgoglio, ma una forma di carità verso chi ascolta, per non lasciare che i semplici siano ingannati da falsi maestri.
È necessario spiegare, contestualizzare, formare.
Non rispondere con la stessa rabbia, ma restituire la complessità.
Non basta dire “è falso”: occorre mostrare come e perché è falso, e come funziona la manipolazione digitale.
L’unica vera risposta è un’educazione al dubbio sano, che insegni a distinguere la ricerca della verità dal sospetto patologico.
La responsabilità cristiana della parola
Per la fede cristiana, la parola è sempre un atto morale.
Ogni click è una scelta di mondo.
E nel tempo delle “verità multiple”, il compito del comunicatore cristiano non è difendere un partito ecclesiale, ma custodire la comunione.
Riflettere sul caso Macron e sulle derive religiose non significa paragonare, ma riconoscere lo stesso virus: la perversione della comunicazione, che trasforma la parola in arma e la fede in fazione.
Il compito della Chiesa — e dei giornalisti di ispirazione cristiana — è oggi questo:
riportare la comunicazione al suo fine originario, che è la relazione;
insegnare che la verità non ha bisogno di urla;
e ricordare che la replica, quando nasce dall’amore per la giustizia, è la forma più alta della carità intellettuale.
C’è una frase di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, che oggi suona come un test per tutti noi:
“La lingua non deve mai parlare contro il cuore.”
Nel tempo dei blog e delle piattaforme, potremmo tradurla così: “scrivere senza ferire, pubblicare senza diffamare, replicare per guarire”.
È questa la vera rivoluzione cristiana della comunicazione: non tacere la verità, ma dirla con amore — anche quando costa.