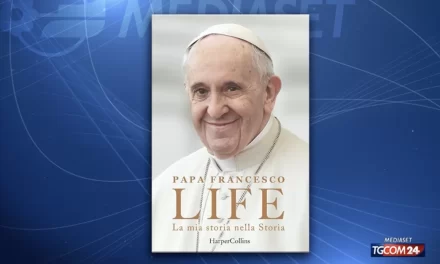Alla fine, il “mondo intero” è davvero passato da Roma. Non per un congresso, non per un vertice, non per un grande evento spettacolare, ma per una Porta. I numeri del Giubileo della Speranza 2025 – oltre trentatré milioni di pellegrini da centottantacinque Paesi – impressionano, ma non spiegano. I numeri contano, certo, ma non raccontano ciò che è accaduto davvero in questo anno santo che si chiude con un gesto antico: una porta che si richiude lentamente.
Roma, in questi mesi, non è stata solo una città sovraffollata. È stata una soglia. Una città attraversata più che visitata. Un luogo in cui milioni di persone non sono venute a “vedere”, ma a lasciarsi cambiare, anche solo per un istante. Lo ha detto con sobrietà monsignor Rino Fisichella, tracciando il bilancio ufficiale: più confessioni, più preghiera, più desiderio di conversione. Parole che oggi, in un tempo di spiritualità spesso ridotta a emozione privata, suonano quasi controcorrente.
Il Giubileo non si è imposto con clamore. Ha lavorato in profondità. Ha fatto ciò che la Chiesa sa fare quando è fedele a se stessa: non occupare lo spazio, ma abitare il tempo. Non gridare risposte, ma offrire cammini. È per questo che i grandi eventi – pur numerosi – non sono stati il cuore dell’Anno Santo. Il cuore è stato un popolo in movimento, silenzioso e ostinato, che ha riempito basiliche, santuari, confessionali, senza fare rumore.
Colpisce che tutto questo sia avvenuto in un’epoca segnata da individualismo e frammentazione. Eppure, proprio qui sta la forza del Giubileo: ricordare che l’uomo non si salva da solo, e che la speranza non è un sentimento vago, ma un’esperienza condivisa. Spes non confundit, la speranza non delude: non perché elimina il dolore, ma perché lo attraversa insieme.
C’è poi un altro aspetto, meno spirituale ma non meno eloquente: quello che è stato chiamato il “metodo Giubileo”. Un’espressione apparentemente tecnica, che in realtà dice molto. Amministrazioni che coordinano senza dominare, istituzioni che collaborano senza competere, responsabilità condivise senza protagonismi. È raro, oggi, vedere la macchina pubblica mettersi al servizio di qualcosa che non sia il proprio tornaconto. Eppure è accaduto. Come se, per una volta, anche la politica avesse accettato di fare un passo indietro per lasciare spazio all’essenziale.
Roma non ne è uscita impoverita, come qualcuno temeva, ma trasformata. I pellegrini non hanno sottratto nulla alla città: le hanno restituito un’anima che a volte rischia di perdersi sotto il peso del turismo e dell’abitudine. La pazienza dei romani, l’accoglienza reciproca, l’esperienza di Tor Vergata con i giovani resteranno come una memoria condivisa, non solo ecclesiale.
E poi c’è la parola del Papa, Leone XIV, che in questi giorni ha dato la chiave interpretativa più profonda. La speranza cristiana non nasce da previsioni ottimistiche, ma dall’incarnazione. Dio che entra nella carne dell’uomo. Dio che non osserva da lontano, ma cammina dentro la storia. Da qui discende tutto: una fede incarnata, non astratta; una spiritualità che non fugge il mondo; un impegno verso l’uomo che non è opzionale, ma necessario.
Quando la Porta Santa si chiuderà, il Giubileo non finirà davvero. Finirà un tempo liturgico, ma resterà una domanda aperta: che cosa fare della speranza ricevuta? Perché una Porta serve a poco se non cambia la direzione del cammino.
Forse il senso ultimo di questo Anno Santo sta proprio qui: aver ricordato, in un mondo stanco e ferito, che la speranza non è evasione, ma responsabilità. E che ogni volta che il mondo passa da una Porta, qualcosa di esso resta dentro. E qualcosa di nuovo, silenziosamente, comincia.