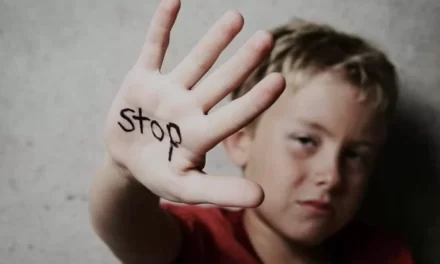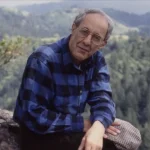Coalizione di Governo infuriata contro la Magistratura per il blocco sul Ponte sullo Stretto
La Corte dei conti respinge la delibera Cipess da 13,5 miliardi per il Ponte. Il governo può forzare la mano, ma aprirebbe un terremoto giuridico. In gioco non c’è solo un’infrastruttura: c’è l’equilibrio tra controllo della spesa, diritto Ue e ambizione di “grande opera”.
La notizia è semplice, le conseguenze no: la Corte dei conti non ha registrato la delibera Cipess che impegna 13,5 miliardi per il Ponte sullo Stretto. Non è un incidente d’ufficio: è un alt, motivato da lacune documentali e nodi giuridici che toccano nervi vitali — firma delle relazioni istruttorie, adeguatezza degli atti “Iropi” (interesse pubblico prevalente), aggiornamento progettuale, rispetto delle regole Ue su concorrenza e appalti, ruolo dell’Autorità dei trasporti sulle tariffe. Tradotto: non si può chiedere allo Stato di scrivere un assegno miliardario con fogli mancanti, firme assenti e un progetto che, dal 2003 a oggi, è cambiato più la normativa che le tavole.
La politica reagisce secondo copione. Palazzo Chigi parla di “invadenza” dei giudici contabili, Salvini grida al sabotaggio, Schlein legge nella polemica la vera natura della riforma della giustizia, Bonelli brinda alla legalità ritrovata. Ma al netto degli slogan il punto è un altro: se un governo decide di aggirare la registrazione e mandare comunque la delibera in Gazzetta — strada estrema ma prevista — accetta consapevolmente un contenzioso a tappeto davanti ai giudici amministrativi italiani e, soprattutto, davanti alla giustizia europea. È così che una scorciatoia amministrativa diventa un lunghissimo vicolo giudiziario.
Tre criticità nel via libera ai lavori
Il cuore del problema sono tre crepe.
La prima è contabile: passare da una concessione “leggera” del 2003 a un finanziamento quasi integralmente a carico dello Stato nel 2025 impone una nuova istruttoria di sostenibilità. Non bastano rinvii a documenti vecchi: servono quadri economici aggiornati, check su costi/benefici, analisi del rischio. Se, come segnalato, sono circolate “schede non aggiornate”, la fiducia si incrina: 13,5 miliardi non si approvano con l’asterisco.
La seconda è europea: riattivare un appalto antico, nel frattempo variato e lievitato, senza riaprire la gara sfida il diritto dell’Unione. La regola è chiara: modifiche sostanziali e incremento oltre soglie significative impongono concorrenza. Se davvero il progetto è mutato, non è un dettaglio: è il discrimine tra continuità legittima e violazione delle direttive appalti. Qui non decide la propaganda: decide Lussemburgo.
La terza è procedurale: la corsia “Iropi” può giustificare deroghe ambientali solo con motivazioni tecniche puntuali, firmate, tracciabili. Un parere “trasmesso” ma non sottoscritto è un boomerang: in caso di ricorsi, la prima domanda del giudice sarà “chi se ne assume la responsabilità?”. Se la risposta è il silenzio, l’atto non regge.
La posta politica è enorme. Il Ponte è molto più di un viadotto: è simbolo. Per i sostenitori, l’atto fondativo di un Sud agganciato ai corridoi europei; per gli avversari, un monumento all’azzardo pubblico. Ma c’è un equivoco da sciogliere: i simboli non esonerano dai conti. E i conti, quando mancano, non si sostituiscono con un decreto.
Si dirà: “Così si blocca lo sviluppo”. In realtà, l’unico vero blocco è una catena decisionale fragile. Se davvero il progetto è “pronto”, perché non rifare la gara su basi aggiornate e inattaccabili? Perché non pretendere oggi quelle validazioni tecniche che domani un giudice pretenderà comunque? La fretta, in infrastrutture, è la forma più costosa della lentezza.
Scenari futuri sul Ponte
C’è poi un tema di opportunità. Impegnare 13,5 miliardi su un’unica opera significa scegliere — e rinunciare ad altro: manutenzione di rete ferroviaria e stradale, porti, interporti, raccordi urbani, messa in sicurezza del territorio. Nessuno nega l’ambizione: ma il Mezzogiorno non vive di annunci, vive di cantieri che aprono e chiudono, di treni regionali puntuali, di porti interoperabili con i retroporti. La grande opera non può diventare una grande ipoteca.
Che succede adesso? Due strade. Autotutela: il governo ritira, ristruttura gli atti, aggiorna progetto e coperture, rimedia alle mancanze e ripresenta. Oppure forzatura: salta la registrazione e pubblica lo stesso. La prima costa tempo, la seconda costa cause (e, probabilmente, tempo doppio). In mezzo, la riforma della Corte dei conti evocata dall’esecutivo: trasformare un conflitto tecnico in un braccio di ferro istituzionale può dare dividendi nell’immediato, ma lascia cicatrici profonde sulla credibilità finanziaria del Paese. I mercati hanno memoria lunga: amano i ponti, odiano gli strappi.
In realtà, la via d’uscita è meno eroica e più adulta: trasparenza piena degli atti, nuova gara conforme al diritto Ue se le modifiche sono sostanziali, pareri firmati e responsabilità chiare, cronoprogramma vincolante con milestones verificabili, piano B di investimento territoriale se il progetto dovesse ancora impantanarsi. Dire “andiamo avanti” senza mettere in sicurezza la legalità del percorso è come imboccare l’autostrada con il serbatoio in riserva: si parte tra gli applausi, si finisce in corsia d’emergenza.
Il Ponte può essere un progetto del Paese o un progetto di parte. La differenza non la fa l’idea — legittima — di collegare due sponde. La fa il metodo: conti in ordine, procedure solide, rispetto delle regole comuni. In democrazia, non è la giurisdizione a invadere la politica: è la politica che, quando spende denaro pubblico, deve accettare di farsi misurare. È questo il vero test di maturità di un governo. Il resto è rumore di fondo.