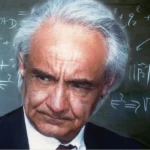Una mamma dal Portogallo contesta il reclutamento e l’indottrinamento della figlia che ha raggiunto una presunta setta di pie donne riconducibili a P. Stefano Manelli che non è più un religioso ma un prete diocesano fuori sede.
“Voglio solo sapere se sta bene”. Teresa Santos, madre di Telma (22 anni), racconta una vicenda che dal Portogallo arriva fino a Frigento, in Irpinia. Secondo la sua ricostruzione, la figlia avrebbe maturato nel tempo un legame con un gruppo di donne che avrebbero una base a Fatima e un’altra in Italia.
Il punto, però, è delicato e va precisato subito. Contrariamente a quanto dichiara la stampa locale con Avellino Today, non si parla dell’Istituto delle Suore Francescane dell’Immacolata, che risulta estraneo alla vicenda, bensì di una realtà diversa, indicata dalla madre come non riconosciuta dalla diocesi. Il vescovo di Leria-Fatima ha sconfessato questo gruppo mentre l’Ordinario di Sant’Angelo dei Lombardi la tollera.
La mamma riferisce che nei mesi estivi del 2024 la figlia aveva contatti con alcune donne vestite da suore e che, da settembre dello stesso anno, sarebbe partita per l’Italia insieme ad altre giovani e a una responsabile del gruppo, Daniela Palma che si fa chiamare Madre Maria Grazia. Da quel momento, sostiene, la comunicazione con la famiglia si sarebbe fatta sempre più difficile.
Una giovane maggiorenne può scegliere di cambiare vita, anche contro il parere dei genitori. Ma quando una scelta viene accompagnata da isolamento, opacità e interdizione dei legami familiari, non siamo più nel terreno sereno della vocazione: entriamo nella zona grigia del controllo.
Non è più Chiesa, ma setta.
La prima responsabilità — civile, ecclesiale, giornalistica — è non confondere gli attori, non sbagliare le etichette, non fare rumore con nomi altrui, ma evitare che altre persone cadano nella trappola.
C’è una parola che, in Italia, fa immediatamente notizia: convento. A volte più della convivenza, più della rottura domestica, più di qualunque altra scelta che una ragazza maggiorenne possa fare nella libertà. È una strana asimmetria: la ragazza che decide di andare a vivere con un compagno contro il parere dei genitori viene archiviata come “vita privata”; la ragazza che varca una soglia religiosa diventa “caso”. È ipocrisia sociale, prima ancora che moralismo.
Ma qui il punto non è — o non dovrebbe essere — la libertà di una ventiduenne di autodeterminarsi. Una maggiorenne può scegliere, sbagliare, cambiare strada: e nessun genitore può imporre. Può proporre, certo; può soffrire, può pregare, può insistere; ma non può sostituirsi alla coscienza adulta di una figlia. Questo va detto subito, per non avvelenare il discorso pubblico con un paternalismo facile.
Il problema vero comincia quando, dietro la parola “scelta”, si intravede una tecnica: reclutamento, separazione, dipendenza. Il racconto della madre portoghese — che chiede soltanto una cosa elementare (“sapere se mia figlia sta bene”) — descrive una traiettoria tipica delle dinamiche chiuse: avvicinamento graduale, viaggio come prova di obbedienza, mutamento repentino di linguaggio (“non voglio più studiare”), consegna degli effetti personali come taglio simbolico col passato, contatti filtrati, e soprattutto una soglia: la madre che resta fuori, letteralmente, davanti a una porta.
La storia riguarda un aggregato di “pie donne” nato — secondo le ricostruzioni e le denunce che da anni circolano in ambito ecclesiale e civile — attorno a un modello di dipendenza personale e di “obbedienza” non mediata da strutture canoniche trasparenti, con pratiche che appaiono lontane dalla prassi ordinaria della Chiesa: isolamento dalla famiglia, percorsi formativi interrotti, decisioni decisive demandate a un sacerdote problematico. presentato come oracolo.
In questo quadro, il nodo non è l’abito in sé (che, come fatto esteriore, non prova nulla), ma il suo uso come sigillo identitario: l’abito addosso può diventare, agli occhi dei fedeli, una scorciatoia di legittimazione.
E c’è un terzo punto, che pesa come una pietra: l’uso di strutture oggetto di contenzioso. Se davvero — come viene sostenuto — alcune di queste persone hanno occupato o utilizzato immobili al centro di dispute giudiziarie (si cita, ad esempio, l’ex abbazia-hotel di Frigento) sottraendoli alla disponibilità di frati e suore legittimamente presenti, allora non siamo più nella narrativa romantica “ragazza in convento”: siamo dentro una questione di responsabilità, proprietà, gestione e trasparenza. C’è un disegno criminogeno che vuole apparire sotto le sembianze di devozione?
Qui emerge la dimensione “settaria” (termine che, per rigore, va maneggiato con cautela e sempre come qualificazione contestata. Le pratiche sono la prova dei sistemi. E quando una madre denuncia minacce (“se non ritiri la denuncia non mi vedrai più”), quando i contatti vengono concessi come favore e non come diritto umano minimo, quando l’accesso familiare è filtrato e il dialogo diventa un privilegio, allora una società sana — e una Chiesa sana — non possono rifugiarsi nel “sono scelte personali”.
Non è neppure questione di “tolleranza”. La confusione peggiore è proprio quella: scambiare la tolleranza (che può essere prudenza pastorale davanti alle persone) con una approvazione (che richiede atti, norme, riconoscimenti).
Qui, invece, l’impressione è quella di una zona opaca, dove alcune persone “si spacciano” per appartenere a un santuario o per rappresentare una realtà ecclesiale, pubblicano testi, distribuiscono materiale nelle parrocchie per raccogliere offerte, ma restano irreperibili, senza una presenza pubblica ordinaria, senza la trasparenza che la vita consacrata autentica normalmente accetta: comunità visibile, regola chiara, superiori riconosciuti, formazione verificabile, sacramenti celebrati dentro un perimetro ecclesiale limpido.
Di questa vicenda si parla — ed è qui il punto più scomodo — non per gusto di scandalo, ma per dovere di tutela: tutela delle famiglie, tutela delle vocazioni vere, tutela dei fedeli, tutela degli istituti riconosciuti che vengono trascinati nel fango per un errore di etichetta. E tutela, soprattutto, delle giovani: perché la libertà non è solo “andare via”, ma poter tornare, parlare, verificare, senza ricatti affettivi e senza muri.
Se l’informazione vuole essere adulta, deve uscire dal cliché: non “madre contro convento”, non “figlia rapita” contro “vocazione tradita”. La vera alternativa è più esigente: vocazione autentica o manipolazione. E per capirlo servono fatti, trasparenza, risposte, verifiche. A cominciare dalla prima: chiamare correttamente le persone e le istituzioni, evitando l’errore che inquina tutto.
Quanto a chi, negli anni, è stato indicato come ispiratore di questo circuito, il nome basta citarlo una volta: p. Stefano M. Manelli. Il resto lo devono dire gli atti, non gli epiteti. Ma una cosa va detta chiaramente: nessuna vocazione cristiana cresce contro la verità, nessuna consacrazione fiorisce contro la libertà, nessuna pietà mariana si regge sull’ombra.
S. C.
………………
Articolo gentilmente concesso dalla testata Il Faro di Roma