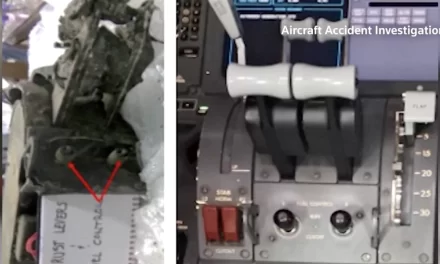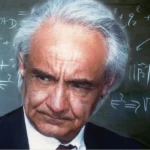Dietro l’attacco missilistico degli USA nel Nord-Ovest Nigeriano a postazioni di terroristi islamisti, c’è in realtà un’operazione di strategia egemonica degli USA che Trump giustifica verso l’opinione pubblica facendo credere al “massacro dei cristiani” che lo stesso governo nigeriano smentisce.
Quando Washington parla di Nigeria, la parola che rimbalza nei titoli è sempre la stessa: religione. Cristiani massacrati, jihadisti islamici, Natale di sangue. Donald Trump lo ha detto senza sfumature, nel suo stile: gli Stati Uniti hanno colpito l’ISIS perché “sta massacrando i cristiani”. E il messaggio, rivolto all’elettorato evangelico americano, è chiaro: una guerra giusta, quasi una crociata difensiva.
Ma la Nigeria reale è molto meno manichea di quella raccontata nei comunicati della Casa Bianca e nei frame del mainstream occidentale.
Il Paese più popoloso d’Africa non è il teatro di uno scontro religioso lineare tra Islam e Cristianesimo. È, piuttosto, un mosaico instabile di conflitti sovrapposti: jihadismo, banditismo armato, sequestri a scopo di riscatto, lotte per la terra, collasso dello Stato nelle periferie, economie criminali che prosperano dove il potere pubblico non arriva. Boko Haram, ISWAP, milizie locali e bande di “bandits” uccidono cristiani e musulmani con la stessa ferocia. Abuja lo ripete da anni: parlare di genocidio cristiano è una semplificazione interessata.
Eppure Washington insiste. Perché?
La risposta non sta solo nella politica interna americana, ma in ciò che bolle sotto la superficie: la Nigeria è un nodo strategico, non morale. È sicurezza, influenza regionale e – soprattutto – energia.
Il Paese è uno dei principali produttori di petrolio dell’Africa subsahariana, snodo cruciale nel Golfo di Guinea, area sempre più contesa in un mondo che ha scoperto di colpo la fragilità delle proprie catene energetiche. Da decenni, in Nigeria operano colossi europei come ENI e TotalEnergies, Shell, presenti nei grandi giacimenti offshore e onshore, spesso in condizioni difficili ma con una conoscenza profonda del territorio e delle sue complessità politiche. Gli statunitensi sono presenti con i colossi ExxonMobil e Chevron da tutelare.
L’intervento militare statunitense – per la prima volta diretto e dichiarato sotto la presidenza Trump – segna un cambio di passo. Non è solo antiterrorismo. È anche un messaggio geopolitico: gli Stati Uniti tornano a farsi attore militare diretto in un Paese dove finora avevano preferito agire per interposta cooperazione, intelligence e forniture.
Che la Nigeria abbia “illuminato i bersagli” e fornito le informazioni a Washington è un dettaglio rivelatore. Abuja non ha subito un intervento: lo ha autorizzato. Ma autorizzarlo significa anche accettare che la partita non si giochi più solo sul terreno interno, bensì in uno spazio internazionale dove sicurezza e risorse si intrecciano.
Il petrolio è il convitato di pietra di questa storia. Non viene nominato nei discorsi natalizi di Trump, ma è presente in ogni mappa strategica del Pentagono. Stabilizzare – o almeno controllare – le aree chiave significa anche garantire che le infrastrutture energetiche restino accessibili, che i flussi non finiscano in mani ostili, che il peso degli operatori europei non diventi eccessivo in una fase di ridefinizione degli equilibri globali.
In questo senso, la retorica religiosa funziona come una copertura perfetta: mobilita consenso, semplifica il conflitto, oscura interessi materiali. Ma la Nigeria non è l’Iraq del 2003 e non è nemmeno la Siria. È un Paese formalmente sovrano, che rifiuta l’etichetta di guerra di religione e che sa di muoversi su un crinale pericoloso: accettare l’aiuto americano senza trasformarsi in un teatro di competizione permanente tra potenze.
Dietro i missili lanciati a Natale, dunque, non c’è solo l’ISIS. C’è una partita più ampia: chi controlla la sicurezza dell’Africa occidentale, chi orienta i flussi energetici, chi detta la narrazione. E chi, mentre parla di fede, guarda soprattutto ai pozzi.
La vera domanda non è se Boko Haram dipenda da una matrice religiosa. La domanda è se, ancora una volta, la religione non venga usata come linguaggio di superficie per mascherare una guerra che – come spesso accade – profuma soprattutto di petrolio.