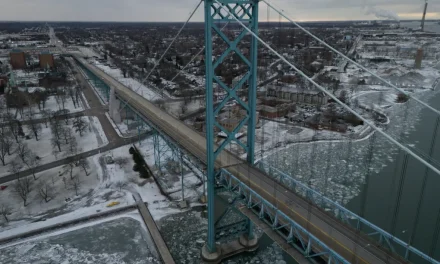Le immagini che arrivano da Kathmandu non sono quelle di una normale crisi politica: raccontano il crollo di un sistema che ha smesso di funzionare. Il Parlamento incendiato, le residenze degli ex primi ministri devastate, le dimissioni forzate di K.P. Sharma Oli: tutto parla di un Paese in cui la politica non è più percepita come soluzione, ma come parte del problema.
A guidare la rivolta non sono i tradizionali partiti di opposizione, bensì i giovani. La cosiddetta Generazione Z nepaleseè scesa in piazza con una rabbia sedimentata negli anni, esasperata dalla corruzione, dall’assenza di lavoro e dall’incapacità delle istituzioni di mantenere le promesse di rinnovamento democratico fatte dopo la caduta della monarchia nel 2008.
La miccia dei social e la polveriera del malcontento
La scintilla che ha acceso le proteste è stato il bando imposto dal governo su WhatsApp, Instagram, YouTube e LinkedIn. In un Paese in cui milioni di cittadini vivono all’estero e sostengono le famiglie con le rimesse, i social non sono un passatempo, ma una vera e propria infrastruttura sociale ed economica.
Bloccarli è stato percepito come un atto autoritario e distante dalla realtà quotidiana. La successiva revoca è arrivata troppo tardi: la miccia aveva già acceso un incendio politico che nessuno sembra in grado di spegnere.
Giovani senza lavoro, famiglie sostenute dalle rimesse
Il vero dramma del Nepal resta il lavoro. Il tasso ufficiale di disoccupazione, al 12,6% nel 2024, sottostima una realtà ben più grave: gran parte dell’economia è sommersa e agricola, e i giovani faticano a trovare impieghi stabili. Ogni giorno migliaia di ragazzi e ragazze lasciano il Paese per contratti precari nel Golfo Persico o in Malesia.
Il Nepal sopravvive grazie alle rimesse degli emigrati: 11 miliardi di dollari nel 2024, oltre un quarto del PIL nazionale. Un flusso vitale che paga istruzione, cure mediche e beni essenziali, ma che rivela anche la fragilità di un Paese incapace di offrire futuro ai propri figli. Il divieto dei social, in questo contesto, non ha solo limitato la libertà d’espressione: ha tagliato i ponti tra chi lavora all’estero e chi resta a casa.
Corruzione cronica e promesse tradite
Il malessere non nasce dal nulla: il Nepal è tra i Paesi più corrotti dell’Asia. Scandali miliardari, come quello dell’aeroporto internazionale di Pokhara, dove decine di milioni di dollari sono spariti tra politica e imprese, hanno cementato la sfiducia verso le istituzioni. Nessuno paga mai davvero.
Ancora più scandaloso lo schema dei falsi rifugiati bhutanesi: giovani disoccupati ingannati con la promessa di un lavoro negli Stati Uniti, mentre politici di ogni partito lucravano sulla disperazione collettiva. Pochi sono stati perseguiti, e quasi sempre tra le file dell’opposizione.
Per i cittadini, la corruzione non è un concetto astratto: significa mancanza di fertilizzanti per i contadini, scuole inadeguate, cure mediche troppo costose, inflazione che divora i salari.
Una democrazia senza respiro
Dal 2015 a oggi, tre soli leader — Oli, Pushpa Kamal Dahal e Sher Bahadur Deuba — si sono alternati a ritmo serrato al vertice del governo. Una rotazione che più che stabilità ha prodotto paralisi, con mandati brevi e nessuna riforma incisiva.
Non stupisce che l’ira dei giovani si sia rivolta anche contro i simboli personali del potere: le ville degli ex premier, le immagini dei loro figli che ostentano lusso sui social, percepite come schiaffi a una generazione senza opportunità.
Il vuoto e il rischio di implosione
Le dimissioni di Oli hanno aperto un vuoto politico pericoloso. Le strade della capitale restano militarizzate ma incontrollabili, con civili armati, granate lanciate contro edifici pubblici, aeroporti e hotel devastati. La dichiarazione congiunta dei vertici della sicurezza, che hanno chiesto calma, suona come un’ammissione di impotenza.
Il Nepal oggi è sospeso: da un lato una generazione che reclama futuro, dall’altro un’élite che continua a ripiegarsi sui propri privilegi.
Una lezione globale
La crisi nepalese non è un caso isolato. Le piazze del Bangladesh, le barricate dello Sri Lanka, i cortei in Indonesia raccontano la stessa storia: quando i giovani non trovano spazio nella politica, quando la democrazia non mantiene le promesse, il contratto sociale si spezza.
Kathmandu brucia, ma le fiamme illuminano un paradosso universale: i giovani non smettono di chiedere futuro. Lo chiedono con la voce, con le marce, e quando nessuno li ascolta — purtroppo — con la forza.
Se la politica non è capace di ascoltarli e includerli, il rischio è che le nuove generazioni non cerchino più soluzioni nelle urne, ma nelle strade. E allora la democrazia smette di essere promessa di progresso e diventa soltanto un guscio vuoto.