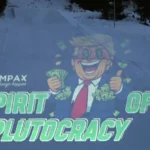A Betlemme i bambini tornano a sorridere. È un sorriso fragile, timido, quasi incredulo, come se avesse bisogno di chiedere permesso alla storia per riaffiorare. Padre Ibrahim Faltas lo racconta con parole semplici: dopo due anni di paura, di guerra, di assenza di festa, il Natale torna a farsi vedere sui volti dei più piccoli. Eppure basta spostare lo sguardo di pochi chilometri, attraversare idealmente quel filo invisibile che separa Betlemme da Gaza, perché la gioia si trasformi in una domanda bruciante: che senso ha parlare di stabilizzazione mentre si contano oltre quattrocento morti innocenti dopo una tregua?
È qui che il Natale cristiano smette di essere una cornice emotiva e diventa giudizio sulla storia. A Gaza e a Rafah il cielo continua a rombare di aerei, le “zone gialle” si riempiono di esplosioni, l’artiglieria e i droni scandiscono le ore di chi vive nelle tende, senza acqua, senza luce, senza medicine. In questo scenario, l’uso disinvolto della parola “sicurezza” suona come una bestemmia semantica. La sicurezza che passa sopra i corpi dei bambini non è stabilità: è anestesia morale.
Il paradosso è tutto qui. Mentre a Betlemme il Natale unisce cristiani e musulmani come messaggio di pace universale, a Gaza il Natale assomiglia sempre di più a quello di duemila anni fa: una nascita sotto assedio, una fuga forzata, una vita minacciata dal potere. Padre Gabriel Romanelli lo dice senza retorica: questo Natale “ci fa tornare all’essenzialità”. All’essenziale del Vangelo, verrebbe da aggiungere, dove Dio non nasce mai nei palazzi della geopolitica ma ai margini, tra chi non conta nulla.
Per questo solidarizzare con i gazawi e con il popolo palestinese non è un gesto ideologico, ma un atto di fedeltà al Natale stesso. In barba a chi parla di stabilizzazione come se fosse una categoria neutra, tecnica, disincarnata. Non c’è stabilità dove la terra trema sotto le tende, dove i rifiuti si accumulano perché le discariche sono oltre una linea militare, dove l’acqua potabile è un lusso e l’elettricità una concessione intermittente. Non c’è stabilità dove la tregua diventa un intervallo per riorganizzare la violenza.
Le dichiarazioni sul futuro di Gaza, i sogni di reinsediamenti, le smentite parziali, i giochi di parole sulla sicurezza rivelano una verità scomoda: la pace viene evocata, ma non voluta fino in fondo. E mentre i grandi discutono di piani in venti punti, i piccoli ricevono uova, polli, coperte. È una sproporzione che grida al cielo.
Eppure, proprio lì, in quella sproporzione, il Natale resiste. Resiste nella prima Comunione di nove bambini a Gaza, in un battesimo celebrato tra le macerie, in un Cristo sofferente dipinto e inviato al Papa come segno di gratitudine. Resiste nella carità concreta che diventa confessione di fede. Resiste come accusa silenziosa contro ogni cinismo politico.
Solidarizzare oggi con Gaza e con i palestinesi significa allora una cosa sola: rifiutare l’idea che la pace possa nascere dalla rimozione del dolore. Significa ricordare che il Bambino di Betlemme non è mai neutrale, e che il suo Natale non benedice nessuna stabilizzazione costruita sulla morte degli innocenti. Se il Natale ha ancora una parola da dire al mondo, è questa: o è pace per gli ultimi, o non è Natale.