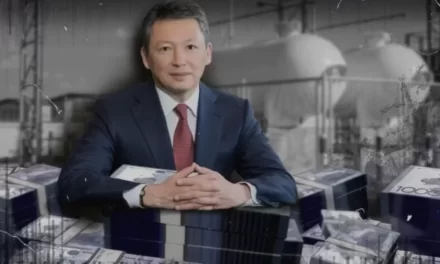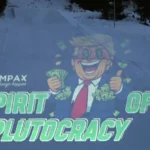Attentato al generale Fanil Sarvarov dello Stato Maggiore russo
C’è un momento, nelle guerre lunghe, in cui il fronte smette di essere una linea e diventa una condizione. L’autobomba che ha ucciso nel cuore di Mosca il generale Fanil Sarvarov, capo della direzione addestramento operativo dello Stato Maggiore russo, dice precisamente questo: il conflitto non è più “là fuori”. È entrato nel cortile del potere, sotto il sedile del conducente, azionato al primo freno.
Trecento grammi di tritolo — poco, tecnicamente; molto, simbolicamente — bastano a smentire la retorica dell’inviolabilità. Bastano a incrinare l’idea che la capitale sia una fortezza. Bastano, soprattutto, a ricordare che ogni guerra moderna, prima o poi, diventa una guerra di nervi. E che i nervi, quando vengono colpiti, fanno male a tutti.
Il sospetto — immediato, quasi rituale — cade sui servizi ucraini. Non è una novità. Dal 2022 a oggi, una scia di attentati mirati ha attraversato la Russia e i territori occupati: l’assassinio di Daria Douguina, le bombe contro blogger militari, i colpi a generali di alto profilo. L’elenco non è propaganda, è cronaca. E la cronaca racconta una cosa semplice: la guerra si è fatta asimmetrica, chirurgica, comunicativa. Colpire un generale nel centro di Mosca non è solo un’azione militare; è un messaggio.
Un messaggio a Vladimir Putin, innanzitutto. Perché l’imbarazzo è politico prima che operativo. Se il cuore del sistema può essere raggiunto, allora il sistema non è impermeabile. E ogni reazione — inevitabile, più dura, più rumorosa — rischia di apparire come ciò che è: una risposta che cerca di ricucire una vulnerabilità esposta.
Sarvarov non era un nome qualsiasi. Formazione nelle accademie delle forze corazzate e dello Stato Maggiore, teatri di guerra dall’Ossezia-Inguscezia alla Cecenia, dalla Siria all’Ucraina; decorazioni, promozioni, un ruolo chiave nell’addestramento operativo. Uccidere lui significa colpire il nervo che prepara, coordina, istruisce. Non il soldato, ma la macchina che rende i soldati tali. È una scelta, non un caso.
Eppure, fermarsi all’effetto “colpo al Cremlino” sarebbe miope. Perché l’autobomba di Mosca arriva mentre si parla — a bassa voce, in stanze lontane — di negoziati. Miami, emissari, linguaggi prudenti. Tutto “costruttivo”, dicono. Tutto “poco costruttivo”, ribattono. In questo scarto lessicale si inserisce la detonazione. Come a dire: la diplomazia può attendere, il campo no. O, peggio, come a dire che la diplomazia viene usata come cornice mentre la guerra detta il ritmo.
C’è poi l’altra faccia, quella ucraina. Se davvero l’azione fosse riconducibile a Kiev — ipotesi, non sentenza — il segnale sarebbe duplice: deterrenza verso i vertici militari russi e rassicurazione verso un’opinione pubblica stremata, che chiede prove di capacità offensiva oltre il fronte. Le guerre contemporanee si combattono anche così: con atti che tengono insieme strategia e psicologia, efficacia e narrazione.
Il rischio, tuttavia, è noto. Ogni attentato “di successo” avvicina l’escalation. Ogni colpo nel cuore dell’avversario giustifica, agli occhi di chi comanda, una risposta più ampia, più brutale, più indifferente ai confini tra militare e civile. Odessa, Dnipropetrovsk, le infrastrutture colpite: la lista dei ritorsioni è già scritta, cambia solo l’ordine.
Per questo l’autobomba di Mosca non è solo un fatto di cronaca. È una soglia. Segna il passaggio da una guerra che pretendeva di restare lontana a una guerra che si presenta alla porta. Ricorda che la sicurezza totale è un’illusione e che, quando la violenza rientra in casa, il prezzo politico sale. Per tutti.
In fondo, l’immagine è semplice e terribile: un ordigno fissato con un magnete. Non servono grandi mezzi per incrinare grandi poteri. Basta trovare il punto giusto. E il punto giusto, oggi, non è più solo il fronte. È la percezione. È la capitale. È la certezza — ormai persa — che “qui” non succederà.