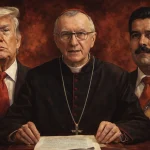Il discorso di Giorgia Meloni al Meeting di Rimini 2025 è stato lungo, appassionato e ricco di riferimenti culturali e religiosi. Non è casuale: parlare a Comunione e Liberazione significa misurarsi con un pubblico abituato al linguaggio della fede, delle opere e della dottrina sociale. Per questo le citazioni non sono mai neutre.
La premier ha scelto di evocare, fra gli altri, Jean Guitton, Pier Giorgio Frassati, don Giussani. Ma quando ha citato il cardinale Robert Sarah – “chi considera le migrazioni necessarie e indispensabili compie un atto egoistico” – ha acceso una miccia. Con tutto il rispetto dovuto al porporato guineano, Sarah è divenuto negli ultimi anni un punto di riferimento per i settori più critici verso il magistero di Papa Francesco e, oggi, verso Papa Leone XIV. L’inserimento della sua voce in un discorso così calibrato non può essere considerato casuale: significa parlare a quell’area cattolica tradizionalista che vede nella linea papale sull’accoglienza dei migranti una cedimento al globalismo, e che si riconosce piuttosto in un linguaggio severo di “radici” e “difesa”.
È un passaggio che stride con l’orientamento costante della Santa Sede. Francesco, come Leone XIV, ha sempre insistito sul dovere di accogliere, proteggere, promuovere e integrare, pur distinguendo tra migranti economici e rifugiati. Meloni, invece, fa proprio l’assioma di Sarah: meglio che i giovani restino in Africa. Un’affermazione che, sebbene motivata dal rispetto delle culture e dalla lotta ai trafficanti, rischia di ignorare la realtà: chi fugge non lo fa quasi mai per egoismo, ma per necessità, e perché vede in Europa – spesso illusoriamente – un eldorado. Qui si avverte la distanza con il magistero sociale della Chiesa, che non smette di denunciare le disuguaglianze strutturali, la mancanza di lavoro e la corruzione politica come cause prime delle migrazioni.
Sorprende inoltre un’assenza: il Piano Mattei per l’Africa, che il Governo aveva presentato come architrave della sua visione strategica, compare solo in modo episodico e non come fulcro dell’intervento. La premier ha parlato di progetti in Algeria e Costa d’Avorio, ma senza rilanciare con forza la cornice “Mattei”. Perché? Possibile che la retorica dei “mattoni nuovi” e la scelta di un discorso a tutto campo abbiano finito per marginalizzare quello che, fino a pochi mesi fa, era presentato come il segno distintivo dell’Italia nel Mediterraneo e in Africa. Ma resta il fatto che, senza un piano credibile e strutturato di cooperazione, l’invito ai giovani africani a restare nella loro terra rischia di apparire come un imperativo morale privo di sostegno concreto.
La contraddizione è evidente: Meloni riconosce che i flussi irregolari sono stati ridotti, rivendica il ruolo italiano nell’orientare l’Europa verso partenariati con i Paesi di origine, ma contemporaneamente non chiarisce quale sia la reale portata degli investimenti sul terreno. E così la retorica del “diritto a non emigrare” rischia di trasformarsi in slogan, proprio laddove il magistero cattolico chiede di passare dalle parole alle scelte operative.
Al Meeting, dunque, Meloni ha offerto un discorso che alterna continuità e rotture. Continuità con la sua linea identitaria – l’elogio delle radici, la denuncia dell’omologazione, la retorica dei valori “antichi vissuti in modo nuovo”. Rottura parziale sul dossier Israele-Palestina, con un linguaggio più vicino alla sensibilità vaticana che in passato. Ambiguità, però, quando si cita Sarah, assumendo un linguaggio che può piacere a un certo cattolicesimo militante ma che rischia di suonare dissonante rispetto al respiro universale della Chiesa.
Il risultato è un discorso a due velocità: politico sul piano interno, pragmatico sul piano internazionale, identitario sul piano culturale. Ma per un pubblico cattolico come quello del Meeting, resta la domanda: i “mattoni nuovi” sono davvero strumenti di ricostruzione condivisa, o sono mattoni antichi rivestiti di nuova vernice retorica?