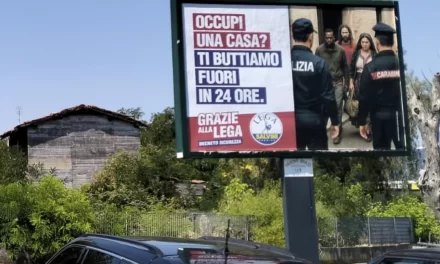Recensione di una docufiction che non lascia scampo alle scuse
Ci sono docuserie che nascono per informare e docuserie che nascono per impedire l’oblio. Marcial Maciel: El lobo de Dios appartiene alla seconda categoria: non cerca la suspense, non corteggia l’ambiguità, non si rifugia nel “forse”. Mette in scena — con testimonianze, documenti e ricostruzioni — un caso che la Chiesa stessa ha riconosciuto come gravissimo, e lo fa con una scelta stilistica precisa: evitare l’anticlericalismo da copione e puntare, piuttosto, alla nuda evidenza di un sistema di potere.
La serie (2025, 4 episodi da circa 45 minuti, diretta da Matías Gueilburt, distribuita su HBO Max) lavora come una lenta serratura che si chiude: più che “raccontare la vita” di Maciel, ricostruisce la fabbrica della sua credibilità, cioè ciò che gli ha permesso di durare decenni: l’aura di santità, il denaro, le reti di protezione, l’uso strumentale del linguaggio religioso e, soprattutto, la manipolazione delle coscienze.
Il punto forte — e anche il più teologico — sta nel modo in cui il film mostra l’architettura della doppia vita non come un accidente psicologico, ma come una spiritualità corrotta. Qui la docufiction diventa una lezione di antropologia cristiana: quando la religione si riduce a performance (successo, “opere”, vocazioni, benefattori), può diventare la maschera perfetta per la predazione. E il predatore, nel contesto ecclesiale, non si limita a ferire corpi: ferisce ciò che è più delicato, cioè la fiducia nel sacro. È per questo che il titolo “lupo di Dio” non suona come una provocazione giornalistica, ma come una diagnosi: il male non entra solo “fuori” dalla Chiesa; entra anche travestito.
Da un punto di vista narrativo, la serie sceglie il registro del “doloroso e affascinante” (formula che dice bene l’effetto sullo spettatore): l’orrore non è spettacolarizzato, ma è comunque inevitabile; e il tema — per definizione — è pesante, con descrizioni e ricostruzioni che possono risultare dure da sostenere.
Il rischio, in operazioni simili, è sempre doppio: o il moralismo anticlericale, o la riduzione del fondatore a “mostro isolato” che salva il sistema. El lobo de Dios tende a evitare il primo, e prova a non cadere nel secondo: insiste sul fatto che un caso così non vive senza complicità, inerzie, timori, calcoli, e senza una cultura ecclesiale che confonde la fecondità esterna con la santità. È il punto che molte letture critiche hanno sottolineato: il problema non è solo Maciel, ma l’ecosistema che lo ha reso possibile.
Resta, tuttavia, una domanda che la serie lascia volutamente sospesa — e che è anche la sua scelta più “politica” (in senso ecclesiale): cosa accade dopo la scoperta? Quanto davvero cambia una congregazione quando il suo mito fondativo viene demolito? ACI Prensa, riportando la posizione dei Legionari di Cristo, mostra un elemento importante del “dopo”: la tensione tra la necessità di fare verità, la gestione della memoria e la narrazione identitaria dell’istituto. È una frizione che la docuserie non risolve — e forse non deve risolvere — ma che consegna allo spettatore come responsabilità.
In definitiva, Marcial Maciel: El lobo de Dios funziona quando smette di essere “il racconto di un criminale” e diventa una catechesi negativa sul potere: su come il carisma possa degenerare in culto, l’obbedienza in soggezione, il linguaggio di Dio in strumento di ricatto morale. È una serie che fa male perché non ti lascia la consolazione più facile — “era un caso unico” — e ti costringe a una conclusione più adulta: la Chiesa non si difende con il silenzio né con l’imbarazzo, ma con la verità e con riforme che impediscano la riproduzione di simili dinamiche.