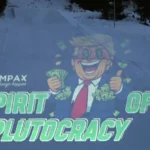La manovra passa al Senato e, come spesso accade quando la politica si fa contabilità d’emergenza, il dato più onesto non è quello dei saldi, ma quello dell’atmosfera: nervosa, compressa, natalizia solo nelle battute. Il governo incassa il primo via libera parlamentare alla legge di Bilancio (110 sì, 66 no, 2 astenuti) e spedisce il testo alla Camera, dove il varo definitivo è atteso il 30 dicembre.
C’è un’immagine che riassume la giornata: la fiducia come slitta obbligata. Prima il voto sulla fiducia al maxi-emendamento (113 sì, 70 no, 2 astenuti), poi il “disco verde” finale. È un modo di procedere che il governo rivendica come responsabilità, le opposizioni come prova d’arrocco. In mezzo, il Parlamento che discute sapendo che la partita vera, alla fine, la decide la somma dei numeri. E i numeri — quando arrivano a dicembre — hanno sempre la voce grossa.
La manovra, dice Giorgetti, vale “circa 22 miliardi” e contiene “cose che sembravano quasi impossibili”. Ma la cronaca di queste ore mostra un’altra verità, meno trionfale e più istruttiva: non è stata una corsa lineare, è stata una traiettoria a zig-zag. Stretta (poi ripensata) sul riscatto della laurea, fibrillazioni sulle pensioni, e soprattutto quel che resta come segno politico: l’idea — solo sfiorata, ma abbastanza da lasciare lividi — di uno “scudo” che avrebbe reso più difficile ottenere arretrati salariali per lavoratori sottopagati, finito fuori dal testo insieme ad altre quattro norme dopo i rilievi del Quirinale.
Qui sta il punto: non è solo una manovra “prudente” o “pasticciata”, secondo la tribuna che la giudica. È una manovra che ha mostrato, in diretta, la fatica di tenere insieme identità e governo. La Lega che agita lo spettro dell’innalzamento dell’età pensionabile e poi lo neutralizza; il ministro dell’Economia che fa l’equilibrista tra vincoli e promesse; Salvini e Giorgetti dati per “gelo” e poi raccontati come “nessun gelo”. In politica, spesso, i rapporti non si misurano da quello che si dice, ma da quanto serve dirlo.
E intanto, dall’altra parte dell’aula, i cartelli “Voltafaccia Meloni” sventolano come un promemoria: la manovra non è mai solo finanza pubblica, è un rendiconto morale su ciò che avevi promesso di essere.
C’è anche un paradosso tutto italiano: per anni “rating” e “spread” sono stati raccontati come feticci tecnocratici; oggi, quando conviene, diventano medaglie da appuntarsi al bavero. Ma la credibilità non la fa la retorica — la fa la coerenza. E la coerenza, in questa manovra, si intravede più nei tagli evitati all’ultimo minuto che nelle certezze proclamate al microfono.
Adesso la palla passa a Montecitorio: l’ultimo miglio, quello in cui di solito si tenta di limare senza far saltare i saldi, e si promette che “non cambierà nulla” mentre tutti cercano di cambiare qualcosa. Il voto finale è atteso il 30 dicembre 2025.
E allora, più che chiedersi chi abbia vinto oggi, conviene annotare la lezione: questa legge di Bilancio non ha raccontato un Paese pacificato, ma un Paese in cui la politica prova a governare la complessità con il fiato corto — e in cui, a pochi giorni da Capodanno, il vero miracolo non è “fare cose impossibili”, ma fare scelte comprensibili.