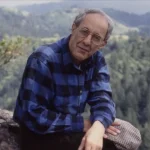Nella comunicazione politica di Lega e Fratelli d’Italia, il “nemico” è spesso già scritto: lo straniero, l’irregolare, l’altro. Un avversario costruito più nella paura che nei fatti, utile a evocare un pericolo costante e a trasformare l’insicurezza percepita in consenso elettorale. La strategia è antica: inventare la minaccia, amplificarla, promettere ordine. Ma ogni volta che si governa attraverso la paura, non si costruisce comunità: si manipolano coscienze e si divide il Paese.
Da tempo, in Italia come in molte democrazie occidentali, il tema dell’immigrazione è diventato terreno privilegiato della contesa politica. Una parte del dibattito pubblico si concentra sistematicamente sui fatti di cronaca che coinvolgono cittadini stranieri, regolari o meno, trasformando episodi criminosi in simboli, casi isolati in generalizzazioni, statistiche in slogan.
La logica è chiara: far coincidere la questione migratoria con quella della sicurezza, alimentando un clima emotivo dove la paura precede la realtà dei fatti. Non si tratta di negare che esistano problemi né che alcuni reati siano compiuti da persone giunte da altri Paesi: sarebbe ingenuo e disonesto. Ma è altrettanto falso sostenere che l’immigrazione costituisca un “pericolo diffuso” per la collettività italiana.
I numeri – non le percezioni, non gli slogan – mostrano da anni un quadro più articolato: i reati nel nostro Paese sono in calo costante, e il legame automatico tra presenza migratoria e criminalità non trova fondamento stabile nei dati. È un punto che studiosi, magistrati, associazioni e operatori sociali ripetono da tempo: la realtà è complessa, la politica la semplifica per convenienza.
Il nodo della percezione
Eppure, nell’immaginario collettivo qualcosa si è incrinato. La narrazione di un’Italia assediata, insicura, “invasa” da persone pronte a delinquere, si è insediata con forza. Non è un caso: per anni determinati attori politici hanno scelto di amplificare ogni episodio che coinvolgesse cittadini stranieri, fino a costruire un “frame” emotivo che precede la verifica dei fatti.
È una strategia: far sentire la casa comune in pericolo, per proporre sé stessi come unico argine possibile. Il rischio, però, è un altro: disumanizzare intere categorie di persone, trasformare la differenza in sospetto, confondere l’eccezione con la norma.
Vittime due volte
Tra le vittime di questo clima non ci sono solo gli stranieri onesti, spesso silenziosi e invisibili, che lavorano, studiano, si sacrificano e costruiscono futuro nelle nostre città. Ci sono anche le nostre comunità: quando la paura diventa lente unica, si perde la capacità di riconoscere l’altro come un fratello in umanità.
La Dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che la sicurezza è un bene, ma lo è anche la verità. Manipolare emozioni e dati significa indebolire la convivenza, erodere il senso di comunità, minare la fiducia sociale.
Una sfida educativa e civile
A chi opera nell’informazione, nella scuola, nella politica, ma anche nella pastorale e nel volontariato, spetta oggi una grande responsabilità: educare alla lettura critica della realtà. Serve “prebunking”, come dicono gli studiosi: offrire strumenti prima che la manipolazione attecchisca.
Non per negare i problemi, ma per collocarli nella verità. Perché il discrimine non è tra buonismo e cattiveria, ma tra realtà e semplificazione, tra giudizio e pregiudizio.
In fondo, non è una battaglia sulle cifre, ma sulla società che vogliamo costruire.
Un Paese che sceglie la paura come bussola smarrisce il futuro.
Un Paese che sceglie la verità, pur scomoda, ed esercita la responsabilità nella parola, ritrova la sua dignità civica e cristiana.
E forse, proprio in questo tempo di voci urlate e immagini manipolate, tornano attuali le parole del Vangelo:
«La verità vi farà liberi». (Gv 8,32)
Non liberi dalla complessità, ma liberi dall’inganno.
E anche questo, oggi, è un servizio alla pace civile e alla fraternità evangelica.
………………………………………………….
Nota di redazione
Questo contributo non intende assumere posizioni di parte né entrare nel confronto politico contingente. Si tratta di un’analisi giornalistica basata su dati pubblici e studi accademici, con l’unico obiettivo di contribuire a un’informazione corretta, consapevole e rispettosa della complessità dei fenomeni sociali.