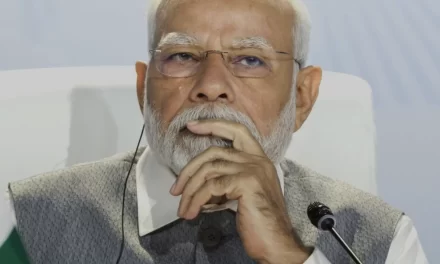Quando Donald Trump alza i dazi e rispolvera il vecchio riflesso protezionista, l’Europa si ritrova davanti a una verità elementare: deve campare. Non per ideologia globalista, ma per sopravvivenza economica. È in questo contesto che va letto l’accordo commerciale tra Unione europea e India, presentato come “la madre di tutti gli accordi” non tanto per entusiasmo, quanto per dimensioni: quasi due miliardi di persone coinvolte, una massa critica che nessun altro partner può offrire oggi.
L’intesa con Nuova Delhi del 27 gennaio scorso, non è un gesto romantico verso l’Asia, né un segnale ostile verso Pechino. Con la Cina, ogni mossa commerciale è immediatamente letta come un affronto politico-diplomatico, un capitolo della competizione sistemica tra modelli di potere. Con l’India è diverso. L’India non è la Cina: è una democrazia imperfetta ma pluralista, un Paese in crescita rapida, una potenza che rivendica autonomia strategica più che egemonia globale. Per Bruxelles, è il partner “possibile” in un mondo in cui gli spazi si stanno chiudendo.
L’accordo nasce dunque da una necessità geopolitica prima ancora che economica. Gli Stati Uniti alzano barriere, la Cina è un terreno minato, la Russia è fuori gioco. L’India diventa la grande porta rimasta socchiusa. Ma, come spesso accade, non tutti entreranno allo stesso modo.
Per l’Italia, in particolare, l’accordo UE-India è insieme promessa e disincanto. Promessa perché apre un mercato gigantesco a produzioni di qualità, disincanto perché smonta un’illusione coltivata a lungo: l’idea che il made in Italy agroalimentare sia universalmente esportabile. Non lo è. E l’India lo dimostra con chiarezza.
La struttura culturale e religiosa dei consumi indiani pone limiti netti. Una popolazione in larga parte vegetariana rende di fatto irrilevanti i salumi italiani, anche in presenza di dazi azzerati. Non è una questione di prezzo, ma di abitudini profonde. Allo stesso modo, il settore lattiero-caseario, fiore all’occhiello dell’Italia, incontra un ostacolo difficilmente aggirabile: il rifiuto dell’uso del caglio animale. L’India è uno dei maggiori produttori mondiali di latte, ma questo non apre automaticamente le porte ai formaggi italiani, che restano in gran parte incompatibili con le pratiche e le sensibilità locali.
Qui l’accordo mostra il suo volto selettivo. Non tutto il made in Italy vola. Alcuni comparti restano a terra.
Eppure, non è un accordo povero. Dove le abitudini cambiano, o possono cambiare, le opportunità sono reali. L’olio d’oliva, ad esempio, ha davanti a sé un percorso lungo ma non impossibile: più che vendere un prodotto, si tratta di educare un consumo, far incontrare la Dieta Mediterranea con una classe media indiana giovane e urbanizzata. Ancora più promettente è il comparto dolciario e dei prodotti da forno, che già oggi gode di una curiosità crescente e di una certa affinità con il gusto urbano indiano.
Ma il vero punto di svolta, per l’Italia, è altrove. È nel vino e nei distillati. Qui l’accordo cambia davvero le regole del gioco. Dazi che arrivavano al 150% hanno finora tenuto fuori i vini europei dal mercato indiano. I numeri parlano chiaro: pochi milioni di euro di export in un Paese da oltre un miliardo di abitanti. Con l’intesa, quei dazi sono destinati a scendere progressivamente fino a livelli attorno al 20–30%. Non subito, ma in modo strutturale.
È qui che si apre una prateria, come l’hanno definita gli operatori del settore. Non solo per il vino, ma per gli spirits: whisky, brandy, rum, un mercato che in India vale decine di miliardi di dollari e che guarda sempre più ai prodotti premium e super-premium. In questo spazio, grappa e brandy italiani possono finalmente giocare una partita vera, dopo anni di marginalità forzata.
Tutto questo avviene mentre l’Europa manda un messaggio politico chiaro: non intende subire passivamente il protezionismo americano. L’accordo con l’India è anche una risposta indiretta a Trump. Non uno scontro frontale, ma una diversificazione strategica. Se Washington chiude, Bruxelles apre altrove.
Resta, certo, l’ombra lunga delle questioni irrisolte: diritti del lavoro, tutele ambientali, sostenibilità sociale. L’accordo, come molti trattati commerciali recenti, privilegia la rapidità e la scala rispetto alla profondità delle garanzie. Ma questo non cancella il dato centrale: l’Europa ha scelto di muoversi, non di restare immobile.
L’intesa UE-India non è la soluzione a tutti i problemi del commercio europeo. È una scommessa necessaria. Per l’Italia, è un banco di prova di realismo: capire che il made in Italy non è un monolite, che alcuni settori vinceranno e altri no, che il futuro passa più dalla qualità e dalla capacità di leggere le culture che dalla nostalgia delle eccellenze universali.
In un mondo che si frammenta, l’Europa ha scelto di non chiudersi. Con l’India non nasce un amore, ma una convenienza strategica reciproca. E, di questi tempi, è già molto.