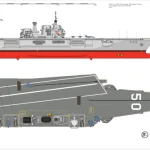Nel festival di El Gouna, sette giovani registi palestinesi raccontano la loro terra assediata, dove Israele considera una telecamera alla stregua di un’arma. Una lotta che parla anche a noi, in un tempo in cui la libertà di stampa — da Gaza a Roma — viene trattata come un rischio da contenere.
Filmare sotto le bombe
“Israele tratta una telecamera come un Kalashnikov.”
La frase del regista palestinese Ala Damo, raccolta da Gaza, non è un’esagerazione.
Per chi tenta di documentare la guerra, ogni inquadratura può essere l’ultima. Le bombe cadono mentre le telecamere riprendono, e i registi — spesso senza corrente, acqua o cibo — continuano a girare, mossi da un unico impulso: proteggere la memoria.
La sezione Finestra sulla Palestina del Festival del Cinema di El Gouna ha presentato sette cortometraggi girati a Gaza da giovani autori che rischiano la vita per offrire al mondo uno sguardo dall’interno.
Sono film nati tra le macerie, montati in tende, registrati con cellulari. Ma raccontano la verità più nitida che abbiamo: non quella dei numeri, ma quella dei volti.
La guerra contro le immagini
“Il dolore può davvero essere documentato?”, chiede la madre di Damo nel film Gaza agli Oscar.
È la domanda che ogni giornalista, fotografo o documentarista si fa in tempo di guerra. Ma oggi, sempre più spesso, la risposta viene imposta dall’alto: “no”.
Chi controlla la narrazione, controlla la guerra.
E così, a Gaza come altrove, filmare è diventato un crimine.
Un drono può scambiare una camera per un’arma; un soldato può eliminare un regista perché “sospetto”. Ma la verità è che la paura delle immagini è la paura della memoria.
Perché la storia scritta dai vivi sopravvive ai comunicati dei governi.
La libertà di raccontare: un problema anche nostro
È facile pensare che tutto questo riguardi solo Gaza, un mondo lontano, oppresso dal conflitto.
Eppure la questione è universale. Anche in Italia, dove un’inchiesta giornalistica può essere seguita da minacce, cause, o querele temerarie, il diritto di raccontare è sotto attacco.
Il caso di Sigfrido Ranucci — giornalista d’inchiesta finito nel mirino per il suo lavoro — dimostra che, pur in democrazia, il potere non sopporta lo sguardo.
Cambia il contesto, ma la logica è la stessa: chi racconta troppo diventa pericoloso.
E così, tra Gaza e Roma, la libertà di informare si misura non più solo con la censura, ma con la paura.
Cinema come sopravvivenza
I giovani registi palestinesi non cercano l’eroismo. Cercano di vivere.
Reema Mahmud filma una cantante di 22 anni che registra la sua voce in un’auto, dopo aver perso padre e fratello.
Muhamed al Sharif racconta un ragazzo arrestato mentre cercava farina.
Itimad Wishah segue donne nei campi profughi che continuano a truccarsi, a cucire, a sognare.
Non sono solo storie di guerra. Sono atti di resistenza culturale.
Mentre il mondo scorre sulle cifre dei morti, questi film ricordano che dietro ogni numero c’è un nome, un suono, un gesto.
È il potere del cinema: non fa politica, ma restituisce dignità.
La battaglia dell’opinione pubblica
“C’è una guerra che non si combatte a Gaza ma nel mondo,” dice il produttore Rashid Masharawi.
Ha ragione. È la guerra per l’opinione pubblica, quella che si gioca sulle immagini e sulle parole.
Ogni volta che una redazione viene intimidita, ogni volta che un film viene censurato o un giornalista ridotto al silenzio, vince la propaganda e perde la democrazia.
In questa guerra invisibile, Gaza è solo il fronte più crudo. Ma i campi di battaglia sono ovunque: nelle redazioni europee, nei social media manipolati, nelle minacce a chi racconta ciò che il potere preferirebbe tacere.
Difendere chi racconta
Un Paese che zittisce chi documenta smette di essere libero.
Difendere i giornalisti, i registi, i fotografi — da Gaza a Rai 3 — non è un gesto di solidarietà corporativa, ma un dovere civile.
Perché senza immagini libere, ogni società diventa una narrazione controllata, un reality senza verità.
I registi di Gaza, che continuano a girare tra le bombe, ci ricordano una lezione elementare: la libertà non si difende con le armi, ma con le storie.
E finché ci sarà qualcuno disposto a filmare anche nel buio, la verità, per quanto scomoda, non potrà essere completamente sepolta.
Israele può trattare una telecamera come un fucile.
Ma la differenza è che una telecamera spara luce, non piombo.
E quella luce — fioca, tremante, ostinata — è l’unica che può ancora attraversare i muri dell’assedio, fisico o mediatico, che soffoca il mondo.