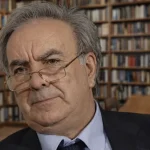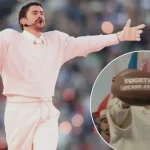Dalle rivoluzioni etero-dirette in America Latina alle ingerenze nella strategia della tensione italiana: un secolo di interventi che hanno piegato la sovranità dei popoli a interessi geopolitici, energetici e strategici. Una riflessione sulle rivoluzioni costruite dall’alto e sui loro costi umani.
Ci sono pagine della storia che nessuno ama sfogliare. Sono le pagine in cui le rivoluzioni non nascono da una piazza gremita, ma dall’ombra di un ufficio. Rivoluzioni senza il calore della gente, senza il respiro di un popolo stanco che reclama dignità, ma figlie del progetto di qualcuno che vive lontano, spesso troppo lontano, da quel popolo. Le chiamano “primavere”, “transizioni democratiche”, “operazioni di stabilizzazione”: parole luminose, quasi poetiche. Eppure, quando le si osserva più da vicino, il loro lucore svanisce e lascia emergere un’altra trama, molto meno ideale: interessi strategici, rotte energetiche, equilibri geopolitici che valgono più dei diritti che si dichiarava di voler difendere.
Gli Stati Uniti non sono stati gli unici a praticare quest’arte sottile del cambiamento pilotato, ma certamente ne sono stati i più metodici. La loro politica estera, spesso narrata come una missione di libertà, è punteggiata di rivoluzioni costruite passo dopo passo, con una coreografia riconoscibile: prima si scredita un governo, poi si appoggia un’opposizione “civile”, si provoca una frattura istituzionale e infine si interviene “per salvare la democrazia”, lasciando al suo posto un governo più malleabile.
Le tappe della storia sono chiare: Panama, dove Noriega, amico fino al giorno prima, divenne il nemico perfetto; il Guatemala, dove la riforma agraria di Árbenz urtò gli interessi della United Fruit e fu etichettata come sovversiva; il Cile, con Allende trasformato in minaccia globale e Pinochet in salvatore dell’ordine; l’Iran di Mossadeq, colpevole di aver nazionalizzato il petrolio. E poi Nicaragua, Haiti, Grenada, il Congo, la Repubblica Dominicana: un intero emisfero segnato da cicatrici profonde, mai completamente rimarginate.
A ogni intervento la retorica era la stessa: difendere i diritti umani, combattere la corruzione, proteggere la libertà. Ma di volta in volta la realtà era molto meno lirica. C’erano in gioco banane, rame, petrolio, basi strategiche, canali marittimi. Una moralità selettiva travestita da idealismo, una contraddizione che l’Occidente fatica ancora oggi ad affrontare. Perché i popoli non dimenticano. Conservano nella memoria i presidenti deposti, le elezioni manipolate, le valigie di dollari consegnate sotto banco, i bombardamenti ribattezzati “missioni umanitarie”. E ricordano soprattutto che la libertà non è un bene di consumo da esportare sotto scorta militare: ogni volta che si tenta di farlo, il risultato è l’opposto.
Durante la Guerra Fredda circolava una formula elegante, plausible deniability, la “negabilità plausibile”: fai tutto, purché nessuno possa dimostrarlo. Ma anche quando i tribunali non trovano colpevoli, restano i morti, restano le città ferite, resta il costo umano di rivoluzioni imposte dall’alto. Chi paga non è mai chi decide; pagano i contadini che non capiscono cosa stia accadendo, gli insegnanti che vedono svanire la loro scuola, i ragazzi che scendono in piazza credendo di difendere un ideale e senza sapere di essere comparse in un copione scritto altrove.
E non serve guardare oltre oceano per riconoscere la stessa logica. L’Italia, negli anni bui della strategia della tensione, ha conosciuto l’odore acre delle ingerenze. Mentre le bombe laceravano le piazze e le stazioni, non era solo il terrorismo interno a muoversi. Nelle pieghe della Repubblica agivano fili sottili e mani esterne. C’era Gladio, la rete clandestina della Guerra Fredda, ufficialmente pensata per resistere a un’invasione sovietica, ma per anni presenza oscura nel sottosuolo politico del Paese. C’era la P2, una loggia che non era soltanto massoneria “deviata” ma un vero progetto di rifondazione parallela dello Stato: media addomesticati, servizi fedeli, istituzioni piegate. E c’erano gli attentati e i depistaggi, da Piazza Fontana alla stazione di Bologna, ferite ancora aperte che ricordano quanto facilmente un Paese possa essere trasformato in una scacchiera manipolata da interessi che non hanno volto.
Non erano rivoluzioni dichiarate, non c’erano bandiere né slogan. Ma furono comunque forme di rivoluzione rovesciata: non dal popolo verso l’alto, ma dall’alto verso il popolo. E quanto più arrivavano dall’alto, tanto più presentavano un conto salato, quasi sempre pagato dai più fragili.
La verità, dunque, è semplice e scomoda. Le rivoluzioni autentiche nascono dal basso, dalla lentezza del cambiamento quotidiano, dalla voce di chi costruisce e non di chi impone. Le rivoluzioni imposte, che siano sostenute da logge o eserciti, da operazioni segrete o pressioni economiche, hanno sempre un prezzo nascosto che ricade sui cittadini.
La libertà non si esporta, non si impone, non si compra. La libertà si costruisce, fragile e faticosa, e richiede una condizione essenziale: rispettare la libertà degli altri. Sempre.
Forse è tempo di smettere di fabbricare rivoluzioni per procura e cominciare a riconoscere, con umiltà, quella più vera: la rivoluzione silenziosa con cui ogni popolo, giorno dopo giorno, prova semplicemente a diventare se stesso.