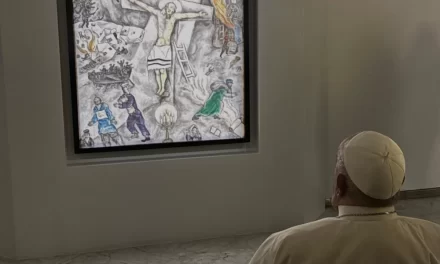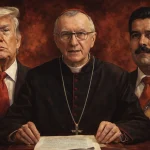EDITORIALE: C’è un paradosso che attraversa ogni guerra: più gli uomini credono di controllarla, più ne diventano prigionieri. Anche oggi, tra i calcoli di Trump, le mosse di Putin e le attese dell’Europa, riaffiora una verità antica: la pace non nasce mai da una somma di interessi, ma da un atto di giustizia.
Nella tradizione cristiana, la prudenza non è la virtù dei timidi, ma dei saggi. È la capacità di scegliere il bene possibile, non l’ideale irraggiungibile. In questo senso, dire “no” ai missili e “sì” alle sanzioni può sembrare una scelta debole, ma in realtà riconosce un limite morale: nessuna vittoria giustifica la distruzione dell’altro.
San Giovanni XXIII, nell’enciclica Pacem in terris, ricordava che la pace “non si fonda sull’equilibrio degli armamenti”, ma sul riconoscimento dei diritti e dei doveri reciproci. Oggi questa lezione vale più che mai. Non esiste pace senza verità, ma neppure senza umiltà: quella di ammettere che nessuna potenza, neppure la più armata, può salvare il mondo da sola.
L’Ucraina ha bisogno di giustizia e di sostegno, ma anche di un orizzonte umano. Le sanzioni possono rallentare la guerra, ma solo il perdono potrà guarirla. La diplomazia potrà fermare i missili, ma solo la misericordia potrà restituire ai popoli il coraggio di guardarsi negli occhi.
In fondo, come ammoniva Paolo VI, “la politica è la forma più alta della carità”. Se tornerà ad esserlo, forse, da questa guerra potrà ancora nascere una pace giusta.
«Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,9).
In un mondo che misura la forza con i missili e l’influenza con le sanzioni, Gesù propone un’altra logica: quella del cuore disarmato. La pace non si impone, si genera. Nasce quando il potere si piega alla compassione e la prudenza diventa servizio alla vita.
Essere operatori di pace, oggi, significa scegliere di non rispondere alla violenza con la violenza, ma con la giustizia e la verità. È la diplomazia del Vangelo: quella che non ha eserciti, ma mani tese.