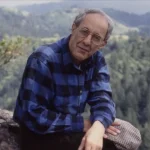Ogni 2 novembre, nella Commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa offre ai credenti la possibilità di ottenere indulgenze in suffragio delle anime del Purgatorio. È un gesto antico, spesso mal compreso, eppure profondamente evangelico: unire i vivi ai defunti in un legame di carità che non si spezza con la morte.
La parola “indulgenza”, nel linguaggio odierno, rischia di evocare immagini distorte — mercimonio spirituale, meccanismi magici, residui medievali. Ma la Chiesa del nostro tempo, con la pazienza delle madri, continua a proporla come un linguaggio di misericordia e comunione, non di contabilità sacra.
Una storia lunga, una fede più lunga ancora
Le indulgenze nascono molto prima che la parola si formi. Nei primi secoli, quando la penitenza pubblica era severa, i martiri in attesa del dono supremo intercedevano per i penitenti, mitigandone il percorso. Era l’eco di una Chiesa che si percepiva come un solo corpo: se uno soffre, tutti soffrono; se uno offre, tutti sono sostenuti.
Col tempo — soprattutto quando si consolidò la dottrina del Purgatorio come luogo/condizione di purificazione — la pratica assunse un’altra tonalità: offrire opere, preghiere, pellegrinaggi perché chi era morto nella grazia potesse compiere più pienamente il suo cammino verso la luce.
È vero: nel Medioevo non mancarono abusi, e quell’ombra pesa tuttora nella memoria storica. Ma ridurre l’indulgenza a quegli eccessi significherebbe ignorare il suo cuore evangelico: la convinzione che la salvezza è un bene condiviso, che nessuno cammina da solo, che la grazia crea legami, non solitudini spirituali.
Dal Concilio a oggi: luce e discernimento
La questione riemerse anche al Concilio Vaticano II. Alcuni padri avrebbero voluto una riforma più netta; altri, soprattutto dalle giovani Chiese, la superarono perfino come linguaggio. Non si arrivò a un testo conciliare specifico, ma il tema entrò comunque nel discernimento ecclesiale.
Fu Paolo VI a proporre, nel 1967, una sintesi autorevole con l’apostolica costituzione Indulgentiarum Doctrina. Non ruppe con la tradizione, ma la purificò e la riportò all’essenziale: l’indulgenza è «remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati già perdonati», dono che la Chiesa distribuisce attingendo ai meriti di Cristo e dei santi. Niente mercato di grazie, ma comunione di amore. Il Catechismo riprenderà testualmente questa definizione (CCC 1471).
Papa Francesco, nel suo stile pastorale, non ha insistito sui tecnicismi, ma sulla dinamica di fondo: la misericordia che guarisce, la Chiesa che accompagna, i legami che restano. Così, anche il linguaggio delle indulgenze, liberato dalle caricature, ritorna alla sua radice: un atto di fiducia nel Dio che vuole tutti con sé.
Cosa accade il 2 novembre
In questo giorno, e durante l’ottava, chi visita un cimitero, prega per i defunti, si confessa, riceve l’Eucaristia e si unisce all’intenzione del Papa, può offrire un’indulgenza plenaria per una persona cara defunta. Non si “accorciano tempi”: si intensifica l’amore. Si consegna a Dio ciò che non possiamo compiere da soli.
È un gesto che educa alla comunione profonda, che ricorda che la morte non rompe la fraternità, che l’intercessione è il linguaggio più umile e più potente della fede.
Un gesto attuale, più che mai
In un’epoca che vive il lutto spesso in solitudine e che teme il legame con i propri morti, le indulgenze ci ricordano una cosa semplice e immensa: siamo ancora famiglia. La memoria cristiana non è malinconia, è responsabilità reciproca; non è culto del passato, ma tenerezza verso chi ci ha preceduto. È credere che l’amore non si spreca, non si interrompe, non si ammutolisce con la morte.
E così, quando portiamo un fiore, accendiamo una candela, sussurriamo un nome, compiamo un atto che nessun secolo ha mai potuto ridicolizzare davvero: affermiamo che la vita non è un arco chiuso, ma un ponte di luce.
Il 2 novembre è allora un giorno di fede e cultura insieme: un popolo che non rinuncia ai suoi morti, non rinuncia neanche al futuro.