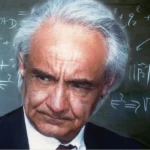Nei dossier su Jeffrey Epstein i nomi dei potenti fanno rumore, quelli delle vittime restano spesso muti: cancellati, oscurati, compressi in rettangoli neri. Eppure è lì, in quelle assenze, che si intravede la vera architettura dell’abuso: un sistema di reclutamento che non cercava “ragazze” in astratto, ma bisogni specifici — denaro, futuro, riconoscimento, protezione — da trasformare in dipendenza. Epstein non adescava soltanto corpi: adescava destini.
C’è una domanda che ritorna, come un sussurro ostinato, ogni volta che la cronaca riesuma l’universo Epstein: com’è possibile? Come può un uomo costruire un impero di predazione che attraversa decenni, Stati, continenti, e che sembra rinnovarsi come una multinazionale del ricatto? La risposta più comoda è la più cinematografica: l’isola, i voli, gli ospiti illustri, la leggenda nera di un “giro” al servizio dei potenti. Ma se si vuole capire — davvero capire — occorre spostare lo sguardo: dal mito dei clienti all’ingegneria delle vittime.
Epstein era un predatore con un talento raro: sapeva promettere. E, soprattutto, sapeva cosa promettere a ciascuna. Non vendeva la stessa illusione a tutte. Non era un seduttore seriale; era un selezionatore sociale. Aveva imparato a riconoscere, in pochi minuti, il punto in cui una persona è più esposta: ciò che manca, ciò che brucia, ciò che non si osa chiedere ad alta voce. A una ragazza povera offriva contanti; a una ragazza “di talento” offriva futuro; a una giovane aspirante offriva accesso; a una famiglia offriva rassicurazioni. Il suo capitale non era solo il denaro: era la credibilità che il denaro compra quando si traveste da filantropia.
Il dettaglio decisivo — quello che molti trascurano perché non è spettacolare — è la selezione per classe. In Florida, la caccia era spesso diretta verso adolescenti vulnerabili: il bisogno immediato, la precarietà, la casa fragile, l’urgenza di aiutare la famiglia. Qui il linguaggio era semplice: soldi per un “massaggio”, pagamenti rapidi, regali, piccoli privilegi che diventavano catene. A New York il lessico cambiava: borse di studio, consigli per l’ammissione al college, inviti a eventi, promesse di mentoring culturale. Là dove la povertà non era la leva, lo era l’ambizione. E l’ambizione, come la povertà, può diventare una necessità.
Chi cerca una sola “spiegazione” sbaglia bersaglio. Epstein costruì un dispositivo a più ingressi: un sistema che intercettava bisogni differenti e li ordinava in una gerarchia crudele. Alle più giovani offriva denaro e attenzione; alle più grandi offriva “opportunità”; ad alcune offriva perfino un simulacro di protezione, come se l’abuso fosse il prezzo di un’adozione simbolica nella casa del potere. È qui la sua genialità criminale: fare dell’asimmetria una normalità. Quando ti convincono che ti stanno aiutando, la vergogna si incolla alla lingua e il silenzio diventa parte del contratto.
Poi c’è il capitolo più disturbante: la trasformazione delle vittime in reclutatrici. È la dinamica piramidale dell’abuso: chi è intrappolato viene spinto a trascinare altri, spesso amici, compagne di scuola, parenti, perché il sistema ha bisogno di rinnovarsi e perché così si moltiplica il senso di colpa. Non è solo “organizzazione”: è psicologia del dominio. Se ti costringo a portare qualcun’altra, diventi più controllabile: la tua storia non è più soltanto tua. La rete si autoperpetua attraverso legami di fiducia deformati. È una perversione della socialità: l’amicizia usata come corridoio di servizio per l’orrore.
In questo quadro, la figura di Ghislaine Maxwell — al di là dei profili giudiziari — assume un significato funzionale: non un dettaglio biografico, ma un dispositivo di accesso. In un mondo in cui un uomo adulto che avvicina un’adolescente suscita allarme, una donna “elegante”, apparentemente premurosa, può trasformare la diffidenza in conversazione. È un passaggio sottile, quasi invisibile, eppure decisivo: l’abuso, prima di essere fisico, è un’opera di normalizzazione.
Il sistema aveva anche una geografia: case, ranch, isola, appartamenti, hotel, voli. Ma sarebbe un errore leggere questi luoghi come scenografie. Erano ingranaggi. Ogni spazio serviva a isolare, spostare, confondere, rendere la fuga logisticamente difficile e psicologicamente impensabile. Viaggiare, per molte, non era privilegio: era disorientamento. Essere “portate” altrove non era glamour: era perdere coordinate, perdere rete, perdere voce.
E qui arriviamo alla pagina più amara, quella che spiega perché nei file abbondano i nomi celebri e le vittime restano “scatole nere”. La potenza di Epstein non era soltanto la capacità di adescare: era la capacità di impacchettare la predazione in una cornice socialmente rispettabile. Donazioni, fondi, relazioni, consigli accademici, contatti: tutta una filiera di reputazione che, anche senza complicità criminale, produceva un effetto devastante. Perché la reputazione funziona come un anestetico collettivo: rende incredibile la denuncia e plausibile l’alibi. “Un benefattore”, “un mecenate”, “un uomo con accesso”. Il potere non sempre abusa direttamente; spesso crea l’aria in cui l’abuso respira.
Ecco allora la tesi — scomoda, ma necessaria — che un elzeviro non può evitare: la storia di Epstein non è soltanto la storia di un predatore e delle sue vittime. È anche la storia di un ecosistema in cui le ragazze diventano invisibili non per caso, ma per struttura. Quelle barre nere sui documenti non sono solo privacy; sono il simbolo di una cultura che sa nominare il prestigio e fatica a nominare la fragilità. Sappiamo elencare gli ospiti, ma non ricordiamo le ragazze. Sappiamo ricostruire itinerari di jet, ma non sappiamo riparare biografie spezzate.
E alla fine resta un paradosso: il denaro, che è stato la leva del controllo, diventa anche l’unico linguaggio con cui lo Stato e la società provano a chiamare “giustizia” una riparazione. Fondi, accordi, transazioni, clausole di riservatezza. Ma la giustizia, per chi ha vissuto la predazione come destino imposto, non è un bonifico: è una narrazione restituita. È poter dire “è successo” senza pagare ancora il prezzo dell’umiliazione. È vedere riconosciuto che l’abuso non è stato un inciampo individuale, ma un sistema.
Per questo le donne dietro le “scatole nere” sono il vero centro della vicenda. Finché restano ombre, continueremo a raccontare Epstein come leggenda torbida, come gossip geopolitico, come scandalo dei salotti. Quando, invece, cominciamo a vedere il suo metodo — la gerarchia della vulnerabilità, l’uso della classe sociale, la filantropia come cavallo di Troia, la piramide del reclutamento — la storia smette di essere un thriller e torna a essere ciò che è: una lezione sull’asimmetria. Su come il potere, quando vuole predare, non entra dalla porta della violenza: entra dalla porta della promessa.