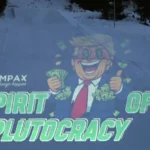C’è una domanda che torna, puntuale, ogni volta che l’umano si presenta con il volto concreto delle sue ferite e delle sue promesse: la morale può cambiare?. Non è una curiosità da salotto accademico; è una domanda pastorale, dunque teologica, dunque drammatica. Perché tocca il punto in cui la Chiesa rischia il peggio: scambiare la fedeltà con l’immobilità, e la verità con il controllo.
Il volume di Giovanni Del Missier e Roberto Massaro (Accademia Alfonsiana), La morale può cambiare? (San Paolo, 2025), prende sul serio la questione e lo fa senza scorciatoie. La tesi non è: “cambiamo le norme perché il mondo è cambiato”. È più esigente: cambiare può essere l’unico modo per restare fedeli, quando i linguaggi, i quadri antropologici e perfino le “regole di lettura” della realtà non reggono più la vita reale delle persone.
Non relativismo, ma incarnazione: la morale come scienza pratica
Il primo equivoco da disinnescare è quello più comodo: se ascolti i vissuti, allora relativizzi; se contestualizzi, allora dissolvi l’universale; se introduci il discernimento, allora indebolisci la norma. È un sillogismo elegante e falso.
La tradizione morale cattolica è nata e cresciuta proprio dentro questo attrito: tra norma generale e decisione concreta, tra principio e prudenza, tra il bene che si deve e il bene che si può. Da Tommaso fino ad Alfonso, passando per dispute e sistemi morali, la teologia ha sempre saputo che l’universalità non è una livella meccanica. È un orientamento, non un calco.
Del Missier e Massaro lo dicono con una formula che merita di essere meditata: la morale è anzitutto scienza pratica, e perciò s’interessa della vita vera — dei conflitti tra valori, dei condizionamenti, delle fragilità, delle responsabilità che non si assumono nel vuoto. Qui sta il cuore dell’operazione: sottrarre l’etica cristiana al rischio di una “morale fredda, elaborata a tavolino” (l’eco di Amoris laetitia è evidente) e restituirla alla sua vocazione: accompagnare, discernere, salvare.
E la frase decisiva è questa: il fine della verità morale non sono le norme — realtà penultime — ma la salvezza. Chi si scandalizza dovrebbe ricordare che è scandalosa anche l’Incarnazione: Dio non salva dall’alto dei concetti, ma entrando nelle pieghe della storia.
“Cambio di paradigma”: non una moda, ma una necessità epistemologica
Il libro usa, con cautela ma decisione, la categoria del “cambio di paradigma”. Non come slogan, ma come strumento per nominare un dato: ci sono momenti in cui l’apparato concettuale con cui si interpretava la realtà non riesce più a renderla intelligibile né abitabile. E allora non basta “aggiustare” qualche casella: occorre ripensare l’impianto.
È un passaggio delicato, perché nella Chiesa la parola “paradigma” fa paura: sembra autorizzare ogni rottura. Ma gli autori non propongono una “rivoluzione permanente”. Propongono un criterio classico: sviluppo nella continuità, con svolte reali quando la fedeltà al kerygma lo esige.
Lo spiegano bene con immagini che valgono più di molte note: la foto digitale, uniforme da lontano e “discontinua” se ingrandita nei pixel; e soprattutto un esempio storico che taglia corto a molti falsi tradizionalismi: a Nicea la Chiesa introduce un termine extrabiblico, homoousios, per custodire la fede. Non cambiò il Vangelo; cambiò il linguaggio per non tradirlo.
L’ascolto delle coscienze: 190 operatori pastorali e quattro nodi esplosivi
Il secondo gesto del libro è altrettanto significativo: far parlare le coscienze ecclesiali. Non in forma di plebiscito, ma con un questionario a 190 operatori e operatrici pastorali su quattro aree dove oggi si concentrano tensioni e sofferenze: relazioni omoaffettive, convivenze, ruolo della donna nella Chiesa, incongruenza di genere e integrazione comunitaria.
Qui emerge un punto che spesso viene negato con ostinazione: molte persone amano la Chiesa, restano nella Chiesa, ma faticano a comprendere un certo magistero su affettività e sessualità e sperimentano esclusione, giudizio, distanza. L’interrogativo, allora, non è se “la dottrina” debba diventare più simpatica. È se la Chiesa possa permettersi di parlare dell’umano senza ascoltare l’umano, come se la vita fosse solo un test di conformità.
Ne nasce una prospettiva “attivo-induttiva”: partire dall’esperienza, leggerla criticamente, far emergere il bene possibile, elaborare categorie che non siano né lassismo né legalismo. Non è una resa: è una pedagogia morale.
Universalità, inculturazione e fine dell’eurocentrismo morale
C’è poi una domanda che pesa come una pietra: da dove viene la pretesa di universalità della morale cattolica, soprattutto su sessualità e matrimonio, quando spesso appare un modello occidentale esportato?
Gli autori rispondono da cristiani: l’universalità non è un’etnografia travestita da teologia; è Cristo, l’umano pieno. Ma proprio per questo l’annuncio deve interrogarsi: come si declina la sequela nei contesti differenti, senza imporre un modello eurocentrico?
La citazione di Amoris laetitia (n. 3) è programmatica: unità di dottrina e prassi non impedisce diversi modi di interpretare aspetti della dottrina e conseguenze; anzi, invita a soluzioni più inculturate, attente alle tradizioni e alle sfide locali. Se questa frase non viene presa sul serio, il cattolicesimo diventa una globalizzazione ecclesiastica: stessa lingua per tutti, stesso peso per tutti, stessa ferita per molti.
Psicologia sì, psicologismo no: oltre Drewermann senza ricadere nel moralismo
Un passaggio interessante dell’intervista riguarda ciò che è cambiato negli ultimi decenni: l’attenzione ai vissuti e alle dimensioni psicologiche non è più letta come riduzione terapeutica della fede, ma come parte di un quadro storico, culturale, ecclesiale. Il soggetto non è isolato: è situato. La psicologia non è criterio ultimo: è interlocutore. I vissuti non sono soltanto “sintomi”: sono luoghi di senso, talvolta luoghi in cui la grazia chiede un linguaggio nuovo.
È una correzione doppia: evitare la scorciatoia psicologistica e, insieme, evitare la tentazione opposta — il ritorno a una norma senza carne. La teologia, dicono, cresce nel dialogo con altri saperi, come suggerisce anche Gaudium et spes (n. 44): Chiesa e mondo non come nemici, ma come realtà in relazione critica e feconda.
Omosessualità, identità sessuata e legge naturale: un nodo delicato e decisivo
Quando la riflessione morale affronta l’ambito della sessualità, il linguaggio si fa inevitabilmente più teso: non per gusto di polemica, ma perché qui si toccano la persona, la coscienza e il modo stesso di intendere il bene umano. Gli autori propongono un’impostazione che intende muoversi nella continuità della tradizione, senza però ignorare le acquisizioni conoscitive del nostro tempo.
Il ricorso a san Tommaso, dunque, non è un semplice “ritorno alle formule”, ma un richiamo al suo metodo: partire da ciò che è veramente umano e cercare il bene secondo ragione illuminata dalla fede. In questa prospettiva, gli autori osservano che oggi l’omosessualità viene spesso compresa come una condizione relativamente stabile della persona — una configurazione dell’identità che, nei termini odierni, l’Aquinate non poteva avere davanti. Da qui l’esigenza di riformulare alcune categorie, mantenendo fermo l’orizzonte della dignità della persona e della verità dell’amore.
Il quadro proposto si articola su tre punti:
- La sessualità come atto umano personale, non riducibile al solo dato biologico: ciò che conta moralmente è l’integrazione della dimensione corporea nella libertà, nell’affettività e nella responsabilità, secondo una visione unitaria della persona.
- Un discernimento prudente sul linguaggio contemporaneo dell’identità sessuata: senza assumerne acriticamente le impostazioni ideologiche, si riconosce che le categorie odierne cercano di descrivere fenomeni reali e vissuti complessi, che chiedono ascolto e valutazione, non sbrigative liquidazioni.
- Una ripresa della legge naturale in senso classico e non riduttivo: non come “codice biologico” applicato meccanicamente, ma come orientamento della ragione al bene proprio dell’uomo, capace di confronto con la cultura e con le scienze, come già sollecitato anche dal magistero recente.
È su questo crinale che la teologia morale mostra la sua statura: restare fedele ai principi senza diventare astratta, e saper indicare vie di bene nella concretezza delle situazioni, senza smarrire né la verità dell’umano né la dignità inviolabile delle persone.
Tradizione viva: non una pietra, ma un organismo
Alla fine, la questione “la morale può cambiare?” diventa una prova di fede ecclesiale. Se la dottrina è concepita come statica, ogni mutamento sembra tradimento. Ma se la tradizione è un organismo vivo, capace di crescere anche attraverso crisi e svolte, allora il cambiamento può essere un atto di fedeltà, non di infedeltà.
La vera alternativa non è tra “norma” e “relativismo”. È tra una Chiesa che accetta la fatica del discernimento — e quindi della storia — e una Chiesa che si protegge dietro formule astratte, perdendo le persone mentre difende le definizioni.
Forse, allora, la domanda corretta non è se la morale può cambiare. È se la Chiesa può permettersi di non cambiare linguaggio, categorie e prassi quando questi non riescono più a dire il bene e a custodire l’umano. Perché l’unica cosa che non può cambiare è questa: che la verità cristiana è per la vita, e la vita concreta è il luogo in cui la verità deve diventare buona notizia.