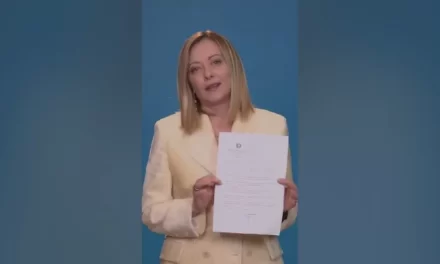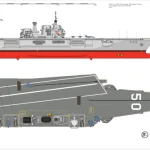C’è una parola che ritorna con insistenza nel racconto americano degli ultimi raid in Siria: vendetta. Non deterrenza, non stabilizzazione, non sicurezza collettiva, ma vendetta. Quando Donald Trump annuncia un’operazione militare “massiccia” contro le cellule dell’ISIS dopo l’uccisione di soldati statunitensi a Palmira, non parla il lessico del diritto internazionale, bensì quello dell’offesa da lavare. È una scelta linguistica che precede – e orienta – la scelta politica.
Dal punto di vista strettamente militare, l’operazione appare efficace: decine di obiettivi colpiti, infrastrutture distrutte, comandanti eliminati. La precisione tecnologica viene rivendicata come garanzia morale. Eppure, proprio questa retorica dell’efficienza rischia di nascondere il problema di fondo: la forza che punisce non è automaticamente la forza che pacifica.
Il ritorno dell’ISIS nel discorso pubblico – dopo anni in cui lo si dava per sconfitto – rivela una verità scomoda. Il jihadismo non è solo un fenomeno territoriale, ma una patologia cronica degli spazi instabili. Finché la Siria resta una geografia frammentata, attraversata da potenze esterne, milizie locali, interessi incrociati, l’estremismo trova sempre fessure in cui riorganizzarsi. Colpire le cellule è necessario; credere che basti è illusorio.
La novità più rilevante, semmai, è politica. Gli attacchi avvengono con l’assenso – esplicito o tacito – del nuovo governo siriano post-Assad, desideroso di legittimazione internazionale. La Siria che fino a ieri denunciava ogni incursione come violazione della sovranità oggi coopera, o quantomeno acconsente. È il prezzo dell’uscita dall’isolamento: la sovranità come bene negoziabile.
In questo quadro si inserisce anche il coinvolgimento della Giordania, memoria ancora viva dell’orrore inflitto dall’ISIS dieci anni fa con l’uccisione del suo pilota. Qui la partecipazione militare ha una valenza simbolica forte: non solo sicurezza, ma risarcimento morale. E tuttavia, anche questa memoria rischia di essere utilizzata come combustibile per una strategia che resta essenzialmente reattiva.
Il nodo centrale non è l’ISIS – che sopravvive proprio grazie alla frammentazione regionale – ma l’assenza di un ordine politico condiviso. Gli Stati Uniti colpiscono dal cielo, Israele avanza sul terreno nel sud della Siria, le forze curde presidiano porzioni di territorio, Damasco cerca di rimettere insieme ciò che resta dello Stato. Ognuno agisce in nome della sicurezza; nessuno costruisce davvero la pace.
Il paradosso è evidente: mentre Washington proclama di “ripristinare la pace attraverso la forza”, il terreno siriano continua a essere attraversato da incursioni, raid, posti di blocco, violazioni di accordi internazionali come quello del 1974 sul Golan. La pace viene evocata, ma mai definita. È un orizzonte retorico, non un progetto.
C’è infine un elemento culturale che non va sottovalutato. Il linguaggio della vendetta, quando viene adottato da una superpotenza, normalizza la logica dell’eccezione permanente. Se la forza diventa risposta identitaria all’offesa, ogni attore regionale si sente autorizzato a fare lo stesso. È così che il Medio Oriente resta intrappolato in una spirale di azioni “necessarie”, ciascuna delle quali rende la successiva inevitabile.
La sconfitta dell’ISIS nel 2018 aveva illuso molti che il problema fosse chiuso. Oggi appare chiaro che non lo era. Ma la lezione più amara è un’altra: non si può bombardare l’assenza di uno Stato, né colpire con missili il vuoto della politica. Finché la Siria resterà un campo di prova per vendette incrociate e riabilitazioni opportunistiche, la pace continuerà a essere promessa nei discorsi e smentita sul terreno.
La forza, da sola, può vendicare.
Ma senza una visione condivisa, non sa costruire.