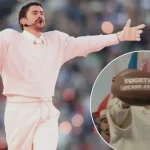La notizia rimbalza dagli Stati Uniti, riportata dal Wall Street Journal, e lascia interdetti: la Siria sarebbe entrata a far parte della coalizione anti-Isis. Una frase che, letta così, sembra quasi un paradosso. Perché implica che uno degli attori che negli anni più bui del conflitto iracheno e siriano ha osservato con ambiguità l’ascesa del jihadismo, ora venga presentato come membro della coalizione chiamata a combattere gli stessi gruppi con cui, direttamente o indirettamente, aveva condiviso spazi, interessi o tattiche di convenienza.
L’idea che uno dei protagonisti di quella stagione – fatta di massacri, deportazioni, assedi e atrocità contro cristiani e musulmani – possa oggi sedersi al tavolo degli alleati come se nulla fosse fa venire un brivido. È come se un piromane si presentasse come esperto di sicurezza antincendio proprio nel luogo del rogo che ha contribuito ad appiccare.
A rendere tutto ancora più surreale c’è una stretta di mano sconcertante: l’incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Ahmad Al Sharaa, nuovo leader della Siria e ex esponente del fronte jiahdista più duro dell’opposizione armata siriana. Un episodio che, al di là delle versioni e delle giustificazioni, rivelò un tratto inquietante della politica internazionale di quegli anni: la facilità con cui figure provenienti da contesti bellici opachi e segnati da accuse gravissime venivano accolte nello Studio Ovale come interlocutori legittimi, utili a rafforzare una narrazione o a colpire un avversario geopolitico.
E non è stata la prima volta:: sono reperibili su internet le foto di Trump sorridente, il drappo americano sullo sfondo, e davanti a lui personaggi che in molte inchieste internazionali erano stati associati – in forme diverse – alle zone grigie del conflitto siriano, ai gruppi armati più radicali, alle reti che avevano alimentato la spirale della violenza. Non si tratta di una banale foto di protocollo: è la dimostrazione di come la guerra siriana abbia trasformato carnefici, comandanti di milizie e figure compromesse in pedine del grande gioco diplomatico.
Lì, nello spazio simbolico per eccellenza della democrazia americana, si celebra dunque in più riprese una sorta di legittimazione politica di un mondo che, fino a pochi anni prima, veniva percepito come il cuore dell’instabilità mediorientale. E se allora la logica era quella di usare chiunque fosse utile pur di indebolire Damasco o Teheran, oggi lo scenario appare capovolto: gli stessi attori che in quel caos hanno prosperato, o che da quel caos sono stati protetti, vengono riciclati come partner della “lotta al terrorismo”.
Ed è proprio questo intreccio – la facilità con cui i ruoli si ribaltano, i percorsi si ripuliscono, le responsabilità si sciolgono – a rendere la notizia di oggi ancora più inquietante. Perché chi ha visto la guerra siriana davvero, chi ha ascoltato i sopravvissuti di Aleppo o di Deir ez-Zor, sa benissimo che in quel conflitto nessuno era innocente e che le alleanze mutavano con la stessa rapidità con cui mutavano i fronti.
E allora l’ingresso della Siria nella coalizione anti-Isis non è solo una contraddizione. È il simbolo di un sistema internazionale in cui basta cambiare palcoscenico per cambiare identità, in cui anche chi ieri flirtava con i peggiori tagliagole può ripresentarsi oggi come difensore della stabilità.
Ed è questo, forse, il monito più amaro: quando la geopolitica diventa teatro di maschere, la memoria delle vittime rischia di diventare il primo sacrificio.