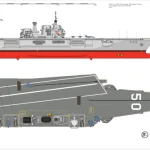Il discorso di Mattarella per gli auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile
C’è un filo discreto ma tenace che attraversa il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica: la pace non come parola cerimoniale, ma come struttura portante della vita democratica. Sergio Mattarella parte da lì, e non è una scelta casuale. In un tempo che sembra aver smarrito il vocabolario del limite, la pace torna a essere ciò che Franklin Delano Roosevelt chiamava “fine dei principi di tutte le guerre”: non una tregua, ma una conversione del pensiero.
Quando Mattarella richiama l’Ucraina e il Medio Oriente, non indulge alla cronaca. Ricolloca i conflitti dentro una cornice più ampia: la pace come affermazione del diritto sulla forza, come condizione di libertà e sviluppo. È una definizione esigente, perché non consente scorciatoie. La pace non è neutrale: chiede scelte, coerenza, responsabilità.
Il passaggio sullo sbarco in Normandia — i volti dei reduci, l’orgoglio silenzioso, il peso della memoria — restituisce alla storia europea il suo fondamento morale. L’Europa della pace non nasce per caso, ma da un trauma condiviso e da una volontà politica precisa: mai più la guerra come strumento ordinario della politica. È qui che la relazione transatlantica viene evocata non come vincolo geopolitico, ma come patrimonio di coscienza. Irreversibile, dice Mattarella. Non perché immune da crisi, ma perché radicato nei popoli prima che nei trattati.
Il nodo più delicato arriva quando il Presidente affronta il tema della difesa. La spesa militare, riconosce, è sempre impopolare. E tuttavia, “poche volte come ora, è necessaria”. È una frase che pesa. Non c’è entusiasmo, non c’è retorica bellicista. C’è il riconoscimento di un mondo in cui la sicurezza non è più garantita per inerzia storica. Ma la condizione posta è decisiva: la difesa ha senso solo nel quadro del diritto internazionale e come strumento di tutela della pace, non come sua negazione. È una linea sottile, che richiede vigilanza democratica costante.
Da qui il discorso scivola, con naturalezza, sulla salute della democrazia. Mattarella coglie una doppia minaccia: da un lato l’avanzata di modelli autoritari che si propongono come alternative efficienti; dall’altro la confusione crescente tra libertà e arbitrio, amplificata dalle tecnologie. È un passaggio di grande lucidità. La democrazia non muore solo per colpi di Stato, ma anche per erosione del senso del limite, per l’illusione che ogni desiderio possa diventare diritto senza mediazioni.
Il tema dell’astensionismo è forse il più inquietante, perché chiama in causa tutti. Una democrazia di assenti, avverte il Presidente, è una democrazia fragile. Non è un problema da archiviare il giorno dopo le elezioni. È una ferita strutturale. Quando la partecipazione si riduce a tifo per vincitori e vinti, la Repubblica perde spessore, diventa amministrazione senza anima.
Infine, l’economia. I dati rassicuranti non bastano a coprire le crepe: cinque milioni di poveri, il lavoro femminile sotto la media europea, i giovani ai margini, salari d’ingresso che non permettono futuro. Qui il discorso presidenziale si fa quasi sobrio fino alla durezza. Non c’è compiacimento. C’è la consapevolezza che senza giustizia sociale la pace resta incompiuta e la democrazia vulnerabile.
Il discorso di Mattarella non offre soluzioni facili. Offre una grammatica: pace, diritto, memoria, partecipazione, responsabilità. In un tempo di slogan e semplificazioni, è già molto. Forse è proprio questo il compito del Presidente: ricordare che la Repubblica non si regge sull’emergenza permanente, ma sulla paziente costruzione del bene comune. E che la pace, prima ancora di essere una politica estera, è una disciplina interiore delle istituzioni.