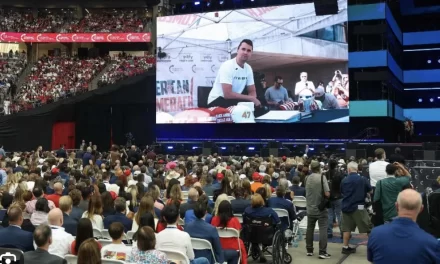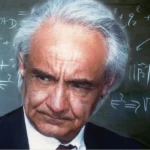Per decenni l’incubo europeo non è stato il ritorno del potere tedesco, ma la sua assenza: una Berlino prospera, pacifica, quasi “post-storica”, chiamata dagli alleati a fare di più mentre si schermiva dietro freni al debito e pudori strategici. Ora il pendolo torna indietro. La Germania si riarma davvero, promette di diventare il pilastro militare del continente e, proprio per questo, riapre una domanda che l’Europa credeva di aver archiviato: come si vive con un egemone, anche quando è “ben intenzionato”?
C’è un’Europa che, ogni volta che la storia accelera, riscopre le sue vecchie paure sotto parole nuove. Nel Novecento quelle paure avevano il volto della Germania armata e senza freni; nel dopoguerra, invece, si travestirono da speranza: legare la potenza tedesca a regole e istituzioni, trasformare un problema geopolitico in un progetto politico. L’Unione europea, con le sue procedure e i suoi compromessi, è stata anche questo: una grande macchina di “domesticazione” della forza, un modo per evitare che il baricentro del continente diventasse una minaccia per gli altri.
Ma le macchine funzionano finché non cambia l’energia che le alimenta. Oggi l’energia si chiama guerra — quella russa in Ucraina — e si chiama disimpegno americano, o quantomeno incertezza americana. Quando l’ombrello di Washington si accorcia, l’Europa si ritrova nuda davanti ai propri dilemmi. E il primo, inevitabile, è tedesco: perché nessun Paese europeo possiede, insieme, la capacità fiscale e industriale della Germania. Se bisogna produrre munizioni, finanziare sistemi d’arma, sostenere una spesa strutturale, Berlino è l’unica con il serbatoio abbastanza grande. Chi, fino a ieri, chiedeva “più Germania”, ora deve fare i conti con il prezzo della richiesta.
La “svolta epocale” annunciata nel 2022 — la promessa di diventare uno dei leader della difesa europea — non è più un discorso da conferenza, ma un calendario. Quando un Paese decide di trasformare il proprio profilo militare, non cambia soltanto il bilancio dello Stato: cambia il modo in cui viene percepito. È qui che l’Europa rischia di inciampare. Non perché la Germania voglia dominare domani mattina, ma perché la predominanza, una volta che esiste, produce effetti anche senza intenzione: genera aspettative, suscita sospetti, crea dipendenze. E le dipendenze, in politica internazionale, sono una forma elegante di vulnerabilità.
In teoria, il continente dovrebbe essere sollevato: una Germania che spende e dispiega è una Germania che prende sul serio la minaccia russa. In pratica, però, le memorie europee sono lunghe e le gelosie strategiche più vive di quanto si ammetta. Parigi, che da sempre custodisce il riflesso della “grandeur”, osserva il riarmo tedesco come si guarda un vicino che allarga casa: con un sorriso di circostanza e la mano già sul metro. Varsavia, che conosce meglio di tutti il costo dei compromessi tra potenze, teme un domani in cui una Germania più forte possa ritenersi libera di “riaprire canali” con Mosca quando le converrà. E gli Stati più piccoli, quelli che nell’Unione contano spesso solo quando riescono a coalizzarsi, temono la marginalizzazione: non la guerra, ma l’irrilevanza.
Il paradosso è che l’Europa ha già sperimentato un’egemonia tedesca — non con i carri armati, ma con le regole. Durante la crisi del debito, Berlino fu il “tesoriere severo” dell’eurozona: impose condizioni, austerità, ortodossie, e lasciò cicatrici politiche che ancora bruciano. Quel ricordo non riguarda il passato remoto: è un precedente psicologico. Quando la potenza tedesca aumenta, molti europei non si chiedono solo “ci difenderà?”, ma anche “a quale prezzo?”. La fiducia, in politica, non è una moneta astratta: si stampa con atti concreti, e si svaluta con una sola stagione di umiliazioni.
C’è poi un rischio più sottile: la competizione intraeuropea. Una Germania che investe a ritmi superiori può spingere altri a controbilanciare. Non necessariamente con ostilità, ma con un gioco di posizionamento: alleanze regionali, formati paralleli, “coalizioni dei volenterosi” che diventano, lentamente, alternative. È il momento in cui la difesa comune si frantuma in difese concorrenti. E una volta che la deterrenza dipende da architetture diverse, la Russia non deve vincere militarmente: le basta testare le crepe.
Il nodo industriale rende tutto più delicato. Se Berlino concentra la spesa sulle proprie aziende, se usa le scappatoie per proteggere il mercato nazionale e rifiuta una regia davvero europea degli appalti, la crescita della potenza militare tedesca diventa anche crescita della rendita tedesca. E allora il riarmo, anziché essere un progetto comune, appare come un moltiplicatore di asimmetrie. L’Europa, che avrebbe bisogno di una “Airbus della difesa” — consorzi, standard comuni, interoperabilità reale — rischia di trovarsi con ventisette industrie che competono e una che primeggia. È il modo più rapido per trasformare la necessità strategica in risentimento politico.
E poi c’è la politica interna tedesca, la variabile che nessuno ama nominare ma che tutti, in privato, calcolano. Se un giorno a Berlino prevalesse un nazionalismo duro — l’idea che l’esercito serva solo gli interessi tedeschi, che l’Unione sia un vincolo da allentare, che la NATO sia un contratto da rinegoziare — la potenza accumulata cambierebbe segno. Non perché le democrazie si trasformino in un attimo, ma perché il potere, una volta costruito, è come un’infrastruttura: può essere usata da governi diversi, con visioni opposte. Chi oggi applaude la crescita della Bundeswehr per contenere Mosca, domani potrebbe ritrovarsi a temere una Germania che “contiene” anche i vicini.
La domanda, allora, non è se la Germania debba riar mare. Deve. La domanda è come farlo senza destabilizzare l’Europa. E la risposta, se vogliamo evitarci nuove illusioni, è antica e poco romantica: legare la potenza a vincoli. Non vincoli morali — quelli cambiano con i governi — ma vincoli istituzionali e materiali. Una Germania davvero europea non è quella che proclama solidarietà: è quella che rende costosa e difficile la tentazione di agire da sola.
Qui entra in gioco l’idea delle “manette d’oro”: più integrazione come assicurazione politica. Significa, anzitutto, soldi messi in comune dove serve: strumenti finanziari europei per la difesa che permettano agli altri Stati di investire senza devastare welfare e coesione sociale. Perché un’Europa che finanzia i cannoni tagliando le pensioni è un’Europa che consegna voti ai populismi, e i populismi — di destra o di sinistra — sono il solvente dell’unità ucraina e della deterrenza antirussa.
Significa, poi, industria davvero integrata: progetti condivisi, catene di fornitura europee, appalti pensati come architettura continentale e non come politica industriale nazionale mascherata. Infine, significa comando e strutture comuni: formazioni multinazionali credibili, pianificazione europea, interoperabilità che non sia un manuale ma un’abitudine. Non serve immaginare domani un “esercito europeo” nel senso classico; basta costruire, oggi, un sistema in cui nessuno — nemmeno la Germania — possa muovere da solo l’intero peso della difesa.
C’è un’ultima ironia: questa strada conviene alla Germania stessa. Perché l’egemonia, in Europa, è un affare logorante. Ti chiedono di guidare e poi ti accusano di comandare. Ti invocano quando manchi e ti temono quando arrivi. L’unico modo per rendere sostenibile il ruolo tedesco è farlo diventare meno “tedesco” e più “europeo”: non come slogan, ma come meccanismo.
L’Europa ha imparato a cooperare per ottant’anni perché qualcuno — gli Stati Uniti — rendeva troppo costosa la rivalità. Se quel “qualcuno” si sfila, gli europei devono decidere se sostituirlo con istituzioni oppure con diffidenze. Il riarmo tedesco può essere la colonna vertebrale della sicurezza comune o il detonatore di una nuova frammentazione. Dipenderà da una scelta che sembra tecnica — appalti, debito, comandi — ma che è profondamente politica: accettare che la potenza, per restare benedizione, deve essere condivisa prima ancora di essere esercitata.