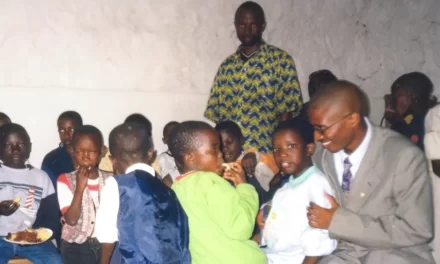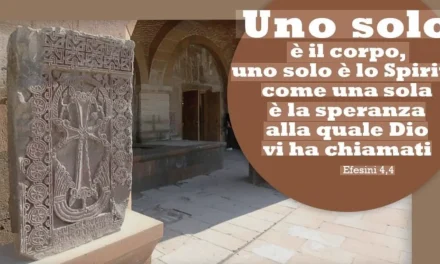Nel Verano il Papa ricorda che il lutto cristiano non è retorica del ricordo, ma esercizio di speranza e carità concreta.
C’è un tono pacato, quasi domestico, nell’omelia che Leone XIV ha pronunciato al Verano nella Commemorazione dei fedeli defunti. Non il linguaggio solenne di chi parla della morte come di un concetto astratto, ma quello di chi ha visto piangere famiglie vere, accompagnato anziani soli, ascoltato ferite che non cicatrizzano. Il Papa non ha negato la malinconia che abita i cimiteri; l’ha abitata con cura. «I profumi delle nostre case», «le immagini», i luoghi che ricordano i nostri cari — non sono semplice nostalgia. Sono la soglia di qualcos’altro: memoria che diventa attesa.
La sua intuizione è chiarissima: il cristiano non ricorda per trattenere, ma per prepararsi. Non si limita a contemplare ciò che fu, ma si esercita a guardare ciò che viene. La morte, che appare come un muro, si trasfigura come passaggio: non un epilogo malinconico, ma una porta che si apre sulla promessa di Dio. E qui il Papa ha colto il cuore della fede pasquale: senza la risurrezione, il lutto diventa solo esercizio di rimpianto; con la risurrezione, diventa pazienza piena di senso.
Ma c’è un punto che vale sottolineare, e che Leone XIV ha nascosto in poche parole: la speranza non è un sentimento privato; è una forma di vita. Non basta “pensare” al cielo — bisogna cominciarlo. Così le parole del Vangelo sugli affamati, gli assetati, gli stranieri, i malati e i carcerati entrano, con discrezione e forza, nella liturgia dei morti. Non come nota di moralismo, ma come logica evangelica: la carità vince la morte.
È qui il messaggio politico e sociale dell’omelia, espresso senza slogan e senza polemica: non possiamo pregare per rivedere i nostri cari e poi voltare lo sguardo ai poveri come se non ci appartenessero. Non possiamo invocare il Cielo mentre costruendo muri sulla terra. Il giudizio finale, ricorda Gesù, non passa per le idee, ma per i gesti. E in un tempo in cui il dibattito pubblico sembra vivere di paure e contrapposizioni — stranieri contro cittadini, giovani contro anziani, sani contro fragili — quelle parole del Vangelo diventano un invito severo: il vero culto dei morti nasce dall’amore per i vivi.
I cimiteri raccontano che nessuno si salva da solo. Le lapidi, allineate e umili, sono una teologia muta della comunione: davanti alla morte, cadono i ruoli, le carriere, le appartenenze. Resta ciò che si è amato. Ed è proprio da questa radicale uguaglianza che rinasce la Chiesa dei vivi: una Chiesa chiamata a non ridurre la fede a memoria, ma a soglia di futuro.
In fondo, come diceva Newman — e la scelta di ricordarlo oggi non è neutra — “il cristiano è colui che sa che la vita è un pellegrinaggio verso casa”. Leone XIV l’ha ripetuto con parole d’albore: chi ha camminato nell’amore ritroverà i suoi cari, non perché il tempo lo restituisce, ma perché Dio lo promette.
Uscendo dal Verano, la domanda rimane: vogliamo vivere come gente che spera davvero? O come naufraghi della memoria? La differenza non è emotiva, è evangelica. Chi ama, costruisce il futuro. E ogni gesto di misericordia, fatto oggi, diventa già un pezzo di eternità.
Perché — lo ha detto il Papa, ma potremmo quasi sentirlo sussurrato da ogni pietra del cimitero — la carità è il ponte su cui i vivi raggiungeranno di nuovo i loro morti. E questa è la teologia più semplice e più vera.