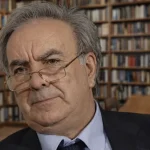Per decenni è sembrata una certezza granitica: il Partito Repubblicano come baluardo politico, morale e persino teologico dello Stato di Israele. Una fedeltà che attraversava governi, crisi mediorientali, cambi di leadership e guerre lontane, sostenuta da un’alleanza tanto solida quanto singolare: quella tra l’establishment della politica estera conservatrice e il mondo evangelico americano. Oggi, però, quella certezza mostra crepe profonde. E non sono solo crepe politiche, ma culturali, generazionali e teologiche.
Quando gli storici guarderanno al secondo mandato di Donald Trump, potrebbero identificarlo come il momento di massimo sostegno americano a Israele — e allo stesso tempo come l’inizio del suo logoramento interno. Mai come sotto Trump Washington ha garantito a Tel Aviv libertà d’azione militare, copertura diplomatica e sostegno simbolico. Eppure, mentre la Casa Bianca rafforzava l’asse con Netanyahu, nel corpo profondo del Partito Repubblicano qualcosa iniziava a mutare.
La guerra dentro la destra
Il cambiamento non riguarda la vecchia guardia repubblicana, ancora largamente pro-Israele, ma una nuova composizione dell’elettorato conservatore: più giovane, meno bianca, meno legata alle chiese evangeliche tradizionali, spesso proveniente da esperienze politiche fluide e radicalizzate online. In questo segmento, il sostegno a Israele non è più un dogma. Anzi, è spesso oggetto di sospetto, rifiuto o risentimento.
Il problema, però, non è solo la critica politica. È il linguaggio che la accompagna. Nazionalismo identitario, nativismo, cristianesimo politico e un ritorno di antichi stereotipi antiebraici si intrecciano in un magma ideologico che rende sempre più difficile distinguere tra isolazionismo strategico e antisemitismo vero e proprio. La destra americana non sta semplicemente discutendo Israele: sta discutendo sé stessa.
Le fratture sono emerse in modo clamoroso nei media conservatori. Da una parte, figure storicamente pro-Israele; dall’altra, voci influenti che parlano apertamente di “sionismo cristiano” come di una deviazione teologica, o addirittura di una patologia culturale. Ne è nata una sorta di guerra civile ideologica, combattuta a colpi di podcast, conferenze e campagne social, dove il confine tra dissenso e demonizzazione diventa sempre più sottile.
Quando la teologia cambia la geopolitica
Per comprendere la portata del fenomeno occorre guardare oltre la politica e entrare nel terreno, più profondo, della teologia. L’alleanza tra Repubblicani e Israele non è nata solo da calcoli strategici, ma da una visione religiosa della storia. Per milioni di evangelici, il ritorno del popolo ebraico nella sua terra e la nascita dello Stato di Israele rappresentavano un segno provvidenziale, un tassello essenziale nel disegno escatologico della fine dei tempi.
Questa lettura — che ha plasmato generazioni di elettori e predicatori — oggi è in declino. Nuove correnti cristiane, spesso più politiche che spirituali, rifiutano quell’interpretazione e guardano a Israele non come a un segno divino, ma come a uno Stato qualsiasi, giudicato sulla base dell’interesse nazionale americano o, peggio, di antiche categorie teologiche di sostituzione. In questo quadro, l’ebraismo non è più “alleato escatologico”, ma una realtà da assorbire, correggere o superare.
Non è un ritorno innocuo al passato. È il riemergere di una teologia che la storia europea conosce bene, e che ha spesso preparato il terreno alla persecuzione prima ancora che alla discriminazione.
La generazione di Gaza
A rendere irreversibile il cambiamento contribuisce un fattore decisivo: l’esperienza generazionale. I giovani conservatori americani non sono cresciuti con la memoria viva dell’Olocausto né con l’entusiasmo biblico degli anni Ottanta. Sono cresciuti tra Iraq, Afghanistan, crisi economiche, social media e immagini incessanti di Gaza. Per loro, Israele non è il simbolo della rinascita di un popolo perseguitato, ma uno degli attori di un conflitto percepito come distante e costoso.
In questo contesto, il sostegno militare ed economico a Israele viene letto come un lusso che l’America non può più permettersi, mentre il disagio interno — costo della vita, immigrazione, declino sociale — reclama attenzione. È una visione che attraversa ideologie diverse e che produce un paradosso: critiche simili a Israele emergono oggi sia a destra sia a sinistra, pur partendo da presupposti opposti.
Un futuro incerto
Donald Trump, per ora, resta saldo nel suo sostegno a Israele. Ma il trumpismo senza Trump è un terreno instabile. La domanda non è se l’alleanza storica tra Repubblicani e Israele finirà, ma in che forma sopravvivrà. Sarà ancora una scelta strategica condivisa o diventerà una linea di frattura permanente? I nazionalisti cristiani imporranno la loro visione? L’antisemitismo verrà espulso o normalizzato?
In gioco non c’è solo la politica estera americana, ma l’identità stessa della destra occidentale. Perché quando un’alleanza fondata su fede, potere e storia inizia a sgretolarsi, non è mai un semplice aggiustamento tattico: è un cambio d’epoca. E spesso, ce ne accorgiamo solo quando è già troppo tardi.