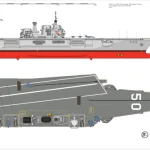Sono cresciuti con una promessa dimezzata. Prima gli si è detto che avrebbero vissuto meglio, poi che dovevano “resistere”: lockdown in piena età dell’uscita, lauree via webcam, tirocini che non fanno curricolo e affitti che mangiano lo stipendio. Quando la porta finalmente si è riaperta, fuori non c’era l’avventura: c’era il listino prezzi. Non stupisce che una parte dei ventenni abbia scelto la scorciatoia più rumorosa della politica: la ribellione, ma verso destra. Talvolta fino all’estrema. Non un capriccio: un segnale.
La scena è sempre la stessa, da Madrid a Milano, da Barcellona a Bologna. Si comincia con la casa – primo confine dell’età adulta – e si finisce schiacciati tra l’algoritmo e il bancomat. La politica, intanto, parla con voce sgranata: bonus a pioggia, promesse in diretta, identità sventolate come scudi. I ragazzi chiedono chiavi, non hashtag. Quando non arrivano, si rivolgono a chi offre frasi corte e colpevoli chiari. Funziona: l’ansia si placa per un giorno, la realtà no.
Non riduciamo tutto a sociologia spicciola. C’è anche fame di ordine, di riconoscimento, di un lessico che non derida i percorsi “classici” – studiare, lavorare, mettere su casa, magari una famiglia – senza per questo disprezzare chi cerca strade diverse. Dove questi desideri non trovano cittadinanza, cresce chi promette sbarre e muri. È la politica dell’immediatezza: meno sfumature, più verbi all’indicativo. Ma la vita, per loro come per noi, resta nel congiuntivo: seavessi un affitto umano, se ci fosse un contratto degno, se potessi fermarmi in un quartiere senza temere di essere ospite provvisorio.
Da cristiani, non possiamo cavarcela con il mantra “è colpa dei social”. È troppo comodo. Gli algoritmi amplificano, non inventano. La Dottrina sociale della Chiesa ci chiede altro: guardare al bene comune come misura concreta, non come parola bella. Significa tre movimenti, semplici da dire, duri da fare.
Primo: mettere la dignità prima dell’identità. La persona viene prima della bandiera, anche quando la bandiera rassicura. Le paure hanno cittadinanza, i capri espiatori no. Il confine tra sicurezza e accoglienza non passa tra “buoni e cattivi”, ma tra legalità che protegge e indifferenza che abbandona. E la legalità, per essere credibile, dev’essere rapida, equa, non scenografica.
Secondo: tornare alla rappresentanza come ascolto efficace. Non bastano i “sentiamo i giovani” di circostanza. Servono luoghi dove la loro voce pesi: consigli comunali che aprano il bilancio, università che non si limitino a tirocini non pagati, imprese che investano davvero in apprendistato. Radicale nei fini – casa, lavoro, cura del territorio – inclusiva nei mezzi: questa è politica adulta.
Terzo: passare dalle opinioni alle opere. Qui finiscono gli elzeviri e cominciano i cantieri. Case a canone sostenibile con patti lunghi e garanzie serie; trasporto che funzioni dove la gente vive, non solo dove si fotografa bene; canali regolari di immigrazione nei settori scoperti, insieme a integrazione esigente e ad espulsioni effettive per chi delinque; formazione tecnica non di serie B; un servizio civile davvero universale, pagato con dignità, che rimetta in contatto generazioni e territori. Sono parole poco romantiche, ma sono quelle che riaccendono la speranza.
C’è poi una responsabilità che non possiamo delegare alla politica: le comunità. Parrocchie, oratori, associazioni sono uno degli ultimi laboratori dove l’altro non è “avatar” ma volto; dove l’italiano di seconda generazione e il nonno del quartiere si ritrovano sullo stesso campo sportivo o allo stesso doposcuola. È lì che si impara la grammatica del noi: esercizio lento, contro la fretta polemica; antidoto naturale al “prima i miei” che risolve poco e divide molto.
Qualcuno dirà: siete ingenui, il vento tira altrove. Può darsi. Ma i venti cambiano quando cambiano i porti. Se un ventenne trova una casa abitabile senza ipotecare la vita, un lavoro che non sia un quiz a termine, un quartiere dove la convivenza è più di una parola, la propaganda perde volume. E la rabbia – anche quella “di destra” – si scopre per ciò che è: un dolore che cerca forma.
Un’ultima cosa. Evitiamo il tono da predica: è la trappola perfetta. I giovani fiutano subito il paternalismo. Non chiedono applausi né scomuniche: chiedono adulti affidabili. La Chiesa, quando è fedele al Vangelo, questa affidabilità ce l’ha: non nasconde le ferite, non semplifica il male, non si rassegna alla rissa. Tiene insieme libertà e responsabilità, misericordia e verità. È una postura scomoda, quindi necessaria.
Resterà chi guarderà ai vent’anni come a una moda politica. Sbaglia. Qui non c’è una moda: c’è una generazione che, dopo anni di attese, pretende sostanza. Se la politica gliela nega, cercherà scorciatoie. Se la comunità civile arretra, riempiranno il vuoto i professionisti dell’ira. Ma se metteremo in fila opere giuste – poche, visibili, mantenute – vedremo la cosa più semplice e più difficile: la fiducia tornare. E, con lei, la possibilità di pensarci finalmente insieme.